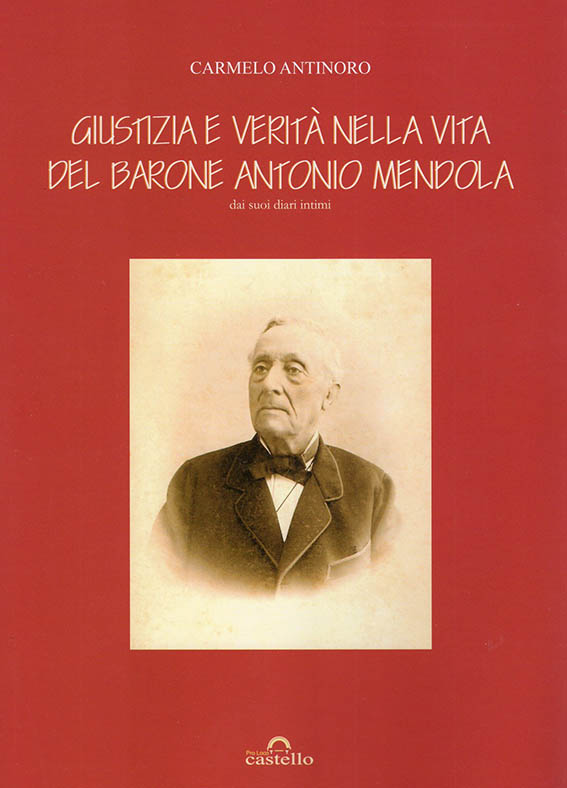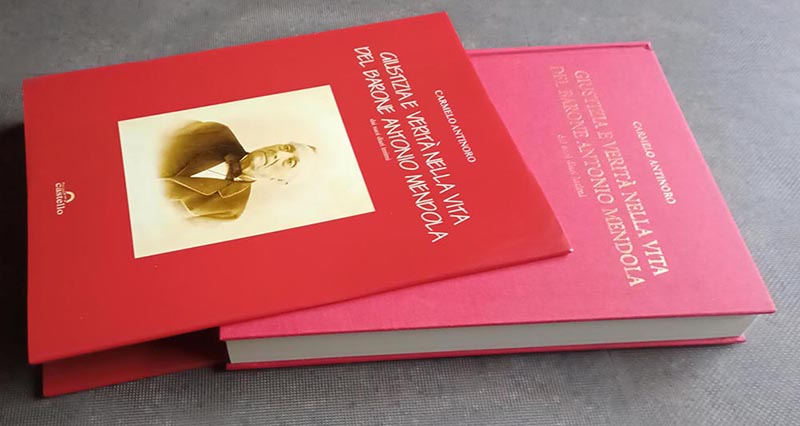|
GOCCE DI RIFLESSIONI
TRATTE DAI DIARI INTIMI DEL BARONE ANTONIO
MENDOLA
Il nuovo
anno, rimembranze e delusioni
(1 gennaio 1897)
Ogni
anno i giorni solenni sono amari per me. Sono proprio sconfortato, sento
di essere nel nulla, inetto ad operare. Mi ero creato una piccola
atmosfera nella quale vivevo di speranze e di illusioni, bastando a me
stesso. Questa piccola volta di cielo artificiale, questa piccola
atmosfera è crollata e andata via. Che cosa fare in questo paese? Sono
rimasto isolatissimo, ozioso, desolato. Ho visto svanire ogni
castelluccio creato dalla mia fantasia e dal desiderio del bene. Potrò
così più vivere in Favara? Sono un pesce fuori dall’acqua, sono un
paralizzato. Penso di abbandonare questo ostile soggiorno e guarirmi
dalla paralisi, trasferendomi in qualche città, dove sentimenti umani e
conforti ed esempi di vita si possono trovare. Povero Popularis
Sapientiae Loculus, nascesti morto, non fosti cosa, ma aborto. I
favaresi ti hanno barbaramente annichilito. Povere opere di beneficenza,
orfanotrofio, asilo d’invalidi al lavoro, ospedale, asilo infantile,
siete rimasti pii desideri nel petto mio, siete ombre, vaneggiamenti. Mi
sento venir meno. Non so più andare avanti, mi manca la forza, vado
strisciando come un rettile, come un uccello a cui furono strappate le
penne dalle ali e dalla coda. L’anno 1897 comincia per me con cattivi
auspici. Ho mangiato male, ho dormito peggio. Un fortissimo raffreddore
mi toglie appetito e forza. Aspettavo per il capo d’anno mia figlia e
mio genero, non l’ha voluto far venire. Pochissimi mi hanno fatto gli
auguri del capodanno, Domenico Sajeva di Giovanni è venuto ieri sera di
soppiatto, quasi è sdegnoso degli aiuti che io accordo a suo padre per
mantenere lui allo studio. Stamattina sono venuti De Vecchi, Calogero
Chiodo, il dr. Antonio Mulè e suo figlio Raffaele mio figlioccio, anche
costui scade negli studi; fu bocciato agli esami di luglio e di ottobre.
Ha preso già il vizio delle donne; è impertinente e collerico con i
genitori. Che gioventù! Dopo pranzo sono venuti Giacomo La Russa con le
sue due figlie, la grandicella che studia il corso normale femminile e
la piccina Carmelina e poi mio fratello con le mie nipotine Graziella e
Peppinella. Mia figlioccia Checchina Scaduto mi ha fatto un bel regalo.
In tanta desolazione ho avuto questi cari conforti dalla famiglia, meno
male. Ho mandato due grappoli di uva fresca dalle mie pergole al dr.
Libertino Fanara, mio medico, con un servizio da caffé, per due, in
porcellana Ginori che comprai a Napoli per lire 50. Con l’imballaggio e
spedizione mi costò lire 60. Alle 11 è venuto il dottore a ringraziarmi.
Ci siamo ringraziati a vicenda. Ma io sono così disdegnato dell’ambiente
e pentito di aver fatto il loculus da non pigliare ora nessuna
soluzione. È finita l’idea di giovare al pubblico perché non c’è
pubblico che se ne giovi. Mi resta da vedere se nel mio individuale
piacere convenga o no ampliare il museo, già molto avanti in fatto di
uccelli.
(1 febbraio 1897)
Il mio povero cuore, tutti immerso nel
lutto e cordoglio da 16 anni sente tuttavia il bisogno di sfogarsi, di
espandersi e recare qualche conforto e lenimento nell’animo di coloro
che sono stati colpiti dalla medesima sciagura. Non so se faccio bene o
male e se tradisco le mie intenzioni, in tutti i casi mi compatiscano.
Io comprendo appieno ed a prova tutto il dolore e del caso amarissimo
dell’immatura perdita del loro figlio Giuseppino. Che somiglianza e
coincidenza!. Anch’io ho perduto un figlio Giuseppino a 19 anni, il 19
febbraio 1879. Era buono, saggio, bello. Dagli 8 a 13 anni fu messo
nelle grandi preparazioni di Hoffwesl? presso Berna e già a quell’età
parlava il tedesco, l’inglese, il francese, lo spagnolo. Da 14 a 15 anni
imparò benissimo il greco e latino, iniziandosi nelle lingue orientali.
Era pianista e disegnatore. Senza nessuno dei vizi che dirupano la
maggior parte dell’odierna gioventù. Era passato a Stuttgart, capitale
del Wuttemberg a fare il corso di scienze naturali. Non era stato mai
ammalato. Era robusto quando fu colpito da una terribile polmonite che
in soli 4 giorni lo spedì al sepolcro. Con lui perdetti tutto, la
famiglia già estinta, la consolazione della vecchiaia. Sono rimasto
solissimo. Ho cercato di sostituire l’eredità degli affetti con le
orfanelle. Ho trovato calma e conforto nella rassegnazione in Dio e nel
tempo; a loro la fede e il tempo. Penso che in un lontano avvenire mi
riunirò alle mie amate creature, nel cielo, dove la morte è sbiadita per
sempre e dove sono perpetui i gaudi delle anime riunite in quella eterna
carità che riassume e concentra la famiglia, l’umanità e l’universalità
di tutti gli esseri angelici in una cosa sola. In questa valle di
lacrime piango e prego sulla tomba del mio figliolo.
Disordini studenteschi e progressi della modernità
(6
febbraio 1897)
Tutti i giornali sono pieni del racconto dei disordini commessi dagli
studenti. Le università, i ginnasi, i licei, gli istituti professionali
tecnici, tutti sono divenuti convegni e strumenti di ribellione e
iniquità. I giovani invece di cibarsi di sapienza e di educarsi alla
bontà, sono divenuti l’opposto di ciò che dovrebbero essere o almeno
mostrarsi. Sintomo bruttissimo è questo. Il corpo sociale è pieno di
cancrena nei suoi organi primi, nelle sue cellule. Crescendo sentirà i
dolori e proverà i guai della distruzione. I padri di famiglia (eccetto
pochi patrizi e pochi prediletti) si sobbarcano a stenti e sacrifici per
fare istruire ed educare i figli. Essi non hanno scelta di educatori e
di maestri. La libera Italia obbliga, livellando le cose, manomettendo
ogni libertà di mandare i figli solo nelle scuole dello Stato
elementari, tecniche, ginnasi, licei, università. L’Italia libera e
moralizzata tiene un esercito di maestri e di professori modelli di
dottrina, cultura ed educazione. Eccetto pochi dotti e pochi buoni, la
massa degli insegnanti pubblici può assomigliarsi ad una legione uscita
dall’inferno. Nelle scuole s’insegna e s’impara l’ateismo, il
socialismo, il malcostume. Non c’è morale, né etica, né famiglia. Che
razza di cittadini si vanno plasmando in Italia? Si semina vento e si
raccoglierà tempesta. Ieri l’altro nella minuscola Girgenti, la
scolaresca si abbandonò a disordini insoliti, con frasi della
solidarietà, della incolumità dall’aula della scienza e con altri simili
roboanti vocaboli. Tra gli altri si distinse negli eccessi facinorosi
Domenico Sajeva, il figlio di Giovanni, il soccorso da me. Io mi pento
di averlo aiutato, sospendo ogni sussidio, è nullo d’ingegno ed ora
invece di supplire con gli studi e con la buona condotta, pieno
d’orgoglio fa il gradasso e il capo rivoluzionario. Perché gli studenti
fanno queste baldorie?, cosa c’è in fondo di veramente grave?, nulla,
prendono pretesti per commettere disordini delle più piccole cose. Io
credo che ci debba essere l’azione e l’oro straniero per sobillarli, per
spingere questo infelice popolo a simili eccessi che minano la società e
degradano il governo. Vedremo il seguito. In questi giorni rileggevo il
libro di Tobia. Com’è bello e soave! Oh gli insegnamenti, i consigli di
Tobia dati al figliolo Tobiolo, come sono edificanti, come scendono al
cuore, come tendono a formare l’uomo saggio, istruito, accetto a Dio,
utile alla famiglia ed alla nazione. I moderni invece spacciano altre
massime, altri principi, del tutto opposti. Ecco i progressi della
modernità! Io desidero che si ritorni all’antico.
(13
marzo 1897)
Il
cielo, benché sgombero di nuvole, è bianchiccio, non ride del bel
ceruleo di primavera. L’aria è fresca e umida. Verso le 9 l’aria di
scirocco ha reso tiepida e bella la giornata sino a sera. Una grande
melanconia mi invade. Sento tutto il peso e la desolazione della
solitudine. Il mio cuore è nero, abbattuto. Si avvicina l’onomastico del
padre mio e del mio diletto figlio. Quale dolore, quale mestizia mi
avvolge. Non posso dirlo. Provo un non so che da non potersi significare
a parole, una specie di nullismo o di annichilimento interno e morale.
Tutto agli occhi miei è vestito e colorato di grigio. Una noia
insopportabile mi travaglia. Non ho conforto, non ho a chi raccontare i
miei guai interni. Oh il vecchio e solo! Quanto è infelice! Nessuno lo
crede, è degno di compassione, ma nessuno lo può capire e può
accordargliela per conforto. Stasera la solita fiaccolata o fanari e un
aerostato. Ho guardato quasi senza percepire il senso, senza ridestare
quella certa reminiscenza di brio, di giovanilità, senza partecipare al
magnetismo, al contagio psichico della festa. Sono un vero decadente che
sta per toccare l’ultimo limite della parabola della vita e tutto si
affievolisce, l’organismo, i sensi, la mente, si inaridisce il cuore.
Sono
nato sotto una mala stella, amarissimo è il mio destino
(15
aprile 1897)
Mi
sveglio, mi alzo dal letto, moralmente abbattuto. Il dover convivere con
la signorina Elena che vede in me un nemico ed interpreta male ogni mia
risoluzione dell’amministrazione della casa, produce effetti dolorosi.
Gli eccessi di grida forsennate ed isteriche di ieri sera mi hanno
annichilito. Oggi non ho potuto mangiare. Sono prostrato. Ho detto a me
stesso che forse sono io il cattivo, il birbaccione e non me ne accorgo.
Suor Orsola mi sfugge, la signorina Elena mi detesta. Ci deve essere una
ragione. Il solo dubbio della mia cattiveria senza che io me ne accorgo,
è una spina che mi punge, mi dilania il cuore. Non sono degno della
convivenza umana e delle gioie domestiche. Sono un mostro, è giusto che
pianga la mia tristezza e non tormenti gli altri. La signorina Elena ha
dichiarato volersene andare, vada pure. Rimango deserto e sconsolato, ma
libero dalle morali sofferenze. Sono nato sotto una mala stella,
amarissimo è il mio destino. Non debbo avere pace e compagnia sempre, la
discordia, il travaglio dei contrasti, il dolore, la disperazione,
l’inferno in casa mia. Sono oramai prostrato!, davvero prostrato. Con la
fibra dell’età giovane potevo e sapevo resistere, adesso, vecchio e
debole, mi sfrontano, divengo inebetito. Stasera la signorina Elena dice
di essere presa dall’emicrania. È andata a letto senza cena. Non l’ho
vista. Come entrare nella sua stanza per confortarla, quando ho, se non
la certezza, almeno il dubbio, di contrastarla maggiormente con la mia
visita? Oh vita amarissima che è e che è stata la mia. Inferno con la
mia moglie dal 1850 fino al 1872, inferno con Angelina Indelicato dal
1873 al 1890, inferno con la signorina Elena dal 1891 al 1897, aggiungo
1898 ed oltre. E chissà che diamine ancora di peggio si apparecchia per
me.
(13
giugno 1897) Oggi si festeggia S. Antonio da Padova patrono del
paese e mio santo onomastico. Le orfanelle apparecchiano una
festicciola. Per me sono cose dispiacevoli, nel senso di vedermi
tributate lodi che non merito quasi in pubblico. Non vi è maggiore
tormento morale di questo santo, una specie di ribellione interna, uno
sconvolgimento, una riluttanza istintiva. Non mi sono mai ricordato del
mio onomastico. Non sono stato mai abituato a vedermi recitare auguri,
per significare infine come un altro anno si è sfogliato dal listino
della mia vita. Queste novità sono venute per me con le bocconiste. Ho
dichiarato però alla superiora che questa sarà l’ultima volta e che
nell’avvenire debbo essere lasciato in pace. Oggi mi preparo a soffrire
un poco nel mio amor proprio.
La villa Piana, il peso e l’amarezza della mia solitudine.
(21
giugno 1897)
A
sera, ridottomi nella mia stanzuccia, alla villa Piana, sento il peso e
l’amarezza della mia solitudine. Il silenzio della campagna, l’abbaiare
dei cani e lo stormire delle foglie mi fanno un maggior vuoto
nell’anima. Parmi di essere in una tomba. L’anno scorso venni in villa
Piana il 13 luglio. Quest’anno ho anticipato di poco più che 20 giorni.
Per un lungo corso di circa 18 anni mi trasportavo in villa all’entrare
dell’aprile. Tra la fragranza dei fiori e il rinverdire degli alberi, il
cuore, benché fulminato da gravi sciagure e da dolori morali, si apriva
ad una certa soddisfazione di piacere, non voglio chiamarla letizia, ma
ora, entrato nella vecchiaia, tutto è mutato in me, non vi è più un
baleno di gioia, mancano i profumi della zagara e delle viole, mancano i
gorgheggi degli uccelli, non si vedono le loro belle penne dispiegarsi
al sole. Tanti graziosi navigatori dell’aria che festeggiavano la natura
rinascente, negli anni della mia giovinezza e alle primavere della mia
villeggiatura, adesso scarseggiano. Il cielo è sprovvisto di questi
giorni dei suoi volatili, la terra dei suoi fiori e della sua frutta. La
stessa cresce di cereali e legumi, si stacca dai campi e tutti restano
nudi e arsicci e per compiere la tinta grigia del quadro, le nuvole
guastano il dolce zaffiro della volta celeste e danno tuoni e minacce di
pioggia o tempeste. Anche l’anno scorso il fresco, le nubi, i tuoni
accompagnarono il mio arrivo in villa. È un periodo di povertà e di
stanchezza per la campagna. Meno male che dura pochi giorni, Fra poco
abbonderanno le albicocche, le pere primaticce, le zizzole o pere di S.
Giovanni, le pesche, i bifari e poi seguiranno tutte le pompe del
cornucopia fino alla vendemmia.
I miei vecchi amici sono già usciti da questo misero mondo
(7 agosto 1897)
Ho
ricevuto la posta con l’anima desolata. Da un pezzo non mi arrivano
lettere, né me ne aspetto. I miei vecchi amici sono già usciti da questo
misero mondo. Essi mi confortavano. Il loro carteggio era la mia quasi
unica consolazione. Io vivevo da solitario in Favara, dove i parenti e
gli amici sono nomi e non veri affetti. Prima mi consolavano i lontani.
Si è fatto il vero deserto attorno a me. Credevo nel Marino Teodorico di
trovare un consultore, mi sono ingannato. Sono rimasto solissimo.
Teodorico Marino è un furfantello senza cuore. Quel fascio di stampe e
di giornali datimi oggi dalla posta, al solo vederlo mi ha destato la
sensazione di vedere e toccare una cosa morta, un cadavere. Oh la
solitudine, l’isolamento, l’orribile tortura e per la povera anima mia
che sente! La posta nella sua muta comparsa nei tempi trascorsi, alle
volte non solamente mi piaceva, ma mi inebriava al solo scorgere i
caratteri di amici cari e intimi. La posta era per me un commercio di
sentimento, di pensiero, di scienza, ora è divenuta una comparsa di
mestizia. Mi fa lo stesso effetto che provo quando sbarco dai piroscafi
in qualche posto; resto solo, sconosciuto, non aspetto, non vedo un viso
amico, una persona che mi conosce, che mi ami, che venga ad incontrarmi.
Resto solo, sempre solo! E vedo centinaia di barchette piene zeppe di
signori, signorine, fanciulle, bambini lieti, soddisfatti che
gesticolano, salutano, agitano, svolazzano i fazzoletti, ognuno in cerca
dei suoi amici e parenti e dico tra me e me: “felici coloro che
s’intendono, godono, versano reciprocamente nei loro cuori le oneste
allegrezze, gli affetti dolcissimi che costituiscono la vita vera degli
uomini. Io non conto più, sono un atomo separato dagli altri atomi e
sono quindi assimilato al nulla. Ma mi rassegno e soffro e cerco di
superare questa barriera di desolazione, facendo coraggio a me steso e
volgendo i pensieri miei a ben altri fini. Dunque, la posta consolatrice
è divenuta oggi per me una sorta di oppressione morale. Mi devo abituare
a quest’altro tormento e bere intero il calice delle amarezze e dei mali
che sogliono accompagnare la vecchiaia. Io solevo provare qualche
sollievo nello spirito, spendendo qualche parola, celiando, ascoltando
qualche stranezza dalle persone di casa, dei domestici, coi quali
convivo. Da quando la signorina Elena fu presa dalla mania di credere
suoi nemici tutti quelli che convivono in casa, non si parla più. Questo
piccolo refrigerio è venuto pure meno. Speriamo che cessi presto questo
stato di cose. Mi resterà quest’ultimo e meschino conforto di spassarmi
con le asinerie e con le grossolanità che scappano dalla bocca degli
incolti popolani. Solo i miei cagnolini rimangono sempre fermi al loro
posto, non cambiano condotta, non rinnegano, sentono affetto per me, me
lo mostrano tutti i giorni. Sia benedetto il Signore che ci ha dato
questi animalucci per compagni e per fedeli custodi. Davvero i cani si
conoscono e si apprezzano meglio quando si misura tutta la gratitudine e
la malvagità degli uomini. Moretto non dimentica mai le mie carezze e il
bocconcino e l’ossicino che io gli do da mangiare. Gli uomini e le donne
ripagano i benefici che ho loro elargito con la più nera perfidia, o,
per lo meno con la trascuratezza. Nessuno si ricorda di me. Le stesse
orfanelle, che bimbe innocenti e bisognose, per ora mi amano e mi
consolano, forse forse quando saranno cresciute e andate fuori
dall’orfanotrofio non solo si scorderanno di me, ma mi daranno qualche
manta di dispiacere in contraccambio dell’amore e della carità che ho
usato loro.
(27
marzo 1899) Tutto è verde. La terra ripiglia la pompa del suo lusso,
ripiglia la sua periodica giovinezza. La distesa dei campi coltivati a
cereali o legumi e i prati naturali o artificiali presentano una veste
con dolcissime gradazioni di verde, dal cupo allo smeraldo, dal
gialliccio pallido al verdino tenero. I mandorli sono nello sfarzo,
nell’orgoglio della vegetazione e del colore. I fichi già cominciano a
nascondere i loro neri rami tra le verdeggianti foglioline. Tutto ride.
La natura si ridesta, si apre all’amore, agli incanti, ai tripudi. I
fiori sono già preparati e stanno per venir fuori variopinti, con tutta
la tavolozza delle tinte somiglianti più che Tiziano e Rubens.
L’infanzia della vegetazione si accosta assai da vicino alla giovinezza.
Che vista stupenda! Chi guarda la terra in questi giorni non può fare a
meno di innalzare un inno al creatore, inno di lode e di gratitudine. La
presenza e la grandezza di Dio si rivela in tutto e sempre. Un pensatore
vede Dio dappertutto, ma le masse popolari ed anche gli umani colti in
questa stagione, colpiti dallo spettacolo vivo e rigurgitante di
bellezza che offre la terra, sentono maggiormente la mano del signore e
s’inebriano e si sollevano quasi ai cieli. Io solo sono triste e rimango
come ebete in tanta magnificenza, in tanta gala, in tanta esuberanza di
vitalità, perché la vitalità si estingue e l’infanzia, la giovinezza e
la virilità spariti non possono più tornare.
Si
affaccia il sole e mi trova desolato, non mi scaldo, non mi illumino
(7 aprile 1899)
Ho scritto
lettere alle possibili governanti in uno stato d’animo che non so
qualificare e descrivere. Non ho quasi coscienza di ciò che faccio, vedo
innanzi a me un deserto sconfinato. Non ho scopi, non ho più ideali. Che
cosa devo fare più in questo mondo?, quale via percorrere?, quale meta
raggiungere?, il nulla. Mi sento vuoto, spossato, insufficiente ad ogni
cosa. Dalla vita attiva, dall’energia umana, ossia ragionevole, sono
passato quasi senza avvedermene, nella vita vegetativa, nella vita
passiva. Vivo perché devo vivere. Si affaccia il sole e mi trova
desolato. Non mi scaldo, non mi illumino. Non mi punge, ne mi stimola ad
opere nobili o fruttuose. Batte il meriggio, scende la sera, poi la
notte con le sue ombre e mi fa lo stesso effetto del sole. Tutto passa,
anzi vola davanti a me, senza impressionarmi, senza lasciare traccia
alcuna. Sono una pallina di sughero che viene spinta di qua e di la dal
venticello, che percorre lo spazio e tocca i corpi, senza lasciare segno
di se e senza riceverne. Quanta sfiducia mi invade l’anima! Non ho
famiglia, morendo tutto muore con me. Non ho più speranza di compiere i
lavori scientifici da tanti anni vagheggiati da me. L’ampelografia
italica, l’idolo dei miei desideri è rimasta men che ombra. Serve solo
di amarissimo e desolante ricordo. La collezione ampelografica, la
figlia diletta della mia vita non è più, la fillossera l’ha distrutta.
Il mio Peppino non può più confortare la mia tarda e malata vecchiezza.
Che mi resta dunque? solo Dio; ma se Dio conforta lo spirito nella parte
delle umane attività, mi sento distrutto e quindi inutilizzato. Servire
la patria non mi è dato, mancano le forze, i tempi d’altronde corrono
tristissimi e corrotti. Non conto più. I miei vecchi colleghi ed amici
sono quasi tutti spariti. I nuovi venuti nella pubblica amministrazione
guardano quasi con disdegno e disprezzo i vecchi, come fossero disadatti
o nocevoli ad attuare le cose del mondo nuovo, del mondo dei giovani.
L’antitesi torna: il giovane in opposizione col vecchio, il vecchio col
giovane. Nella coscienza basta Dio e se non fosse per questo non potrei
vivere, ma nell’attività umana, quando vedo mancarmi l’affetto della
famiglia, della patria, della scienza, dico che mi manca tutto. Questa
mancanza di tutto è una desolazione, produce una noia generatrice di
martirio indefinibile. Ripeto sempre in questi belli e splendidi giorni
di primavera tutto ride intorno a me. Dentro di me impera il dolore e il
pianto. L’uomo veramente fu creato ad immagine del suo creatore, quindi
ha l’istinto e la facoltà di creare, non ha la creazione vera che dal
nulla trae ogni cosa. L’uomo crea servendosi della materia fatta da Dio,
la sua creazione consiste nel trasformarla in modo da renderla sempre
diversa e conferendo ad essa gradi di bellezza e proprietà sempre
variate e nuove. Oltre alla creazione nell’ordine materiale l’uomo imita
il suo creatore nella creazione o attività o energia intellettiva,
effettiva e morale. Quindi le passioni nobili, la carità, il bene, etc.
Anche questo, al punto dove sono è vietato a me. Non ho più nulla da
creare materialmente, nulla moralmente. Tutto mi pare vanità. Venendo
meno l’attività manca l’attuazione creativa che è una necessità
nell’uomo, derivata dal suo modo di esistere e dal creatore. Tutto va a
male. L’infelicità diviene il retaggio di quegli infelici che sono privi
o non possono esercitare il loro istinto, la loro missione. Ammiro
stupido il cielo, la terra, i luoghi che mi videro nascere e mi nutrono
e rimango impassibile, inebetito. Che cosa sono dunque? Mi accosto alla
follia?, sarà una malattia la mia?. Non so comprendere me stesso. Non
apprezzo altro in me che il dolore. Non vedo altro che il gran nulla.
Non ho altro avvenire che la vicina discesa nella fossa dei morti. Il
pensiero poi, della vita a venire è tremendo. Chi lo sa come andrà a
finirmi?. Dio avrà misericordia di me?, problemi tremendi che mi
accasciano maggiormente sono questi. Mi spavento, rifuggo indietro.
Stimo meglio starmene stupidito, quasi incosciente, come un arbusto o
come una chiocciola anziché sprofondarmi in questi misteri
supernaturali. La cura del dr. Ferrara ha mitigato la mia malinconia, ma
non ha svelto le radici, le quali, anzi, di tanto in tanto gettano nuovi
polloni e nuove spine. Chi mi compiange?, chi pensa che esisto?, a che
cosa sono ormai buono? Tutto è finito per me. La mia parabola è arrivata
al suo termine.
(29 maggio 1899)
Stanotte ho dormito poco e male. Sono affranto dai continui dispiaceri.
Alle 2 svegliatomi mi pascevo solo del mio dolore, sentivo un peso
enorme, un cordoglio grande come un fenomeno fisico morboso. Tutto si
presenta nero all’occhio mio ed alla fantasia. Corro verso mali
maggiori! Che mi accadrà? Oggi la melanconia si è resa acutissima. Sono
oppresso, concentrato, taciturno, con un incubo dolorosissimo
inesplicabile nel cuore. Nonostante la cura ricostituente del dr.
Ferrara invece di acquistare perdo maggiormente l’appetito e il sonno.
Fuggo il consorzio umano. Sono andato in biblioteca e sui lavori della
casa Itria e me ne sono tornato mesto e sconsolato. Non ho potuto
toccare il pianoforte pur facendo forza a me stesso. Mi sono rinchiuso
nella mia camera a leggere le conferenze del dr. Carmine Perrotta ai
maestri delle scuole elementari del circondario di Noto sull’agricoltura
di quella regione. Leggo e quasi non comprendo quei temi in passato a me
cari, oggi mi sembrano noiosi e scipidi. Posso ripetere tristis est
anima mia usqui ad mortum e davvero la morte è vicina ed io
l’aspetto con calma e quasi con piacere. Suonano le campane per la
prossima festa del Corpus Domini ed io mi rattristo, mentre giovanotto
mi allietavo a quello scampanio festevole e lieto. Quest’anno mi
proponevo di cooperare al buon successo di questa santa e solennissima
festività e tentare rimettere in uso la processione dei civili e delle
persone rispettabili per dare esempio al popolo che i grandi di un
paesuccio in faccia a Dio sono un nulla e uguali al più umile operaio.
Ma sono talmente nulla e disfatto, talmente accasciato e privo di
volontà e di operosa energia che mi rimango stupido ed inerte, passivo,
annichilito.
La melanconia si è impossessata di me
(20 maggio 1899)
La melanconia o mestizia si è da un pezzo impossessata di me dopo un
periodo di calma ottenuta con la cura del dr. Ferrara. Ora cresce tutti
i giorni e si modifica o meglio si peggiora in modi che io sento, ma che
non posso ne so descrivere. La melanconia ridotta a tristezza o mestizia
assume su di me un impero assoluto, desolato, schiacciante, lasciandomi
sempre più vuoto impietrito, lasciandomi quasi sbigottito, cioè come mi
trovavo qualche volta, dopo un improvviso subitaneo e forte spavento,
dopo qualche minuto di essere stato colpito da una grande sciagura,
tristissimo di dispiacere. Sono un desolato, sbigottito, senza volontà
vera, trascinato dagli eventi impotenti a reagire, a farmi coraggio, a
ripigliare l’autonomia personale. Non ho avvenire, non speranze, non
ideali, sono una piumicella in preda al vento. Perché esisto da ora in
poi? Chi pensa a me? qual’è la mia missione? Chi mi conforta? Chi mi
rivolge una parola? A tutte queste domande che faccio a me stesso
risponde una eco terribile di silenzio, per modo di dire, poiché il
silenzio non può avere eco. A queste domande il mio cuore si fa più
nero, si rimpicciolisce, si richiude e desidera la morte come l’unico
bene possibile. Oh il bel mese di maggio, il mese dei fiori e delle
rose, il mese dell’amore di tutto il creato, il mese della giovinezza e
delle feste vere del sole, del mare, della terra e di tutte le creature
che vi abitano, il mese di maggio del 1899 è per me terribile e
disperato. Non vedo il sole. L’olezzo della zagara mi dispiace. Che
stato infelice è il mio!
Quando vedo certi fenomeni mi acquieto solo pensando a Dio
(13 novembre 1899)
Ho visto per la prima volta gli uccelli cosiddetti di passaggio. Li ho
visti sull’alba, mentre ero sul piroscafo Galileo Galilei, a vista di
Palermo. Quando rifletti su questi fenomeni perdi quasi la ragione. Mi
acquieto solo pensando a Dio che li ha creati e li sorregge. Solo la
dottrina che fa capo a Dio è la sana, la vera, quella che spiega tutto e
da la pace all’anima umana, togliendo i dubbi e le aberrazioni connesse
alla sua debolezza. Togliete Dio, servitevi (per citare un nome) di
Darwin e di tutti i filosofi o naturalisti immersi nel materialismo o
nell’ateismo per spiegare molti fenomeni e vedete le contraddizioni che
vengono fuori nel descrivere la cosmogonia senza il Creatore. Quando
rifletto a questi piccoli casi come questo che ho visto, degli uccellini
(deboli ed irragionevoli) che agiscono da fortissimi e sapientissimi, o
meglio ragionevolissimi, la mia mente non può fare a meno di ammirare la
divina provvidenza, la quale sa creare e mantenere la sua creazione in
ordine perfetto. I materialisti di oggi mettono in ridicolo e sfatano
l’antica dottrina degli istinti, ma ridano pure quanto vogliono. Gli
istinti esistono, cioè le voci di Dio, né la mente umana può spiegarli
se non ammettendo l’intervento di Dio. Come è possibile con le teorie di
Darwin rendersi ragione della sorprendente architettura che fanno le api
nei loro favi e della direzione sicura che danno gli uccelli nel loro
lungo cammino da una parte di mondo all’altra.
Ogni anno la prima notte che dormo in Favara, tornando dalla piana,
mi sembra sempre un po’ strana
(18 novembre 1899)
La prima notte che dormo in Favara mi sembra sempre un po’ strana.
L’alba non è annunciata dal cinguettio degli uccelli estivi o dalle
calandre o dal correre e abbaiare dei cani, dentro un silenzio profondo,
ma dal confuso rumore degli operai che si destano e si apparecchiano al
lavoro o frequentano la piazza e i caffè. Parmi cosa nuova il ridestarsi
della vita cittadina prima del sole che può assomigliarsi al ronzio
delle api dentro ai loro alveari.
(17
Dicembre 1900)
Oggi
è il mio compleanno. Oggi compio 72 anni di pellegrinaggio in questa
valle di lacrime. Io non ero solito tenere ricordo di questo giorno. Le
orfanelle con le festicciole di affetto ed amore che mi volevano fare,
hanno, per così dire, richiamato la mia attenzione e la mia memoria su
questo giorno che passava sempre inavvertito. Io ho rigettato e impedito
queste feste e queste onoranze, parendomi inutili e inopportuni. Infatti
che cosa si trae di piacere in queste ricorrenze?, nulla di nulla. Solo
si contano i passi fatti dal dì della nascita fino ad oggi e si rileva a
colpo d’occhio una verità poco gradita, cioè che 14 lustri e mezzo sono
passati, che quindi il sepolcro verso cui incessantemente corriamo è
oramai troppo vicino. Quest’anno il mio compleanno è stato solo pensato
da me involontariamente e registrato nel diario. I domestici, gli amici,
i parenti, le orfanelle, tutti si sono dimenticati di questa ricorrenza,
la quale è trascorsa tacita e inosservata, cosa che mi è piaciuta,
poiché rifuggo dagli usi moderni di commemorare cose e date di nascita e
morte, compleanni, onomastici, nozze d’oro e d’argento, cinquanta anni e
cento anni. Un vero abuso, un vero allargamento di commemorazioni e di
onoranze prodigate senza ragione e spettanti solamente ai grandi uomini
illustri e benefattori della religione, della scienza, dell’umanità e
della patria. Lo scialacquo degli onori menoma e quasi perde il pregio
degli onori stessi, i quali debbono trarre importanza e culto dalla
rarità, cioè dal dover essere tributati ai veri meritevoli, che sono
pochi e non molti. Che cosa importa la mia misera persona?
Tolgo, trepidando,
l’ultimo foglio del calendario e tutto muore e sparisce
(31
dicembre 1899)
Ho tolto, trepidando, l’ultimo foglio del calendario domenicano da
sfogliare, che è appeso nel mio scrittoio. Dico l’ultimo dei fogli a
levarsi perché l’ultimo foglio che porta scritto il 31 dicembre sta
appiccicato in fondo al cartone e non si leva. Domani muore tutto e
sparisce. Mi è parso come se togliendo quel foglio avessi affrettato o
comprato la morte di un anno, anzi di un secolo, poiché questo anno che
entra domani rappresenta il principio della fine del secolo decimo
ottavo. Fatticelli da nulla che si succedono fatalmente impressionano
assai l’anima mia. Il levare un foglio, come ho fatto tutte le mattine è
un atto semplice. Oggi piglia un aspetto importante dentro di me. Mi
richiamo molti pensieri e molta mestizia. Scendo da un cavallo che mi ha
prestato il tempo dopo averlo cavalcato per 71 anni. Questo cavallo non
torna più, mi porterà domani il suo successore: il cavallo 1900, sulla
cui sella, non gli anni, ma i giorni sono contati. Il 1900 fra poco mi
balzerà di sella, mi butterà a terra, a disperdere le mie povere ossa in
sepoltura. Che animale focoso, furibondo, inarrestabile, corre e non si
ferma mai, tiene in groppa milioni di cavalieri di ogni età, sesso e
colore. Tutti i momenti ne rovescia giù milioni e tutti i momenti si
rifornisce di altri milioni e non si stanca, corre, corre, finché verrà
la sua volta di precipitare in un abisso da dove più non si ritornerà,
l’abisso dell’eternità. Che fatalità! e non ce ne accorgiamo. Muore il
1899 per dar vita al 1900 e senza la morte dell’uno non ci sarebbe la
vita dell’altro. Una tomba ed una culla. Nell’una si addormenta di sano
eterno un vegliardo canuto, nell’altra apre i sensi a vita novella un
fanciullo vispo e ridente, ma che mescola il riso col pianto e si reputa
signore del mondo ed è superbo di brandirne lo scettro e di vedersi
piovere milioni di auguri da parte di milioni di uomini che sperano
nell’avvenire spiacentissimi del passato. Ed è morto a mezzanotte in
punto il 1899, senza compianti, anzi, forse sprezzato e vilipeso da
tutti. Le cose vecchie, le cose finite, le cose che non possono più
servire a nulla, in generale sono dimenicate alla meno peggio e
tartassate maledettamente. Il 1899 muore come tutti gli infiniti suoi
predecessori. Fiori sulla culla; auguri al buon capo d’anno, poesie,
speranze, illusioni, promesse di ogni bene di Dio, col cominciare e
nell’ultima ora, nell’agonia si ripetono frasi di dileggio, di
detestazione, di malcontento, di rimproveri per i mali, per le sciagure
pubbliche e private, per le guerre per i disastri commerciali che gli si
attribuiscono. È sempre così, così è stato e sarà nell’avvenire. Domani
entra il 1900. Quante canzoni si canteranno in sua lode, quanti omaggi
gli si faranno a Gennaio, altrettanti e maggiori insulti abomini e
imprecazioni gli si daranno nel dicembre. La testa e la coda dell’anno
somigliano alla testa e alla coda dello scorpione che quando si vede
attorniato di fuoco, quando vede prossimo il fine della sua vita,
rivolge il proprio veleno contro se stesso e morde con le proprie
ganasce la propria coda. Si ripete l’eterno giro delle cose, sempre,
quasi d’un modo stesso. La novità è apparente. Tutto è vecchiezza, il
nuovo rampollo del vecchio ed il vecchio è figliato dal nuovo.
(1
maggio 1901)
Solevo prima salutare il maggio quando cominciava. Il sorriso generale
della natura, l’amore ridestato in tutte le creature. La pompa dei
colori e l’orgoglio della vita in tutte le forme e gli organismi mi
costringevano quasi a mandar fuori dall’anima mia un inno di lodi. Ora
tutto è finito. La vecchiaia mi soffoca. Invece della vita vedo la
morte. Tutto si rinnova, si ridesta. Solo io e gli altri miei pari in
età, lungi di riscaldarci al nuovo acceso fuoco della natura, appassiamo
maggiormente e corriamo veloci per il sepolcro. Il maggio, la
giovinezza, la forza, la potenza della natura tutta, per noi vecchi
segna la decadenza. Ogni giorno più che l’altro scemano le forze, si
attutiscono i sensi, mangio e dormo poco e male, sono sordo, la vista si
affievolisce, mancano i denti, non posso masticare e parlo male. La
solitudine, l’isolamento assoluto mi opprimono maggiormente. Non sono
sordo del tutto, ciò che mi rende noioso agli altri e oggioso a me
stesso. Prego Dio che mi chiami al più presto a miglior vita.
Quando mi assale
la malinconia pensieri tetri mi invadono
(11 maggio 1901)
La
malinconia torna ad assalirmi come prima; viene ad ondate, mi soggioga,
mi rimpicciolisce, mi annulla. Negli eccessi di tristezza mi assalgono
mille pensieri su svariate cose, ma tutti tetri e pieni di dolore e di
paure. Mia sorella ieri sera è stata colpita da dolori ai lombi e alle
gambe. Anch’essa risente il grave peso della vecchiaia. Mio fratello da
pochi giorni è a letto, debole, inappetente e si smagrisce tutti i
giorni. La sua salute è minacciata da continui incomodi. Egli invecchia
anzitempo e benché conti nove anni meno di me, sembra averne dieci di
più. Siamo tutti già avanzati negli anni e quindi ammalati o facili ad
ammalarci. Chi scomparirà da questa terra, chi scomparirà prima di noi?
Per legge di natura io che sono primo nato avanti a loro, devo pagare il
primo tributo alla morte. Desidero che così sia. Avrò meno cordoglio e
minori pene. Nell’altro mondo, in seno all’eternità penserò certo
diversamente di come penso in questa misera terra d’esilio. Se morisse
mia sorella ne rimarrei afflitto, chissà quali scene, quali vicende,
quali mutamenti vedrei in famiglia, rimarrei nella solitudine più
completa. Il mio cuore non avrebbe più palpiti. L’amore e l’affetto in
me sarebbero cose morte per sempre. Se morisse mio fratello avrei anche
altri mali da vedere e rimpiangere. Per la fatale dipartita dell’uno o
dell’altra non vedo che cose nere, anzi nerissime. Resterei misera
vittima del mio stesso dolore e poco sopravviverei a loro. Mi parrebbe
che i loro spettri mi ballassero notte e giorno mostrandomi il nulla
delle cose di quaggiù, il dolore immenso che tormenta tutti gli uomini
ed aperta la vicina porta della morte per me.
Rimembranze adolescenziali
(1 ottobre 1901)
Stanotte è venuto ottobre.
Raccolto nella solitudine e sopraffatto dalla melanconia, compagna
inseparabile della mia vita ed ora accresciuta per la vecchiaia.
Rannicchiato e chiuso nella mia stanza per la malattia che mi affligge,
ho guardato il cielo azzurro di cobalto, con certe nuvole biancheggianti
e belle mosse da un’aura fresca, non so perché sono stato assalito dalle
rimembranze e dai ricordi della mia adolescenza. Ho ripensato alla
villeggiatura che convittore del real collegio o convitto a Palermo,
facevo ai Colli, nella cosiddetta Casina Grande in mezzo a quella
magnifica campagna rigogliosa di ogni ben di Dio che si chiama Conca
d’Oro, con a lato Palermo. Oggi ci insediavamo in quel sito ameno.
Com’era bello, più che mezzo secolo indietro, cioè 12 lustri or sono,
questo giorno 1 ottobre per me , com’è mutato adesso, allora vita, brio,
spensieratezza, un certo vago amore dell’avvenire che mi pareva cosparso
di fiori e di rose, allora tutto attorniato da altri giovanotti più
allegri e più spensierati di me; mi abbandonavo alle più care illusioni
senza saperle valutare. Penso alla caccia agli uccelli coi vischi, con
la civetta, con le reti, alle lunghe passeggiate in quei boschi di ulivi
alti e allineati, su per i monti Cuccio, Gallo e Pellegrino. Penso alla
ridente spiaggia di Mondello. Penso alle belle conchiglie che andavo
raccogliendo lungo le rive di quelle spiagge marine incantate. Penso ai
piccoli musei che tentavo di metter su, là chiamandomi una mia speciale
vocazione, e come godevo poi a considerarle. Penso a quegli uccelletti
verdoni che addestravo a vivere in libertà, poiché messi alla verdoniere
come un balcone e dopo aver mangiato e bevuto nei due vasetti, come
graste impiantati ai lati della piccola favata dal finto balcone che
teneva per vetrata uno specchietto da dove, dopo essersi la bestiolina
mirata e compiaciuta e pavoneggiata, ne scappava all’aperta campagna per
ritornare con alterna voce. Penso ai miei cari compagni, la maggior
parte morti. Penso a tanti altri piccoli particolari di quel tempo beato
che più non torna, ne può tornare, di quel tempo di cui si apprezza il
pregio quando è perduto. Preso a quell’età di sollazzi e di svaghi
innocenti e mi pare per un momento di tornare indietro, ma subito casca
l’illusione e fa contrasto amaro con la presente miseria e con la
crescente e desolata vecchiaia. Da quando scrivo questi diari non mi è
venuta mai una così forte e lunga reminiscenza d’un tempo che
relativamente al restante della mia vita si potrebbe dire felice. Allora
mangiavo con appetito, con grande soddisfazione, allora mi pareva di
essere grande, ora, al contrario, mi pare di essere troppo piccolo o
rimpicciolito. Che cosa è dunque la vita? Una larva, un mistero, un
dolore!; e quei miei maestri, quel padre Tuppalli, quel padre Romano e
quel padre Nalbone ed altri sommi che mi tenevano compagnia nelle
passeggiate campestri, istruendomi sempre, narrando cose storiche e
mitologiche!, non sono più anch’essi.
Rimembranze del 12 gennaio
(12 gennaio 1902)
Ciascun anno, in questo giorno mi ricordo in memorando scoppio della
rivoluzione siciliana avvenuta in Palermo il 12 gennaio 1848. Ne ho
fatto parola nei primi diari. A quest’ora (sono le ore 7,30) si apriva
la scena. Io palpitavo senza sapere perché d’un certo palpito quasi
incosciente, forte, tra paura del tiranno e speranza di libertà. Era una
frenesia generale. Lo stato commosso, eccitato di tutti i cittadini e
più degli studenti universitari, fra i quali io mi trovavo per magnetico
influsso, comunicandosi reciprocamente si accresceva e arrivava al
delirio che mi avrebbe profetizzato che 52 anni dopo dovevo scrivere
questa rimembranza, dopo aver visto formarsi l’Italia una ed oggi
prosperare possente, nelle scienze con Marconi e molti altri, nelle
industrie, con le flotte armate, con l’avanzo di 41 milioni nel
bilancio, con tanti altri segni ed elementi di ricchezza e di progresso
civili. In quel 12 gennaio 1848 se fosse venuto un angelo a dirmi tutto
ciò che ho visto e vedo attualmente, non l’avrei creduto. Sia benedetta
la stella d’Italia e s’innalzi sempre di più a civilizzare e mandare
luce benefica al mondo. Io in questi ultimi anni sono stato dubbioso ed
ho guardato in nero il nostro avvenire. Ora però sono mutate in faccia a
fatti evidenti e grandiosi, i fatti che derivano dal cielo e non dai
reggitori del felice regno d’Italia, dei fastigi che stanno in
contraddizione, con la sconvenienza delle nostre politiche
costituzionali, dette monarchiche rappresentative e che in sostanza non
rappresentano nulla, perché la menzogna, come tante volte ho scritto. Vi
ha una forza maggiore che protegge la stella d’Italia una forza divina
che trionferà di tutto e di tutti.
Scene di contrasto mentre il popolo festeggia San Giuseppe
(18 marzo 1902)
Nel
pomeriggio fino a sera le bande musicali hanno suonato alternatamente
sui palchi in piazza bei pezzi di musica. Le tre bande forestiere quest’anno
sono tutte ben accordate, la nostra è meno rumorosa. Alle 5 p. m. sono
partiti per aria 3 palloni di Milano. Bellissimo il primo,
rappresentante un panciutissimo ambrosiano con giacca verde, cappello a
sofflè nero, parapioggia rosso e nero sotto l’ascella e calzoni corti,
con calze carne e scarpe eleganti. Poi è salito su una testa con un
baschetto inglese ed infine un altro capo con berretto militare
violetto. Oggi è venuto mastro Salvatore Amico, il governatore, a
raccogliere la solita oblazione e gli ho dato 5 lire, facendo i miei
rallegramenti per la festa. Stasera alle 6, ancora a luce di giorno,
erano accesi i lumi dei palchi della banda e facevano un bellissimo
effetto di luci colorate come tante pietruzze di mosaico rosso rubino,
color verde e verde smeraldo, veramente belli. Illuminazione cosiddetta
alla veneziana, di cui già l’Andreoli offrì diversi saggi
nell’illuminazione per la festa dell’Assunta nel 1900 e 1901. Le bande
suonavano sui palchi, il popolo invadeva la piazza col delirio del
magnetismo collettivo e psicologico, quando passatovi un piccolo feretro
nero gallonato bianco. Era certo un bimbo o una bimba spento anzitempo,
quasi nel nascere e un fiume di popolo doloroso lo seguiva in fretta.
Trapassando tra il mare dell’allegria si vedeva la gioia e il pianto.
Che contrasti! La vera commedia della vita. Accanto al tripudio ci sta
la morte. Si toccano e non si offendono le due folle, vengono a contatto
e non risentono nulla di ciò che dovrebbero risentire. Sono come due
correnti divise, intangibili tra loro, incoscienti. Oggi quelli che
piangono rideranno domani e domani, forse quelli che oggi ridono
piangeranno. Così passa e si svolge la vita della commedia umana. Alle
7,30 il cielo è nero e comincia a piovere. La piazza si spopola. Si
rompe il bello dell’allegrezza popolare. Incomincia lo sparo dei fuochi
artificiali. I fuochi sono stati belli. Le solite bombe a pioggia, ora
argentea, ora dorata, ora a globetti, ora a serpentelli ed altre forme.
Le solite ruote a girandole, i soliti fiori e tulipani a colori
cangianti, rossi, blu, verdi, gialli. Mi è piaciuto un gallo contornato
o ricamato di fuoco, pure cangiante di colori. La più bella vista è
stata quando si aprirono le ali dorate e la cresta e i bargigli di fuoco
rubino imitante il rosso dei galli vivi. Durante lo sparo dei fuochi
sono stati lanciati in aria 3 piccoli palloni, due costituzionali, cioè
a fasce verdi, bianche e rosse; l’altro a scacchi. Nel primo le fasce
erano intere, nel secondo spezzate nel mezzo, in modo che ogni colore
posava sulla fascia bianca. Uno investì il mio balcone centrale del
piano superiore e rimbalzato dal vento che soffiava sui tetti è ricaduto
in piazza squarciato. Il popolo ne fece prontissima man bassa. Intanto
durante lo sparo dei fuochi il cielo si è quietato un poco. Le bande
suonano. Il popolo rioccupa la piazza tutta. È un vocio generale; si
odono musiche, fischi, scrosci di riso e pare di assistere ad un mare
tempestoso di onde magnetiche e galleggianti. La musica continua fino a
notte.
Oh come tutto è mutato in peggio!
(4 luglio 1902)
.....
Come son mutate le cose tutte! Fino all’anno scorso, la sera, o in
circa, all’ave mi sedevo presso il casino, negli antichi sofà di pietra
e tutta la gente che mangia il mio pane e che abita in villa Piana mi
circondava e tutti davano la stura, discorsi ingenui o, se si vuole,
asinerie, e i loro discorsi lenivano i miei guai morali e mi
trasportavano come in una parentesi di riposo e quasi di ristoro. O
splendeva la luna o regnava il buio, quella conversazione bonaria di
bonarie genti era un conforto. In certi momenti io mi astraevo da loro
per contemplare gli astri, la via lattea, le costellazioni zodiacali, ma
poi tosto le liete e stridenti risate e il trillare di grilli o
l’abbaiare repentino di cani mi tuonavano dentro la prosa terrestre
della mia villa e dei miei villani. Non parlo più di tempi troppo
lontani, nei quali giovani e giovinette, suonatori e cantanti, danzatori
e danzatrici facevano festa e gazzarra intorno a me. Oh! quei tempi sono
da troppo tempo andati via! non giova rievocarli. Sento maggiore dolore.
I tempi dolci della famiglia! Ma ora la scena è cambiata. I miei
villani, le loro donne sono attempate e in parte invecchiate come me.
Non intervengono più a frotta nelle sere estive davanti al casino. Una
noia mortale li prende. I giovani fanno il servizio militare. Le ragazze
sono passate a marito. Restiamo un pugno di persone stanche, che amiamo
più il silenzio e l’isolamento che il benevolo cinguettio e la compagnia
reciproca. Ieri sera stetti un po’ seduto. Tutto taceva. Mi pareva di
essere una mummia tra altre mummie inaridite dai secoli. Mi accolse
un’onda più cupa di tristezza. Abbassai il capo, salutai tutti e col mio
bastone mi ritirai nelle solinghe pareti del casino, senza più udire
manco il ronzio delle mosche. Prima i cani davano segni di vita. Il
delegato me li ha avvelenati. Moretto il fido amico delle stanze è pur
esso tacito, oh com’è tutto mutato. La vita è finita, resta solo il
preludio della morte. Io vegeto, vedo i campi, le montagne, le nuvole,
il cielo come lo vedono le piante e gli alberi, taciti e soli, senza
comunicazione e scambio di idee e di affetti reciproci. Oh come tutto è
mutato in peggio!
Sensazioni strane mi assalgono
(26 luglio
1902)
Da
molto tempo ho inteso e mi è lecito adoperare questa parola, una
sensazione strana, che fa molto peso a me stesso e non so bene
spiegarla, anzi dubito se sia vera e materiale o fantastica ed
incorporea. Questa sensazione dapprima era lievissima e rara, la provavo
qualche volta in un mese. Man mano si è fatta più forte e più frequente.
Ma che sensazione è? È una sensazione che non posso definire e neppure
descrivere bene. Quando suonavo il pianoforte cominciò così, qualche
volta nei piccoli intervalli di riposo o mentre voltavo la carta di
musica mi pareva d’intravedere un certo non so che, come di un’ombra,
come il passaggio di qualche cosa dietro di me, ma voltandomi non
scorgevo nulla, restavo sempre solissimo. Poi ciò si ripeteva quando
scrivevo, quando studiavo e quando ero assorto in qualche meditazione.
Scossomi, guardavo, mi sforzavo di seguire quel lampo d’ombra e non
vedevo mai nulla. Da circa un mese, da quando sono in villa, questa
sensazione si è fatta più forte e spesso mi assale. È un gioco del
cervello? Può essere lo spirito del mio Moretto (il cane morto poco
tempo addietro) che vedendosi desiderato mi lampeggia attorno? Questa
settimana l’ombra è stata più fitta, mi è parso quasi di vederlo,
sebbene indistinto, senza forma. Saranno spiriti buoni o cattivi? Io non
credo a simili fandonie, contrarie alla umana ragione, ma le ombre mi
perseguitano, mi tentano, attraggono la mia attenzione. Si dice che
Socrate, Tasso e molti uomini illustri avessero avuto i loro benevoli
spiriti familiari, per conforto della solitudine e compenso della
ingratitudine e dell’ingiustizia degli uomini. Ma io sono mille miglia
discosto da Socrate e Tasso e dai loro simili, per merito e per tempo,
non posso illudermi e sperare sollievo da qualche essere soprannaturale.
Ma che cosa sarà dunque? Io non lo so. Ma vedremo ciò che succederà, se
si tratta di spiriti dovranno parlare o comunicare con me in altra
qualsiasi maniera. Se si tratta di morbosità della mia mente, sparir
deve col tempo.
Ricordi ridondanti di
allegria del passato che non torneranno più
(24
febbraio 1903)
Ieri
a pranzo solo con mia sorella, si rievocava involontariamente alla
memoria gli antichi ricordi, le passate gioie della fratellanza. In
questo giorno, 70 anni fa circa, io, all’età di 5 o 6 anni pranzavo con
mia sorella ed altri bambini in casa di mio nonno materno Biagio Licata
seniore, con tavola separata. Questo mio nonno era uomo di mente e di
cuore, d’ingegno ed istruito, uomo operoso, intraprendente, che alzò la
fortuna della sua famiglia. Raccoglieva i figli dei figli, i nipoti, gli
amici in casa propria nelle grandi solennità dell’anno e imbandiva
pranzi di lusso per l’affetto e dell’unione di parenti. Si trattava di
trenta o quaranta invitati, oltre a noi bambini. Quei pranzi, quei
raduni di parenti intimi e di amici erano vere feste, piene di letizia e
amore, di espansione ingenua, cordiale. Quelli erano tempi d’oro per il
casato. Ferveva una vita gioconda, patriarcale e condita delle più dolci
compiacenze ed emozioni. I costumi di oggi sono ben diversi. Siamo nella
completa decadenza degli affetti di famiglia e di amicizia. Ora le case
sono tombe. Regna finzione, isolamento e mestizia. Quelle scene
ridondanti di allegria, quel vocio confuso, quelle risate severe, quei
motti, la soluzione degli indovinelli, l’atmosfera carica di magnetismo
animale che uscendo dagli individui refluiva nella massa, si
ripresentavano vivissime alla mia mente e facevano un amaro contrasto
con la solitudine, col silenzio, col deserto di oggi. Tutti morti!
Tutti, tutti coloro che erano festeggianti e festeggiatori! Restiamo
vivi io e mia sorella. Se a me bambino avessero detto ciò che oggi, dopo
70 anni dovevo provare, mi sarei messo a ridere e non avrei capito
l’importanza e l’amarezza della profezia. Purtroppo oggi tocco con mani
la vanità grandissima delle cose umane, la miseria che travaglia tutti e
figli di Adamo.
Visita alle terre di
Zingarello e impressioni sul viaggio
(21
agosto 1903)
Stanotte, con l’animo sollecito, come quando si deve fare un viaggio, ho
dormito poco. Alle 4 mi sono svegliato. Mentre mi vesto e poi prendo il
caffè, sento il cocchiere che prepara e attacca i cavalli con pennacchi
e sonagli. Sento il bisbiglio delle persone che devono accompagnarmi.
Vincenzo Amico, Salvatore Aleo Nero, Carmine Airò e Antonio Vetro di
Giuseppe Marianello, che attacca il suo mulo al carrozzo o barroccio
prestatomi da Lentini Ficarella Salvatore. Doveva venirci Baldassare
Airò, ma si trova ai bagni termali di Sciacca. Mettiamo le cose da
mangiare con piatti, tegami, bicchieri e bottiglie, posate, salviette e
partiamo con l’aria fresca del mattino alle ore 4,20. Non avendo potuto
avere una carrozza locata ho dovuto servirmi dei miei poveri cavalli per
strade lunghe e disagiate. S’intende che parlo della gita da tanto tempo
prestabilita nel fondo Mandra di Scava, nella tenuta detta Zingarello,
nella mia quota toccatami con la divisione fatta con gli eredi di mio
fratello, mia cognata. Appena usciti dal paese dalla casina Piana,
passando per il pubblico macello e per Canali, ho visto lungo la strada
che conduce a S. Anna ed alla zolfara Lucia, Ciavolotta, etc. una vera
lava di gente. Pareva la processione delle formiche quando sgombrano da
un formicaio all’altro e veramente in faccia alla grandezza della natura
l’uomo è men che formica. Quelle teste o macchiette nere appena visibili
in crepuscolo davano l’aspetto di una serpe brulicante di vita e di
movimento in tutte le sue parti. Man mano che avanzava la lava si andava
spartendo, invadendo le vie secondarie, le scorciatoie per le diverse
miniere. Io non credevo che tanta gente lavorasse alle miniere di zolfo.
Uno sciopero di tutte queste formiche deve essere imponente e deve
destare paura, a misura che l’aria schiariva e il sole diffondeva la
luce, si vedevano tutti quei visi di adulti e ragazzi, con qualche cosa
di orrido nel colore, nello sguardo, nell’atteggiamento. A me pareva di
scorgere il marchio che imprime all’uomo la corruzione, la degradazione
fisica e morale e la mafia. Andavo tra me e me fantasticando tante cose
che sarebbe troppo lungo riferire, intorno al mondo, di redimere e
migliorare a poco a poco questa classe di zolfatai e pensavo ai tanti
che hanno le classi cosiddette dirigenti. Presso il campo santo vidi una
figuredda nuova tra l’elegante e lo strano, con grata di ferro e dentro
la nicchia un’immagine santa che non potei distinguere. All’esterno, nei
lati stava scritto a grossi caratteri su fondo bianco: a spese dei
vagoncinari. I vagoncinari sono la melma della melma. Come si fa ad
impastare le cose sante e la tristizia? È una religione di conio
mostruoso. Questa gente depravata crede che i santi aiutano il furto e
l’assassinio. La loro morale è immoralissima. A misura che si alzava il
sole e che andavo scoprendo lunga visione di tutte le campagne che
percorsi assai volte in gioventù, provavo un senso inaspettato di
sorpresa. Tutto mi pareva mutato, diverso da quel che era 40 o 50 anni
addietro. Solo i contorni dei monti e dei colli che si disegnavano
all’orizzonte estremo rispondevano alle antiche forme e ricordi, così le
sinuosità e le sporgenze del lido e il battere delle onde del mare
contro le alte ripe. Rivedevo quei campi un tempo deserti e silenti, con
pochi pastori e mandre di vacche, cavalli e pecore, qua e la, adesso
pieni di vita. Ora si può dire che la vita ferve dappertutto di gente.
Nuove case, piccole e grandi. Quelle grandi distese di giummarre
attenuate e in parte sparite. Le terre quasi tutte rotte dall’aratro,
qua stoppie galleggianti, là nerastre, perché bruciate di fresco. Un
mondo nuovo, una seconda rivelazione, a così breve distanza con la
metampsicosi, dopo molti secoli, l’anima non potrebbe più quasi
riconoscere nulla e difficilmente si orienterebbe a ricostruire lo
spettacolo dei luoghi delle prime sue abitazioni. Le zolfare poi,
sembravano un paese bizzarro e speciale. Vasti casamenti, forni di
fusione di zolfi a centinaia, parte allineati, parte disordinati,
imitavano colonne e rovine di città grandiosa sparita. I fumi di quei
forni ed i fumaioli delle canne fumarie delle macchine a vapore davano
l’aspetto delle città dell’inferno di Dante. Palazzi per gli ingegneri,
con telegrafi, telefoni, ferrovie a scarto ridottissimo che portano
zolfi dalle miniere al mare di Porto Empedocle. Erano tirate non dalle
locomotive, ma da muli e cavalli. Le miniere sono illuminate a luce
elettrica. Ecco come la civiltà penetra, invade tutto. Quando io, a 15
anni, passavo per queste contrade non potevo neppure per sogno
pronosticare a me stesso quello che vedo oggi. Tutto corre, tutto si
trasforma. Metto punto in queste digressioni che mi porterebbero assai
per le lunghe. Ho scritto solo un piccolo cenno delle impressioni
ricevute. Ero solo in carrozza. Mastro Antonio Pirrera stava sopra col
cocchiere, perciò farneticavo in soliloquio, tacito ed interiore. Ad un
certo punto si vedevano le grandi proprietà terriere del barone Giudice,
il latifondo Mosè con casamenti che equivalgono a villaggio e dell’altro
lato opposto Borrainito e Borraitotto, pure con vastissime case rurali.
La potenza dell’oro moderno produce questi fenomeni. Come la forza bruta
e prepotente del medio evo metteva in vista i baroni e i castelli, ora
il combattimento degli strumenti dell’agricoltura e dell’industria,
allora la guerra delle spade e delle guerre fratricide. Rientriamo in
carreggiata. Partiamo alle 4,40 ed arriviamo nella casetta nuova da me
fabbricata in marzo, alle 8 non suonate. Sino ad un certo punto
percorremmo la strada rotabile che da Favara va a Palma di Montechiaro.
Poi ci siamo messi sulle terre così come erano. Sono pianure immense,
con piccoli dislivelli e sassi e sterpi, ma i cavalli sono usciti
vittoriosi. Ho voluto arrivare a piedi alla spiaggia del mare. Ho visto
la sorgente d’acqua fresca e potabile che sta sulla riva. Ho percorso i
fili divisori della mia terra. Avevo l’occhio a tutto. Guardavo a terra
per indagare la natura del suolo. Mi piace assai, è sabbioso, compatto,
un po' calcare con sottosuolo di sabbia addensata e forte, come ho
potuto osservare nel fosso scavato per la calce e per cavare sabbia ad
uso di fabbricazione. Per vigna mi parve eccellente. Deve a forza
produrre bene. Non fa bisogno di aspettare l’anno di prova. Fin da
quest’anno posso cominciare la piantagione. Il suolo è scarso di
gramigna e di mala erba, ma infestato assai di giummarre. Questo è un
brutto nemico che dobbiamo assolutamente debellare. Il posto della
casetta è indovinato. È la che deve estendersi e svilupparsi tutto il
caseggiato rurale futuro. Ma C’è un’altra collina amenissima, proprio
sul mare, dove, se Dio mi da vita, intendo far pure un altro corpo di
case. Ci vorranno circa 60.000 viti. Tutte non possono vendemmiarsi e
vinificarsi e coltivarsi con vera comodità e risparmio, da un solo
casamento. Fa duopo per diminuire i trasporti dell’uva e delle viti e
per alleviare la via ai lavoranti, edificare due centri di abitazione.
In questo secondo centro che sarà delizioso per villeggiare, pescare e
cacciare, ci farò delle camere. Sento dispiacere di averci pensato assai
tardi. Non so se arriverò a poter fare ciò che mi bolle in testa. Del
resto sono cose buone. Si fa quel che si può e fino a che si può. Dio
penserà al resto. Ho subito dato ordine di cominciare fin dalla
settimana entrante l’ammannimento dei materiali: pietra, calce, tegole,
travature, etc. Pensavo però che, attesa la località, non si può farsi
una strada centrale diritta che va dalla casina al mare, perché in mezzo
ci sta un forte avvallamento. Si faranno due braccia curve che uniscono
i caseggiati e si farà poi un braccio piano nel mezzo che unisce i punti
più distanti dell’ellisse. Pensavo pure che è ben difficile assegnare
fin da principio la terra propria a ciascuno dei miei impiegati che
intende beneficiarne. Sarà forse meglio agire in comune, collettivamente
per poi fare le parti e gli assegnamenti. Ma sono ancora idee mie
indigeste, che vogliono discutersi prima di accettarsi. Ho ricevuto
gratissima impressione della bella terra e contrade. Mi ha accompagnato
il figlio del massaro Sorce che possiede ed abita la vecchia casina di
mandra di Scava, fino alla mia casetta di Zingarello ed ha fatto
colazione con noi. Vincenzo Amico ha tenuto un po’ di brio coi suoi
brindisi imprevisti. Aleo Nero non ha saputo aprire bocca, né prosa, né
rima. Mancando l’estro manca tutto. Con l’estro il non poeta poetizza,
senza estro il poeta spoetizza. Il mio progetto di fecondare questa
inospitale spiaggia è bello e lo vedo sempre color rosa e promettente.
Darà agiatezza a tante povere famiglie. Lavoro al popolo, buono e
genuino prodotto ai consumatori di uva e vino. Migliorerà il clima e
offrirà l’agio dei più belli e salutari passatempi, inclusi i bagni di
mare. Che Dio benedica questi miei intendimenti! Egli può tutto. Le
orfanelle, se avrò ancora i giorni che ci vogliono, godranno della loro
casa di villeggiatura e dei bagni.
Quel vecchio violoncello
mi ha rievocato antichi ricordi
(7
settembre 1904)
Ieri
è tornato l’ex carmelitano padre Emanuele Arnone, colui che mi trattò
con la più nera ingratitudine, che fu nemico gratuito e feroce e
calunniatore. Meno male che si è reso mansueto con me. L’ho perdonato.
Mi ha chiesto l’antico mio violoncello, in cui avevano fatto il nido i
topi, forandolo nel timpano delle corde. Il padre Arnone, dilettante di
musica, di buon orecchio e mezzo lunatico, è nella fase acuta di
insegnare alcuni ragazzi nella musica. Ha formato una piccola orchestra
ed ha promesso quanto prima farmelo sentire. Nel consegnargli il mio
violoncello sono stato assalito da vari e penosi ricordi. Quello
strumento che io suonavo discretamente nei tempi più allegri della
giovinezza e che ora non so più neppure tener tra le gambe, si è
mostrato più vecchio e cadente di me, impolverato, senza corde, così
malandato e sciupato da far pietà. Anche gli strumenti musicali
obbediscono alla legge universale del deperimento e della morte. Io vado
appresso al mio violoncello. Nel separarmi dal mio antico e logorato
strumento mi è venuta spontanea una lacrima nell’occhio. Ho sentito uno
strano mescolio e rimescolamento di vecchiaia e di gioventù, di vita e
di morte.
(28
dicembre 1904)
Dopo
una lunga e penosa malattia diabetica, stanotte, prossimi all’alba, è
morta Caterina Chiodo, nubile sorella di Calogero, il quale perciò è in
lutto fin da oggi. Mi sovvengono i ricordi del passato, quando io,
essendo pur giovane, con molti altri giovani, quasi tutte le sere sino a
notte la passavo in casa Chiodo tra le sorelle Mela, Pidda, Giulia,
Rosalia e Tina che era la più giovane, la più briosa, la più ardente,
che dava risposta a tutti e teneva allegrissima la società tutta
raccolta attorno a lei, con motti, risposte inaspettate e arguzie
ridicole. Era l’argento vivo della radunanza. Lo spirito focoso, senza
di essa languiva la compagnia. Si rideva, si chiacchierava, si giocava,
si ballava, si cantava, si facevano giochi di società e mascherate in
carnevale. Era il tempo della giovinezza per dir tutto in una parola di
quella età ridente, bollente e spensierata. Come tutto muta!, ora la
povera Tina, molto meno avanzata di me negli anni, invecchiata e
decaduta anzi tempo è morta. Da un pezzo era ridotta uno scheletro. La
carne turgida della giovinezza era sparita, le ossa e la pelle si
mostravano pallide e brutte. Se 40 anni or sono, mentre cianciavamo
allegri il quelle serate di svago e di ilarità, fosse venuto un profeta
a dirmi che oggi io avrei dovuto consegnare questi ricordi così opposti,
di gioia e di dolore, riguardo alla povera Tina, alla sua casa, alle sue
sorelle, non l’avrei potuto credere. Eppure è così. I tempi lieti sono
passati per sempre, non torneranno più. Di quelle piccole riunioni non
restano che paure di morte e pensieri di tomba, di sofferenze fisiche e
morali.
Silenzio e solitudine alla Piana
(30
giugno 1905) Ho dormito imperfettamente, cioè di sonno non profondo,
né ristorante. Mi sono svegliato alle 4 di mattina. Sempre le stesse
impressioni, le stesse rimembranze degli ultimi anni. Silenzio,
solitudine, nebbia scura nel cuore. Mi manca l'udito. La solitudine si
fa più austera, accompagnata dal silenzio profondo. I grilli cantano.
Canta il gufo, zittisce il barbagianni. I miei domestici lo sentono e ne
parlano, io non odo più nulla. Anche questo conforto, questo concorso
delle creature fatte per sentire la vita durante la notte che è una
specie di morte temporanea della natura mi manca. Posso veramente dire:
Tristi est anima mia. Il villeggiare o anche lo star nell'aperta
campagna che prima era dolce per me, oggi è divenuto amaro, o per lo
meno ha perduto le sue attrattive soavi e dilettevoli. La campagna suol
essere deliziosa per gli abitatori della città, quando dalla vita
travagliata e torrida passano al quieto riposo, quando dall'aria densa e
impura delle strade affollate di palazzi e di persone vanno a respirare
le grandi correnti dell'aria libera e ossigenata dei campi. Quando
dall'afa infuocata che lambisce le più infuocate mura delle strade
godono la piccola brezza dei campi che rinfresca un pochino la fibra
loro affievolita dai calori eccessivi dei formicus umani. E per
me tutti questi vantaggi quasi a me stesso, nel senso che non ne godo;
la malinconia non mi permette di gustarli. I miei sensi sono come
ottusi, le percezioni passano quasi inavvertite, o meglio, manomesse
dall'interno dolore. Ieri sera mentre la mia mente era in un sapore
confuso, come un dormiveglia, chiedevo a me stesso: L'anno vegnente
ritornerò, di questi giorni, in questo luogo, si ripeterà questa scena
della mia vita? Purtroppo ne dubito. Adesso non conto più gli anni, ma i
giorni. La distanza tra la vita e la morte, tra la villa Piana e il
cimitero è brevissima, basta un sol passo, un sol giorno per
sorpassarla. Intanto ringrazio Dio, piglio il tempo come viene. Ho dato
la stoppia di tutta la terra di S. Rosalia, cioè della stradella sotto
l'aia fin laggiù nella via pubblica che conduce a Stefano, alle
orfanelle. La sera quando il calore scema, esse vanno a rastrellarla per
terra e se ne fanno le provviste future per la cucina e i forni. Il
giorno più caldo di Giugno. Come fu forte il freddo e lungo, così credo
sarà il caldo.
(8
marzo 1906) Quando io avevo 5
anni salivo nei giorni festivi quelle scale, allora di pietra, anzi
spesso ci giocavo, tutte affollate di genti che saliva e scendeva, tutte
piene di vita e brio, ora lucide, pulite, ma deserte. Come mutano le
cose e i tempi! Nulla più esiste di quel mondo vecchio, di quell'insieme
di cose che colpivano la mia piccola mente. Mio nonno materno Biagio
Licata, mia nonna Maria Cafisi sorella del barone Stefano, donna Peppina
Ricca, il baronello Antonio Licata, i suoi piccini, etc., tutti sono
spariti. Peppinella Gangitano, Maricchia Licata mi ha ricevuto
nell'antica camera di ricevere di mio nonno, detta degli specchi. Le
decorazioni e la volta sono quelle che erano, l'unica cosa ancora
identica del tempo passato. Mi ricordavo stasera la brillante, anzi
splendida serata, quando mia cuginetta Peppina Ricca figlia di mia zia
Carmela e del barone Riccardo Ricca, si sposava in questa camera con
Nicolò Lombardo da Canicattì, poi padre di mio genero Biagio Lombardo.
Quante reminiscenze!, che folla di sensazioni e di ricordi mi hanno
assalito! Se volessi scriverli occuperei molte pagine. Ripenso che io
ero tanto piccino che non mi volevano fare penetrare nella stanza della
solenne cerimonia nuziale. Io piangevo e strillavo. Allora per
contentarmi, a stento, rompendo il ... della gente invitata, mi fecero
arrivare fin davanti la sposa che mi amava tanto quando ero bambino e mi
dava frutta e dolci e scusava e copriva le mie maccatelle, poiché io
bambino ero irrequieto davvero. Ripenso che mi mise vicino a lei, quasi
tra le sue gambe e mi diede un gelato, allora, per me dono insolito e
dolcissimo. E tutto quanto io dicevo tra me avvenne proprio qui in
questa stanza. Sono rimasti muti e fedeli testimoni, le pareti, i
dipinti della volta, i mattoni del pavimento e nell'altro. Tutto è
svanito. Non c’è più nessuno. Nelle mie infantili reminiscenze la sala,
la festa si ripresentano grandiose, ferventi di convitati, di parenti e
di amici. Ricordo le pitture ornamentali, ma mi sembrano ora
rimpicciolite, immiserite, scolorite. L'antica gaiezza, l'antica vita
non la vedo più.
Jessie White inviata
a Favara dal Times di Londra per una indagine sulle zolfare e il
problema dei carusi
(11
marzo 1906)
Jessie White vedova di Alberto Mario,
amica di Mazzini e di Garibaldi, di cui essa scrisse le gesta e lo
seguì, di Cattamo, di Bertani, di Nicotera, etc., ho detto utile il
fatto perché mi è utile ricordarlo. La Jessie socialista e di gran cuore
venne in Favara, non ricordo bene l'anno, se il 1891 o 1892, per vedere
de visu e studiare personalmente le infelici condizioni fisiche e morali
dei zolfatai e segnatamente dei carusi, ossia di quei ragazzi costretti
barbaramente a trasportare sulle tenere spalle lo zolfo greggio dal
fondo buio delle zolfare all'aria aperta, carusi deformati, rachitici,
contorti dall'enorme peso loro caricato tutti i giorni sugli sulle
spalle. Essa venne in casa mia accompagnata dall'avv. Bello e da un suo
segretario e pranzò in casa mia. Venne a vedere gli stabilimenti di
beneficenza da me eretti, allora non aperti al pubblico esercizio, fino
alla mia villa Piana. Disputammo a lungo sui modi di migliorare, anzi,
di redimere questi infelici carusi. Qui sarebbe lungo riepilogare la
cosa, molto più che la memoria non mi aiuta. Convenimmo in articoli
secondari e tra l'altro io mi opposi all'abolizione assoluta ed
istantanea del lavoro dei carusi. È ben giusto che cessi la barbarie, ma
si salvino gli interessi dei proprietari, degli esercenti le zolfare,
degli interessi così grandi che potrebbero qualificarsi nazionali e quel
che più degli interessi materiali e urgenti degli stessi carusi e le
loro famiglie. Se si aboliscono di botto i carusi con una legge
draconiana, si dovranno chiudere e tosto, tutte le zolfare, con
gravissimo danno. Mettiamo 10 anni di tempo per l'abolizione dei carusi,
graduale, dentro i quali 10 anni i proprietari e gli esercenti avrebbero
il tempo di fare i nuovi pozzi e le gallerie e macchine per estrarre lo
zolfo e condurlo fuori senza le spalle dei carusi, ma con forza
meccanica. La Jesse si arrendette al mio parere e ne fece menzione in un
articolo del Times di Londra, di cui era corrispondente ordinaria. La
Jessie White era più repubblicana che socialista. Amava assai l'Italia
come una seconda patria e venne quale corrispondente del giornale
inglese Daily News.
(1
novembre 1906)
Per
me il mese di novembre, come ho ripetuto quasi in tutti gli anni nei
miei diari, è il mese nero, il mese delle nebbie, delle nuvole, del
cielo vestito di piombo e delle piogge e qualche volta delle nevi. Ci
siamo entrati e dobbiamo rassegnarci ad attraversarlo e dobbiamo
sopportare le noie che ci infigge, la luce che ci ruba, la notte lunga
che ci regala. Sempre ho avuto paura di novembre, di questo mese dei
morti e delle melanconie. Quest'anno mi piace sperare di non dover
soffrire malattie o accidenti. Oggi è la fede di tutti i santi. Gran
tripudio quindi in cielo e in terra. Domani saranno commemorati i morti,
o meglio le anime purganti, con la speranza, anzi con la certezza che in
un tempo più o meno lungo, più o meno breve devono passare in Paradiso.
Le anime sciagurate e peccatrice cascate nell'inferno, domani non
partecipano alla festa per essi ogni speranza, ogni salute, ogni
godimento è finito per sempre. Hanno con loro l'eterno castigo, l'eterna
disperazione e la negazione della beatitudine in Dio.
Giochi
d'infanzia e rimembranze
(26 dicembre 1906)
Quando ero ragazzo nel convitto Real
Ferdinando dei gesuiti in Palermo, spesso nell'estate, nel pomeriggio,
in certe ore che adesso non ricordo bene, mi svagavo riproducendo
artificialmente l'arcobaleno. C'era una fontana d'acqua corrente da un
rubinetto di rame di grosso calibro che si apriva e chiudeva a volontà
con la solita chiavetta superiore. Su questa fontana, in fondo di un
gran corridoio si apriva una grande finestra, credo esposta ad
occidente, dalla quale i raggi del sole passavano a sbocco, cioè molto
inclinate sulla fontana, prima di riposarsi sul pavimento ed
illuminarlo. Io aprivo il rubinetto e poi col pollice lo socchiudevo per
di sotto, facendo sortire l'acqua a spruzzi, a pioggerella continua.
Allora brillavano vivissimi i colori dell'iride ed io facevo mille
scherzi, affrettando o allontanando il corso degli spruzzi o
sospendendolo e subito facendolo ricomparire. Variando poi
l'inclinazione e obliquità del getto d'acqua, s'intensificava o sbiadiva
il piccolo arcobaleno dipinto dentro il corridoio dalla maestà del sole
cadente.
(10
gennaio 1907)
Ieri
sera in casa di Maria Licata e signora Peppina Gangitano del fu senatore
Salvatore, profittando della presenza di un medium, cioè del giovane
avvocato (ora 36 anni) sig. Nicolò Dell'Aria da Canicattì, si tenne una
seduta spiritica. Il tavolinetto a tre piedi e senza chiodi di ferro fu
apprestato da Calogero Montalbano, l'orologiaro che sta al Carmine, al
cantone della casa Ambrosini, a tempi del fu Gaspare Dulcetta. Credo che
questa sia stata la prima seduta spiritica tenuta in Favara in buona
regola, in famiglie civili e col concorso di molti civili. Ho saputo che
il tavolinetto spiritico del Montalbano era esercitato, pregno di fluido
vitale o spiritismo. Ciò fa segno certo che lo spiritismo già da un
pezzo nel ceto popolare ha fatto strada. Tra gli altri che formavano la
catena spiritica c'era l'avv. Vincenzo Sanfilippo. Il tavolino cominciò
a dondolare e mostrare durezza e riluttanza a rispondere e così si venne
in chiaro che il tavolino, ossia gli spiriti che erano invisibilmente
presenti non volevano affatto l'intervento del Sanfilippo, perché
testardo e incredulo come poi ha dichiarato lo stesso tavolino che
parlava con piccole percosse o colpetti secchi corrispondenti in numero
al posto delle varie lettere dell'alfabeto. Ho parlato col Sanfilippo
che è stato testimone oculare di tutta la seduta. Quando il tavolino fu
riacquietato cominciò a dire che lo spirito presente era Antonio Licata,
cioè il buon padre di Maria Licata e che desiderava la celebrazione di
una messa. Gli fu domandato il perché e se fosse necessaria. Ha risposto
che non era necessaria, ma che serviva per glorificare Dio, e si è
allontanato col dire "vi benedico". Indi è comparso il sac. Antonio
Matina (defunto) che ha detto di stare bene. Richiesto se fosse contento
dei suoi parenti, ha dato un bel no. Dopo circa un'ora la seduta si è
sciolta. Io, al cospetto di questi fenomeni non vedo spiriti, ma fatti
fisici. Una catena magnetica animale, risposte e comparse di persone
note ai componenti la catena. Se ci fossero state manifestazioni
veramente spiritiche, cioè toccanti il soprannaturale, allora ci sarebbe
da pensarci un poco a cercare le cagioni produttrici di cotali
manifestazioni. Come per esempio quando evocano lo spirito di una
persona conosciuta solamente da colui che ne chiede la evocazione e da
nessuno dei componenti la catena, tostoché il fluido potesse da essi
estendersi ai vicini individui viventi e coronanti l'aura o fluido
vitale e perciò anche in tal caso la straordinarietà dell'accaduto
potrebbe spiegarsi fisicamente quando questo ignoto evocato piglia la
figura del defunto e si materializza e soprattutto quando scrive
correttamente con la sua ordinaria calligrafia, cioè con quella con la
quale scriveva quando era vivo e lascia lo scritto sempre controllabile,
allora si che vengono meno le ipotesi e le teorie, cioè peggiori simili
avvenimenti. Nel 1857 e 1858 vidi la prima esperienza magnetica. Avevo
un manuale di magnetismo animale in francese. Lo tradussi nelle parte
delle manovre per ottenere il sonnabulismo magnetico e lo comunicai al
dr Gerlando Micciché. Sotto i borboni anche il magnetismo era proibito
ed erano severamente puniti o perseguitati i cultori di esso. Noi
agivamo in segreto come i congiurati. Eravamo consapevoli in pochi. Io,
il dr Gerlando Miccichè, il dr Giovanni Antonio Bellavia, il dr Giuseppe
D'Angelo, l'avv. Calogero Dulcetta e famiglia. Il Bellavia era
incredulissimo e derideva i fenomeni magnetici, dicendoli parti
fantastiche delle nostre menti ammaliate e malate. Il Dulcetta aveva una
servetta nativa di Palma di Montechiaro, debole, esile, infermiccia. Il
dr Miccichè la curava e le medicine non gli giovavano. Allora volle
applicare il ... consultivo. La servetta cadeva facilmente e subito nel
più perfetto e chiaro sonnambulismo (trance). Una sera, alla
spicciolata, per non dare sospetto, io, il dr Miccichè, D'Angelo e
Bellavia convenimmo in casa Dulcetta. La servetta nel semibuio, a porte
chiuse e ben bendata cadde tosto nel sonnambulismo. Io e Bellavia
restammo nel pianerottolo della scala, dietro la porta chiusa della
scala. Allora il magnetizzatore dr Miccichè le chiese chi C’è qui
presente. Essa rispose: nel salotto, a destra C’è la padrona di casa al
buio che guarda dallo spiraglio della toppa e dietro l'uscio d'entrata,
in capo alla scala C’è il dr Bellavia e uno che non conosco. Allora
entriamo io e il Bellavia e gli fu domandato: Cosa tiene in tasca
Bellavia ed essa rispose: nella tasca grande del petto una bottiglia di
vino. Siccome Bellavia sapeva che la seta non dava passaggio agli
afflussi magnetici, coprì la bottiglia con un fazzoletto di seta e la
ripose nell'altra tasca. Gli si domandò della bottiglia ed essa rispose
semplicemente: non la vedo. Sempre si serviva del verbo vedere. Che
cos'altro ha in tasca nel gilet il dr Bellavia: l'orologio da una parte,
dall'altra due piccole chiavi ed una moneta antica, descrivendola
precisamente come se l'avesse avuto sott'occhio, lei al buio e bendata.
La moneta era stata trovata lo stesso giorno al Malvizzo zappando la
terra del Bellavia stesso, dove era andato di persona, quindi si esclude
il caso di trucco e d'inganno. Nessuno aveva potuto sapere di quella
moneta e nessuno aveva potuto comunicare alla rozza servetta la sua
esistenza. Allora Bellavia cominciò a credere ai fenomeni magnetici.
Finalmente si arriva al punto culminante. Il dr Micciché le disse: che
metodo di cura ci vuole per guarirmi e tosto rispose: i preparati per
unzioni e il sodio e principalmente l'unguento napoletano che è la
pomata di Cirillo? Il dr D'Angelo le dice: non sarebbe meglio l'unguento
francese?, ed essa: Ma che, l'unguento francese non esiste che nella
vostra testa e non nella farmacia. Il dialogo o soliloquio era dalla
ignorante servetta sostenuto in perfetto italiano, di buona pronuncia.
Quando dobbiamo fare questa cura?, rispose l'ammalata (eravamo in
dicembre): verso la fine di aprile, perché quest'anno la primavera sarà
tardiva. Così finì. C'era un certo spirito fatidico, sebbene relativo e
fatti fisici e cause concatenati. Poi anche in segreto, ai tempi di
Domenico Pandolfo e presente suo figlio Beniamino Panfolfi, avendo
sposato posteriormente un'avventura da romanzo, una ricca ragazza unica
ereditiera di certi baroni di Salisburgo, con altri amici: Mulè, Giudice
ed altri giovani, la sera nel gran corridoio del convento del Carmine,
permettente il padre maestro Dulcetta. Domenico Pandolfo alloggiava in
una cella monacale del convento da anni. Facevamo girare un mio
tavolinetto tondo in mogano che ancora conservo. Ho voluto ricordare
questi fatti perché si riattaccano allo spiritismo, ossia ai primi passi
e fatti spiritici esplicati in Favara. Ma il nostro tavolino non
parlava, si limitava a girare alle volte anche vertiginosamente a destra
e a sinistra, secondo che noi volevamo. Io non so formarmi un'idea
adeguata ed un concetto preciso di questi fenomeni detti spiritici di
cui ho scritto qualche cosa nel diario 1906. Mi accosto all'opinione di
Flammarione che attribuisce questi fenomeni detti spiritici ad una forza
naturale sconosciuta e queste forze sono certamente naturali, non
potendo alcun fenomeno uscire dal campo della natura. Il Flammarione
parla delle diverse teorie, o meglio, ipotesi e speculazioni dei più
noti uomini che hanno voluto conoscere, studiare e spiegare lo
spiritismo dai materialisti, agli animisti. Sono tutti vari fra loro.
Uno che combacia perfettamente con l'altro non C’è, segno che sono tutti
meno uno nel campo del falso. La verità è una e dev'essere uguale a se
stessa e agli occhi di tutti coloro che per tale la riconoscono, atteso
il carattere suo di unità e identità.
122 |