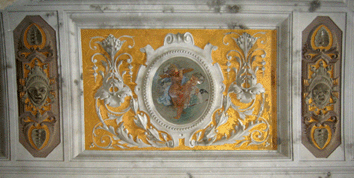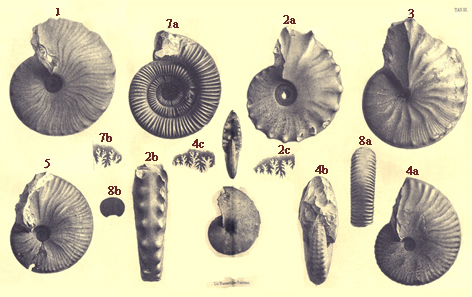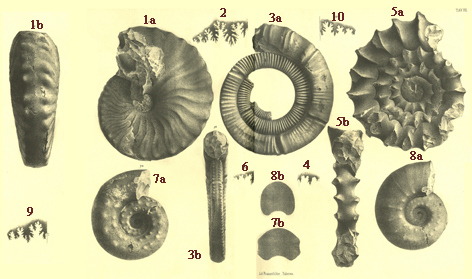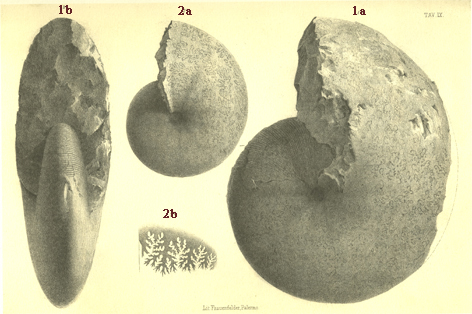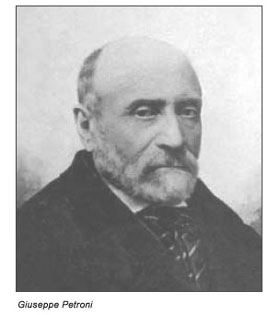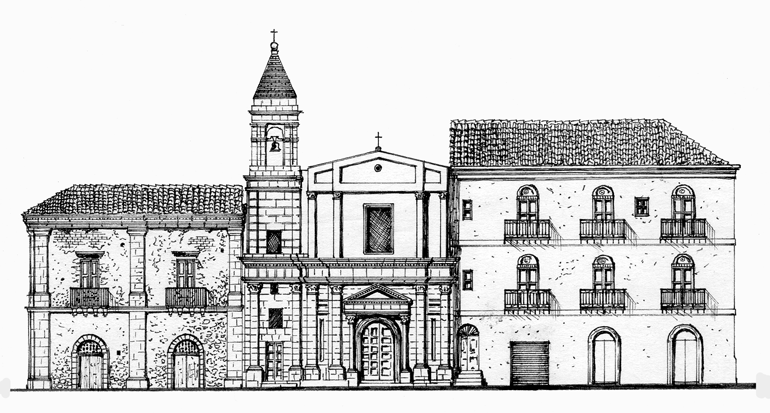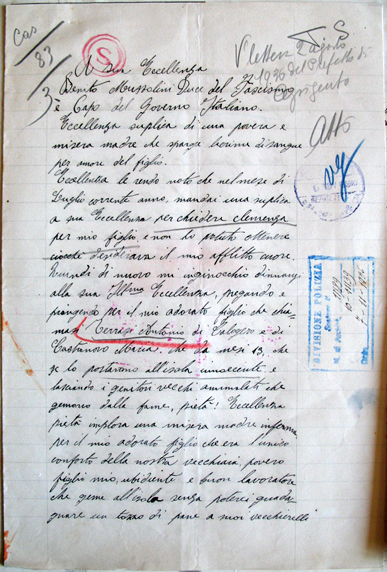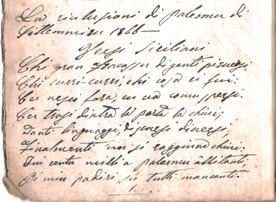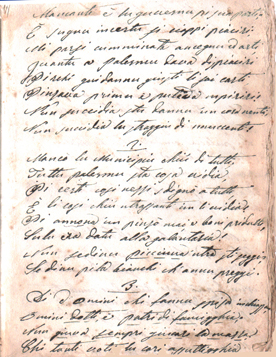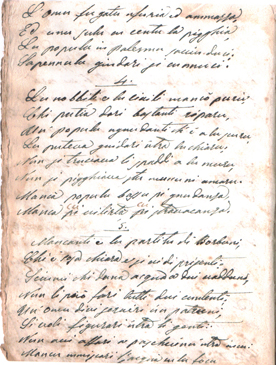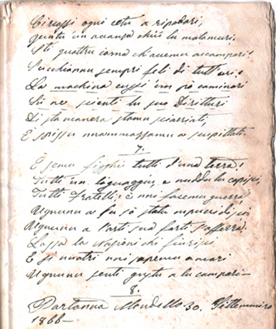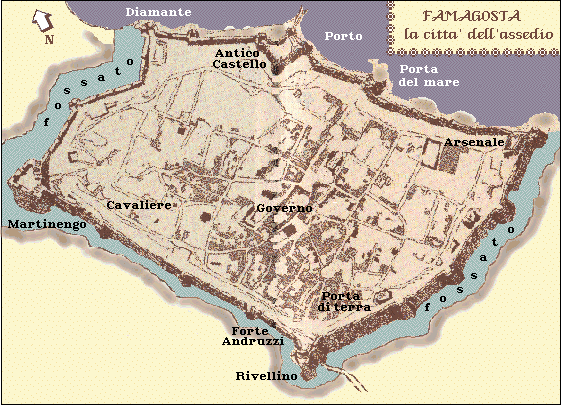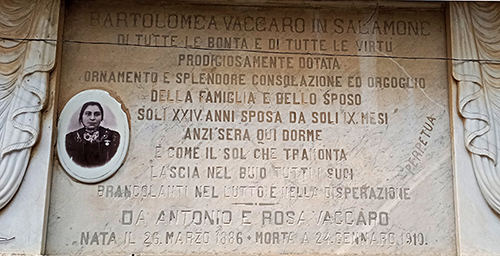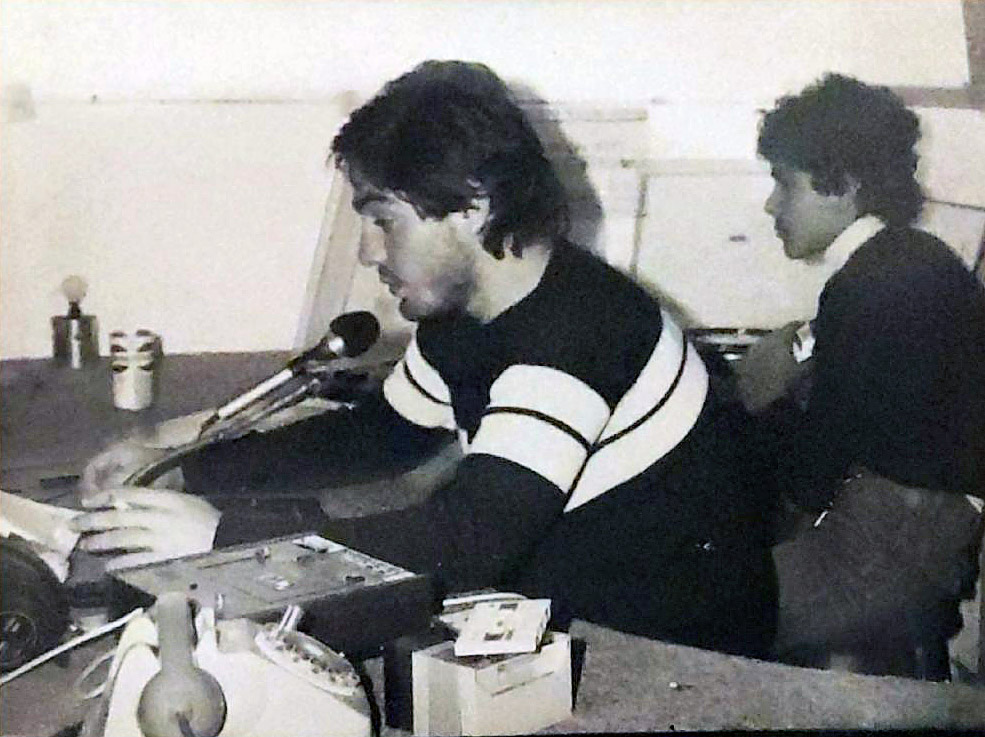|
28 -
Radio Faraci: una voce fuori dal coro a Favara negli anni “70
(di
Giuseppe Maurizio Piscopo)
La storia di
radio Faraci ha avuto particolare rilevanza per il ruolo che ha rivestito negli
anni “70 dello scorso secolo, come strumento di contro-informazione. Il fenomeno
delle radio libere a Favara è stato così importante che il giornale L’Ora ha
dedicato un paginone del suo inviato Umberto Rosso dal titolo: “Favara unita
dalle radio”. Il periodo di radio Faraci corrisponde agli anni più violenti
della storia d’Italia. Questa radio ha segnato una intera generazione di giovani
che magari non divennero tutti militanti di qualche partito, ma di certo
rimasero simpatizzanti ed elettori di sinistra.
A parlarci
di radio Faraci è il professore Giuseppe Alonge docente di Italiano, Latino e
Storia nel liceo M. L. King di Favara.
Quando
nasce radio Faraci?
Radio Faraci
nasce nel 1977 ed è l’espressione del movimento sessantottino, che va dal 1967
al 1977. A Favara arriva nel 1977 ma già altrove in Italia e in Sicilia erano
entrate in tutte le frequenze le cosiddette Radio Libere. La prima radio libera
in Sicilia nasce nel 1970 nel Belice in particolare a Partinico ad opera del
sociologo Danilo Dolci che dal Trentino si era trasferito al Sud, in quell’area
che era stata colpita dal terremoto la notte tra il 14 e il 15 Gennaio del 1968.
Per sollecitare le istituzioni ad intervenire e denunciare lo stato di abbandono
in cui versava l’area terremotata inventò una radio che restò accesa appena 27
ore e in quelle ore il cronista Danilo Dolci denunciò i delitti culturali,
morali e politici che si stavano consumando in quei giorni in quel territorio.
La sua radio fu così violenta nel linguaggio e spregiudicata nel fare i nomi,
che dopo 27 ore di trasmissione i Carabinieri corsero e si affrettarono a
sequestrarla. È l’inizio delle radio libere in Sicilia. Alcune sono
semplicemente commerciali e i programmi sono solo musicali, espressione delle
Hit Parade di quel periodo, programmi intervallati da pubblicità a pagamento che
per alcune emittenti diventò un vero e proprio business.
A fronte
delle radio commerciali, cominciano a nascere le radio di movimento che sono la
voce delle lotte degli studenti e degli operai. Processano ininterrottamente la
classe politica al governo responsabile della condizione economica e sociale del
Paese dove ignoranza, sottosviluppo, sfruttamento ed emigrazione dal Sud la
fanno da padroni.
Le radio di
movimento non hanno alcun finanziamento e non sponsorizzano e pubblicizzano
prodotti di nessun genere, perché queste sono le tessere del mosaico capitalista
ritenuto, dal movimento, l’unico reo della sub condizione umana, costretta a
vivere di stenti e disperazione. Le radio di movimento funzionano col contributo
dei militanti per dare voce alla lotta di classe del movimento operaio, dei
contadini, degli studenti e delle donne che già hanno dato vita al movimento
femminista per rivendicare parità di diritti, di dignità e di eguaglianza con il
suo simile: l’uomo.
Inizialmente un gruppo di giovani si riunisce nel cortile Copernico per
ascoltare musica e per parlare di politica.
I giovani
del futuro movimento scambiavano le proprie idee o passeggiando o stando seduti
sui gradini delle costruzioni che sorgono lungo il corso principale, il sabato
diventava più numeroso perché rientravano, alla fine della settimana, gli
studenti universitari che frequentavano a Palermo o a Catania. Più passavano i
giorni e più cresceva il numero, allora chiamato contestatori della società. E
così, che si ritenne opportuno trovare un locale dove potersi incontrare,
discutere, ciclostilare i volantini, progettare manifestazioni e organizzare il
dissenso. Furono trovati due ampi vani a piano terra nel Cortile Copernico,
traversa del corso principale del paese. Il proprietario era un vecchio compagno
dissidente del PC, che fu felice di locarlo agli extraparlamentari, così si
sentì anche lui dissidente ed extraparlamentare. Il collettivo proletario quindi
aprì in Cortile Copernico nell’autunno del 1976. Io ero rientrato dalla Sardegna
per trasferimento al Liceo Scientifico di Casteltermini. Quindi da Giugno del
’76 ad Ottobre passai il mio tempo a conoscere la situazione politica del mio
paese e incrociavo i contestatori che facevano riferimento chi a Lotta Continua,
chi a Il Manifesto, chi al PDUP. Decidemmo di affittare un locale per progettare
un programma di lotta. È doveroso ricordare che il gruppo iniziale era
costituito da: Pasquale Castellana diplomato, Saro Moscato universitario, Franco
Moscato, fratello di Saro, studente del professionale, Franco Zarcone giovane
disoccupato, i fratelli Lillo e Totò Liotta studenti universitari, Antonio
Marotta universitario in Medicina, Lorenzo Di Caro giovane pensionato per un
incidente sul lavoro all’età di 15 anni, Diego Matina studente, Cosimo Cassaro
dipendente SIP, Carlo Marotta imprenditore, Angelo Castronovo studente, Enzo Di
Caro studente, Antonio Di Stefano universitario, Lillo Infurna universitario,
Antonio Pecoraro maestro. Come gruppo ci si incontrava il sabato, ma durante la
settimana i meno impegnati si incontravano per discutere seduti o per ascoltare
musica psichedelica e canzoni di lotta preferibilmente di Francesco Guccini, gli
Inti-Illimani, Claudio Lolli, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Maria
Carta che saranno poi gli autori delle nostre ore musicali nella futura Radio
Faraci.
A chi
venne l’idea di fare una radio?
Ad un certo
punto ci si accorse che i volantini anche se venivano distribuiti per il corso
principale o in Piazza Cavour avevano sempre gli stessi lettori. Studenti,
pensionati e giovani nullafacenti che frequentavano questi luoghi che sono stati
l’eterno spiazzo per le persone di tutti i tempi. Per potere parlare alle
casalinghe, agli uomini e a tutti quelli che non gradiscono passeggiare o
fermarsi in Piazza Cavour a discutere, sull’onda delle radio libere si pensò di
fornirci di questo strumento per allargare il dissenso e coinvolgere più
protagonisti. A Favara già esisteva una radio ben collaudata che era lo specchio
della società borghese allora dominante e padrona. Radio Favara 101, così si
chiama ancora adesso, prima trasmetteva dal centro del paese poi si trasferì nei
locali del convento di San Francesco e da lì informava e sollazzava gli
ascoltatori con musica leggera, con interviste ai notabili e alla classe
dirigente del paese fatta di democristiani e socialisti.
La
pubblicità era regolarmente a pagamento. Un’altra radio sorse sul corso
principale ed era sul modello della 101 con pubblicità e musica a richiesta e
Hit Parade del giorno: Radio Centrale. Quando si parlò al collettivo di radio, a
nessuno venne in mente una radio diversa da quella dei movimenti di protesta,
per cui già a priori sapevamo tutti che non sarebbe esistita la pubblicità a
pagamento, che la musica sarebbe stata quella delle canzoni di lotta, della
contestazione, della cultura alternativa, dell’emancipazione della donna, e
pertanto il costo della gestione era a carico dei militanti. L’idea della radio
non fu di un singolo compagno, ma pian piano era maturata l’idea di una radio
tutta nostra, per fare controinformazione e denunciare la situazione economica
prodotta e gestita dai partiti dominanti.
Chi
scelse il nome di Radio Faraci?
Un nome
venne proposto da tanti e da tutti. Alla fine fu accolta la proposta di Diego
Matina con un nome che rispondeva alla collocazione geografica del paese di
Favara: Radio Faraci per ricordare che ad Ovest del nostro paese c’è la collina
di Caltafaraci che in stretto siciliano noi pronunciamo “cantafaraci”. Al
collettivo mi sono permesso di illustrare perché quella collina si chiamasse
Caltafaraci ed ancora oggi si trova nel territorio di Agrigento. Il nome
cantafaraci ho informato l’assemblea, nella tradizione popolare, veniva detto
quando dalla montagna Favara giungevano i lamenti dei torturati dal faraone di
Agrigento, appunto Faraci. La tortura consisteva nell’introdurre nel ventre di
un cavallo di rame il condannato a morte e ai piedi del cavallo veniva acceso un
fuoco. Il condannato man mano si scaldava il rame, cominciava ad emettere prima
grida e poi lamenti che uscendo dalla bocca del cavallo sembravano un canto. Nel
borgo Favara, posto a valle, quel lamento veniva percepito dalla gente che
ironicamente esclamava: Canta Faraci!
La
denominazione della radio forse è inappropriata dissi a tutto il collettivo, ma
il Faraci della radio non canta ma si ribella e denuncia le malefatte dei
potenti del nostro tempo. In sintesi radio Faraci era ed è stata la voce degli
esclusi, di chi non aveva avuto fino al quel momento la parola e la voce per
ribellarsi.
So che il
trasmettitore venne fornito da Radio Sud Palermo e il mixer di sei canali da un
tecnico di Caltagirone
Con
l’accordo di tutti i compagni iniziò la corse alla realizzazione di Radio Faraci.
In poco tempo i fratelli Carlino Pippo e Carmelo, studenti universitari uno alla
facoltà di Ingegneria e l’altro in Architettura trovarono il trasmettitore che
venne fornito da un compagno di Radio Sud Palermo; il mixer di sei canali venne
procurato da Cosimo Cassaro che con il suo lavoro alla SIP venne a contatto con
un compagno di Caltagirone e Pasquale Castellana, uno dei pochi a disporre di
una macchina lo andò a ritirare dopo che noi avevamo raccolto un po’ di soldi
per comperare l’usato.
La radio
ebbe sede a Favara nel cortile Priolo la parte alta di via Zanella, centro
storico della città. Che atmosfera si viveva nel 1977 all’interno della radio?
Radio Faraci
viene montata in cortile Priolo, vicino la chiesa San Vito, in una casa di
proprietà del Signor Giuseppe Fanara. Quando cominciò a trasmettere, nel
Febbraio del ’77 gli ascoltatori si accorsero subito che questa era una radio
diversa, aperta a tutti, purché venissero rispettate le regole di una radio di
movimento e di lotta. Vennero donne, anziani, vecchi compagni minatori, i quali
invece di stare seduti in Piazza Cavour venivano ad ascoltare un po’ di musica
che Lillo Bellomo e Calcedonio Zarcone offrivano facendo sentire canti di
minatori e vecchie nenie delle nostre antenate. Ricordo che una sera si è
esibito dal vivo il gruppo popolare favarese ed altri musicisti.
Gaetano
Ricotta e Salvo Patti universitari a Bologna quando si trovavano in paese o a
Bologna facevano sentire la loro voce intervenendo sui problemi del momento o
mettendoci addirittura in collegamento con Radio Onda Rossa.
Atmosfera di
novità e di festa si respirava dentro Radio Faraci. Era una conquista del
movimento ed era la voce del movimento stesso. Il massimo del coinvolgimento
della città e delle aree circostanti fu quando i compagni di Radio Popolare di
Milano ci informarono che stava arrivando Roberto Mander per raggiungere il
confino di Linosa, accusato per la strage di Piazza Fontana avvenuta nel 1969
assieme a Pietro Valpreda. Al seguito di Roberto Mander c’era tutta la stampa
nazionale: da Paolo Liguori (oggi uomo di punta di Mediaset), allora con lo
pseudonimo di straccio firmava gli articoli su lotta continua. Miriam Mafai
moglie di Giancarlo Pajetta corrispondente dell’Unità, Stefano Chiodi che
scriveva articoli per il periodico L’Europeo e L’espresso e decine di compagni
milanesi e romani. Anch’io accompagnai Roberto assieme ad Enzo Di Caro e da lì
scrissi degli articoli per il quotidiano dei lavoratori che era l’organo di
avanguardia operaia e poi di democrazia proletaria. Per le forze dell’ordine
Radio Faraci era complice e connivente con i terroristi nazionali. La situazione
precipitò quando il 16 Marzo del ’78 a Roma in Via Fani si consumò la strage
delle guardie del corpo e il sequestro di Aldo Moro.
Radio Faraci
che faceva da ponte con Radio Popolare, Radio Onda Rossa di Bologna e le radio
di movimento romane divenne il centro di informazione per aggiornare le
condizioni di Mander. Fu un vero e proprio terremoto. Seguimmo con ansia ed
attenzione sia i terribili fatti nazionali che quelli locali. Ci apostrofarono
terroristi e di conseguenza il controllo era diventato più rigoroso. Furono due
mesi di sgomento, apprensione e di naturale condanna del criminale gesto delle
Brigate Rosse. La gente aveva difficoltà a distinguerci dalle BR perché noi
eravamo extraparlamentari dell’ultrasinistra, per cui per l’opinione pubblica
non c’era alcuna differenza. Il massimo della rabbia esplode il 9 Maggio quando
viene trovato a Roma il cadavere di Moro e sulla linea ferroviaria
Palermo-Trapani il cadavere di Peppino Impastato. Radio Faraci si mette subito
in contatto con Radio Aut ma al telefono rispondono voci a noi sconosciute e
subito abbiamo capito che erano dei poliziotti che presidiavano lo studio della
radio. La sera i partiti dell’arco costituzionale hanno organizzato la
manifestazione e noi ci siamo aggregati sia per protestare contro le BR sia
contro la mafia sicuramente l’assassina di Impastato. 2/3 del corteo favarese si
mise dietro lo striscione di Democrazia Proletaria, la lista in cui era
candidato Peppino a Cinisi e io, Peppe Alonge, a Favara. L’onorevole La Russa,
Filippo Lentini e il PC alla fine della sfilata per la città non ci hanno fatto
salire sul balcone del comune assieme a loro per il comizio conclusivo e la
condanna degli attentati mafioso-brigatista. Per loro noi di DP ed Impastato
eravamo brigatisti e quindi terroristi per cui non avevamo diritto di parola. La
rabbia è esplosa anche nei compagni più riflessivi e pacati. Impastato dicevano
era un brigatista ed è morto mentre preparava un attentato sul binario da dove
sarebbe passato il treno Palermo-Trapani. Da quel momento le radio di movimento
approfondiscono le cause della morte di Peppino Impastato e per noi fu subito,
senza ombra di dubbio, delitto di mafia, camuffato per atto terroristico. Il
tempo è galantuomo e subito si seppe che Impastato prima fu ucciso in un
casolare e poi fu fatto brillare sulla ferrovia: ucciso due volte. Peppino io
l’avevo incontrato in una riunione di radio libere collegate alla FRED
(Federazione Radio ed Emittenti Democratiche), prima a Bagheria e poi ad Enna
dove mi avvicinò e volle sapere notizie sulla lista di DP e soprattutto della
gestione del sequestro Moro.
Perché la
radio chiuse nel 79?
Il periodo
di vita di Radio Faraci corrisponde agli anni più violenti della storia
d’Italia. Dal 9 Maggio in poi il nostro tragitto è stato Favara-Cinisi per
partecipare al funerale e alle varie manifestazioni pertinenti la morte di
Peppino.
Intanto il
Signor Fanara ci invitò cortesemente a liberare l’immobile perché l’avrebbe
dovuto restaurare per adibirlo a civile abitazione. La verità era tutt’altra. La
gente gli rimproverava di avere affittato una casa a dei brigatisti e non degli
amanti della musica di Claudio Villa e Luciano Tajoli.
Sloggiammo e
trovammo una soluzione nel quartiere Palma Oliva notoriamente conosciuto come la
piccola Mosca di Favara. È stata chiamata così perché il quartiere era abitato
da minatori e alle elezioni le sezioni del quartiere erano un voto plebiscitario
per il PCI. Quartiere rosso dunque.
L’estate del
’78 di Radio Faraci è segnata da questa pausa e per riprendere le trasmissioni a
fine anno da un altro punto della città, molto più difficile, vista la posizione
del quartiere per cui le onde sonore non possono coprire tutta la città.
Intanto, in quel mese di Settembre mi sono dovuto allontanare perché mia madre
era stata colpita da un tumore ai polmoni per cui dal Settembre del ’78 all’8
Marzo del ’79, giorno del suo decesso, sono stato travolto da una impensabile
tragedia della quale fui io il massimo responsabile della gestione per tentare
l’impossibile per un’eventuale guarigione. Intanto la morte di Moro, lo
sbandamento del movimento a livello nazionale si è ripercosso anche sulle radio.
Nelle grandi città le radio resistettero ancora per un po’, ma furono costrette
ad abbassare i toni o addirittura vennero bloccate dalla magistratura. Radio
Faraci rimase in vita un paio di anni, ma credo che abbia lasciato il segno in
una intera generazione di giovani che magari non divennero tutti militanti di
qualche partito ma di certo rimasero simpatizzanti ed elettori di sinistra.
Radio
Faraci trasmetteva sui 103,00 MHz. Furono trasmessi parecchi dibattiti sui
grandi temi come l’aborto, il nucleare, il divorzio, i problemi della carenza
idrica. Come reagiva la gente a questi dibattiti?
Radio di
movimento vuol dire anche coinvolgimento degli ascoltatori alla realtà
quotidiana dibattendo i problemi che allora erano i più scottanti: il divorzio,
l’aborto, l’occupazione, il nucleare e qualche anno più tardi i missili di
Comiso, il Sud e l’abbandono delle campagne, l’eterno problema dell’acqua. La
gente telefonava, chiedeva spiegazioni e proponeva soluzioni.
Radio
Faraci e radio Aut di Cinisi. Che rapporto c’è stato tra le due radio di
contro-informazione?
Il rapporto
tra Radio Faraci e Radio Aut s’intensificò nella primavera del 1978 quando DP
riuscì a presentare la lista per il rinnovo dei consigli comunali a Cinisi e
Favara. Fu una campagna rovente primo perché era in corso il sequestro di Aldo
Moro e poi perché il 9 Maggio vennero uccisi sia Moro che Impastato. Il 25
Aprile del ’78 venne a sostenere le liste siciliane di DP, come detto a Cinisi e
Favara, il professore Pino Ferraris, docente di storia contemporanea
all’università di Torino e Camerino. La mattina aveva comiziato a Cinisi, la
sera i compagni con una macchina lo accompagnarono a Favara dove alle 20 in
Piazza Cavour parlammo ad una folla di migliaia di persone. Mi venne spontaneo
chiedere a microfono aperto che impressione avesse avuto della realtà di Cinisi.
Mi rispose con queste testuali parole:- “Se Impastato non lo fanno fuori prima
sicuramente a Cinisi prenderemo il consigliere”. Impastato non venne mai a
Favara e i nostri Rapporti furono di movimento e di lunghezze di onda. Dopo la
morte ci fu tutt’altro rapporto con Cinisi, con la mamma di Peppino e con
Giovanni.
Peppino
Impastato e Danilo Dolci con la radio dei poveri Cristi avevano capito che la
Sicilia stava per essere soffocata dalla mafia e da una certa classe politica.
Entrambi sono stati massacrati dal potere. Ecco quello che i siciliani non hanno
capito: chi sta veramente dalla loro parte…
Giuseppe
Impastato e Aldo Moro muoiono lo stesso giorno 9 maggio 1978. Sulla stampa sono
apparsi grandi articoli per la morte di Aldo Moro e un trafiletto su Peppino
Impastato…
Peppino ebbe
rapporti politico culturali con Danilo Dolci e prese spunto da Danilo l’idea
della radio come strumento di comunicazione e di denuncia. I responsabili della
miseria della Sicilia erano la DC e quelli come Gaetano Badalamenti. Nell’estate
del ’78 come radio, come DP e come movimento venne un gruppo folk da Cinisi
creato da Peppino. Ricordo, che la ballata che cantarono all’inizio e alla fine
dello spettacolo si concludeva così: “Una data unni scurdamu, chiddra di lu 9
Maggio”. Ovviamente la coincidenza della morte di Peppino nello stesso giorno
della morte di Moro fu fatta passare in silenzio, il suo valore e il suo
messaggio. C’è voluta tutta la cultura e la forza dei democratici e della
scienza del Dottor Professor Ideale del Carpio, medico legale del policlinico di
Palermo per sbugiardare la versione ufficiale delle forze dell’ordine sulla
morte di Peppino Impastato. Del Carpio accertò con la sua autopsia che già sulle
rotaie della ferrovia Peppino era morto, ucciso con diversi colpi di arma da
fuoco. Poi c’è voluta la determinazione di Umberto Santino, storico e militante
palermitano per dimostrare che la versione dei servizi segreti, i quali dicevano
che Impastato era un terrorista, era solo un’invenzione politica per allontanare
i sospetti dai reali mandanti ed esecutori del delitto: La mafia su ordine di
Badalamenti. Oggi dopo 50 anni in tutte le scuole il 9 Maggio viene ricordato
Impastato come martire della mafia e da allora scuole, vie e quanto altro hanno
preso la denominazione di Peppino Impastato vittima della mafia. Finita la DC
nessuno si ricorda più di Moro, dovrà finire la mafia invece per dimenticare
Impastato.
Guido
Pollice, Roberto Chiodi e molti altri giornalisti sono passati dalla radio?
Paolo
Liguori, Stefano Chiodi e Pino Ferraris vennero a Favara e dai microfoni di
Radio Faraci hanno salutato i compagni e i lettori di Favara.
E’ vero
che questa radio faceva paura ai politici ?
La prova che
Radio Faraci fosse temuta dal potere l’abbiamo avuta la sera del 9 Maggio 1978
quando ci hanno negato la parola in Piazza Cavour alla fine di una
manifestazione di cui i 2/3 del popolo di Favara era dietro lo striscione di DP
con la scritta: “Peppino Impastato sarai vendicato dalla giustizia del
proletariato”.
Avete mai
ricevuto minacce alla radio?
Le minacce furono un fatto quotidiano: telefonate anonime, macchine graffiate,
ma la vera minaccia l’ho subita nell’Aprile del 1981 durante la campagna
elettorale per il rinnovo dell’Assemblea Regionale, come sempre per noi
infuocata e personale, quella volta era candidato Lorenzo Di Caro, per non
candidare sempre Peppe Alonge, ma comunque io ero quello più in vista e la notte
del 30 Aprile del 1981 ci hanno tagliato 800 ceppi di vigna piantata da due anni
e che quell’anno avrebbe prodotto il primo raccolto. “Così impari mi dissero con
una telefonata anonima”.
|