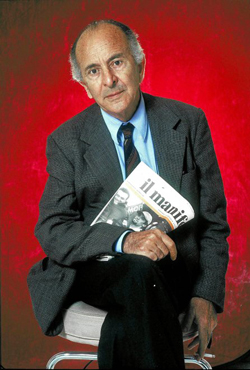C’era un mostro in Favara che offendeva spudoratamente leggi, religione, onestà
pubblica e privata e faceva per nome Domenico Sajeva di Giovanni e Angela Sajeva,
razza cattivissima". Queste erano testuali parole del barone Antonio Mendola.
Domenico Sajeva era perito agronomo, un tipo un poco bislacco, socialista, con
l’atteggiamento del babbeo giudizioso, il classico tipo, come suol dirsi a
Favara, che cercava sempre "scuru e fudda". Non si riusciva a conoscere il vero
colore di costui, ovvero, se aveva colore, o se li mutava tutti, secondo le
occasioni, come un camaleonte. Era uno spirito turbolento, vario, sovversivo. Il
Sajeva, mattoide come suo nonno Menico, soffiava nelle passioni popolari,
predicava l’amore delle plebi, malediceva i dazi consumo, spingeva il popolo ad
assaltare, distruggere e bruciare i casotti del dazio.
La sua avventura iniziiò a rinfocolarsi nel 1902, quando il popolo di Favara
cominciò a duolersi dei medici favaresi che avevano fissato il nuovo annuo
onorario, salatissimo, anzi, insostenibile per le famiglie povere. I medici
erano diventati nemici spietati dei sofferenti.
Nel mese di agosto 1902 c’è stato un grande comizio popolare. Menico Sapeva
parlò per circa un’ora, riscuotendo gli applausi e il favore del popolo. Propose
alla popolazione di rompere l’accordo coi medici. In Favara si chiamava
"accordo" l’annuo pagamento fissato tra il cliente e il medico. “Rompete tutti
l’accordo - ha gridato Sajeva - e vedrete rotto l’incanto. I medici si
sbraneranno tra loro come cani”. Poi ha proposto l'apertura di una farmacia
notturna: cosa veramente necessaria. Ma il sindaco Angelo Giglia era negato per
le opere di beneficenza. Il Sajeva disse: “Per fare disegnare a Ciccio Maniglia
a chiaro scuro 25 ritratti dei 25 sindaci (quelli esistenti nella sala
d'ingresso al primo piano del Palazzo di Città di piazza Cavour) ha pagato 625
lire; per la beneficenza diviene taccagno e pitocco”.
Nella prima metà di settembre correva voce che il dottorino Valenti avesse
spinto gli altri medici a lanciare querela criminale contro i membri del comizio
popolare, che avevano sottoscritto la risposta inserita nel giornale L’ora
ed un’altra querela contro Menico Sajeva, per le parole pronunciate nel comizio
stesso contro i medici.
Si è costituito un comitato di difesa e resistenza, e i denari abbondavano per
sostenere le spese di dette querele.
In occasione della cosiddetta "congiura dei medici", Menico Sajeva ha fatto
nascere un giornaletto in Favara, tutto dedito alle cose paesane col titolo "La
Campana del Popolo" (di cui ancora oggi esiste una raccolta ben rilegata
nella biblioteca comunale di Favara), nel cui primo numero ha dato una bella
lavata di capo ai medici.
Purtroppo gli altri numeri non hanno risposto alle comuni aspettative. Menico
Sajeva, ancora giovane e inesperto sognava rose, ma era destinato a vedere spine
e avrebbe compreso la grande differenza tra il detto e il fatto, e quanto
difficile era in Favara operare il bene e quanto era facile la censura e la
calunnia.
Nel giornale il Sajeva, imprudentemente, aveva fatto stampare l’elenco, con i
nomi delle persone che avevano contribuito alla colletta, che andava
raccogliendo nel popolo, per pagarsi gli avvocati difensori. I medici si sono
inviperiti, hanno fatto comunella e si sono resi solidali nel male, rifiutandosi
di curare i membri del comitato a prezzi plausibili e correnti.
Un articolo ingiurioso e diffamante di Sajeva contro il dr. Vita nel n. 5 de
La Campana del Popolo ha fatto inacerbire ulteriormente le cose, al punto da
prendere il carattere di una pubblica e dannosissima discordia.
Sajeva era un grande birbante. I medici gli hanno alzato un piedistallo d’oro.
Ci voleva una voce autorevole. Ma chi si poteva mettersi in mezzo? Comporre il
dissidio tra due era facile, tra molti difficilissimo. Mancava poi un paciere,
che avesse effettivamente i requisiti e l’abilità richiesta nel presente caso.
I medici pretendevano una disdetta stampata dal Sajeva nei giornali, con la
quale smentiva le cose dette da lui. Naturalmente tale dichiarazione veniva
negata dal Sajeva.
La causa la chiamarono: “La causa del piccolo parlarolo”.
Il 14 novembre Menico Sajeva fu condannato dal Tribunale di Girgenti ad un anno
e 10 giorni di carcere, oltre a mille lire di ammenda, alle spese di
pubblicazione della sentenza in tre giornali.
Menico Sajeva ha avuto il torto di avere adoperato l’ingiuria e la diffamazione
per difendere una causa giusta.
Dopo la sentenza La Campana del Popolo non vide la luce. Sajeva non ha
avuto testa e tempo per infarcire di suoi scritti il giornale.
Il 16 novembre, il Sajeva, tornando verso le 5 di pomeriggio da Girgenti, ebbe
una dimostrazione popolare numerosa, una specie di ovazione. Sajeva, in mezzo
alla folla plaudente e commossa, è sceso in piazza Cavour, è salito su un tavolo
ed ha pronunciato un vibrato e conveniente discorso. Concludeva con queste
parole: “Io Domenico Sajeva, con la penna, con la parola e col cuore, con e
senza le manette, sempre con voi, come spero voi sarete sempre con me”.
Molti si commossero. La piazza era gremita di persone, come per le feste solenni
di S. Giuseppe, era un muro di teste e berretti. Questa enorme alzata di popolo
non è stato certamente un fatto piacevole per i medici.
Ma le cose non sono finite qui. I dottori Valenti, padre e figlio, divenuti
accaniti, persecutori, pieni di presunzione e di odio implacabile, per medie
persone del capitano e tenente della truppa, hanno preteso di sapere se un
articolo del concorso delle spie in Austria, che Menico aveva fatto stampare ne
La Campana del Popolo, alludesse ad essi Valenti ed in ogni caso volevano
una dichiarazione scritta e firmata dal Sajeva. Sajeva rispose che non era
obbligato a dar risposta. A seguito di ciò i messi intimarono il duello, ma
Sajeva rifiutò.
Il 24 gennaio 1903 si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulla
proposta della Giunta, di lanciare querela contro Sajeva, per la lettera aperta
pubblicata ne La Campana del Popolo, diretta al prefetto, dove chiedeva
un’inchiesta amministrativa sul Comune. Il Consiglio Comunale, ab irato,
ad unanimità ha autorizzato la Giunta a procedere a spese pubbliche contro
Sajeva.
Sajeva si era atteggiato piuttosto bene. Dopo essersi procurato l’aura, la
benevolenza popolare cominciò a voler fare l’indipendente, non sentendo i
consigli degli amici e gli avvertimenti di uomini sperimentati. Eccedeva ad ogni
passo, cominciava a mettersi da sé in mala voce: perdeva fautori e seguaci.
Un’altra querela sulle spalle lanciata da un corpo intero rispettabile del
proprio paese, a vicinissima distanza di tempo, produceva pessima impressione
nel pubblico e nell’animo dei giudici.
Nel marzo 1903 sono partiti per Palermo, per l’appello di Sajeva, i medici
Gaetano Vita Guadagno Miccichè, Gerlando Spadaro, Libertino Fanara e il
dottorino Calogero Valenti.
La sera del 10 marzo arrivava un telegramma a Favara con la scritta: “Domenico è
assolto”. La bandiera, di buon mattino, sventolava nel casino o circolo
Fratellanza ad onore di Sajeva.
In realtà Sajeva fu liberato dal carcere; ma fu condannato alle spese del
giudizio ed alla multa di lire 200 invece di 1.000. Non era completa vittoria,
ma era un buon trionfo!
Arrivato in Favara Menico Sajeva ha avuto una vera ovazione, un’apoteosi
popolare.
La strada dell’Itria era gremita di popolo: uomini, donne, vecchi e fanciulli,
tutti gioiosi e plaudenti.
Il sindaco e i medici fecero proibire la
banda musicale e l’uscita dei gonfaloni delle diverse società popolari, mentre
carabinieri, guardie, delegato e truppa, erano in gran movimento nel badare
all’orda di popolo che plaudiva Sajeva. Menico ha avuto un giorno trionfale.
Questo fatto è servito di esempio ai medici, per valutare un’altra volta la
potenza democratica.
Il giornale La Campana del Popolo del 18 agosto è divenuto più feroce di
prima negli attacchi personali e assieme al giornale avverso nel frattempo nato:
L’Avvenire, era divenuto una palestra indegna di sfogo, di odi, rancori e
coltellate.
L’Avvenire del 21 agosto, numero doppio 28-29, con quattro pagine di
fuoco, ha sparato la bomba, facendo guizzare per l’aria vampe e risuonare tuoni
spaventosi. È stato vuotato il sacco delle contumacie, delle diffamazioni, dei
vituperi. Sajeva è stato fatto segno a tutte le possibili ingiurie, colmato di
fango e di disprezzo. Questi problemi toccavano Favara perché non c’erano uomini
di carattere, non c’erano princìpi religiosi, non c’era amore di patria, carità
di prossimo, desiderio di progresso civile. Favara era in uno stato grave di
convulsione; c’erano tanti perché, ma nessuno poteva dare la risposta. Era un
pasticcio, una completa contraddizione. La causa prima era la mancanza di
caratteri, la nullità dei cittadini; una gioventù nulla, serva, che non sapeva
elevarsi all’altezza dei tempi e al bisogno, che col suo operare insano, andava
riducendo il paese ad una tomba. Nel pubblico c’era grande aspettativa: pace o
guerra. La curiosità era immensa. L’opinione delle plebi era mutevole
soprattutto in questi eccessi. Un giorno gridava evviva, un altro giorno muoia,
muoia! Menico Sajeva gridava a tutta gola, si scalmanava dentro la casa della
sua Fratellanza. Un grosso codazzo di zolfatai gli faceva corona.
Alla fine di agosto si intavolavano trattative di rappacificamento fra i
redattori de L’avvenire e il Sajeva. Ci lavoravano il pretore, il
delegato e l’ing. capo della Provincia Gibilaro.
I vecchi, coloro che componevano il piccolo patriziato locale erano tutti
scomparsi; restavano i giovani, che dovevano essere civili, progressivi,
pionieri dei tempi nuovi e invece davano il più triste spettacolo, lottando tra
il fango dei vituperi, delle calunnie, delle insinuazioni. Invece di porgere
esempio di virtù, di amor patrio e moderazione, offrivano alle plebi già
abbastanza abbattute, uno scandalo continuo e ripugnante.
All’inizio di settembre il prof. Francesco Scaduto fu chiamato da amici comuni
per comporre il dissidio, oramai pericoloso, tra Sajeva e Vita Guadagno e
Bennardo redattori de L’avvenire. L’8 settembre è venuto Scaduto; poi è
sopraggiunto l’avv. Pepè Bruccoleri da Girgenti e il delegato Montalbano. Si
sono appartati in una camera, per discutere il componimento amicale tra gli
arrabbiati avveniristi e la maledica Campana. Sono usciti dopo
lunga discussione senza concludere nulla. A sera Scaduto e il sindaco Giglia
sono andati a trovare Sajeva nel casino Studio e Lavoro. Menico Sajeva ha
avuto l’abilità di fare venire, ad pedes, il sindaco e il prof. Scaduto!
Fenomeni strani e scandalosi!
Menico Sajeva ha gettato un paese in uno stato di anormalità, in un parossismo
convulsionario e morboso. Segno non tanto del valore effettivo del Sajeva,
quanto della degradazione e tendenza immorale del popolo: perché un popolo
saggio non si poteva lasciare manomettere da un Pietrino L’Aretino novello.
A sera i dissidenti hanno fatto una specie di pubblica dimostrazione. Tutti
riuniti, insieme, altresì, al delegato, a Scaduto ed altri, hanno passeggiato su
e giù per la strada "Nuova" (corso Vittorio Emanuele). La pace era fatta. I veri
offesi, che hanno perduto molto, sono stati quelli de L’avvenire. Sajeva
era il perturbatore, il virulento, il sarcastico gladiatore che, pur ferito, non
sentiva dolore e non aveva sangue da perdere. Ma, meglio così che affrontare
mali peggiori!
Il direttore de La Campana del Popolo, il malefico Sajeva non sapeva
moderarsi. La satira, la maldicenza, il prezzo sardonico, l’arma del ridicolo
erano le sue arti consuete, da cui non poteva o non sapeva allontanarsi. Si
rigirava tra piccolezze, punzecchiava le parti meno malate, si attaccava ai peli
e lasciava da parte le travi. Si sfogava contro il consigliere comunale, contro
il sindaco suo amico e contro qualche altro. Non scopriva le piaghe larghe e
sanguinose, non si fermava sui furti o peculati, sulla negazione di ogni bene in
fatto di criteri amministrativi, sull’immoralità, sulla corruzione, sui
parassiti che mangiavano al Comune, dissanguando il popolo. Sajeva quando
soddisfaceva i suoi istinti forsennati di maldicenza non si curava di altro.
Sajeva era un repubblicano sui generis, un repubblicano comodista. Ciò
che a lui piaceva, stava bene. Si pasceva di trizzi e di arzigogoli, di miseri
giochetti di parole, promuovendo il riso indecente. Queste cose a Favara
piacevano. Si battevano le mani. L’ambiente era lurido e nero.
Le intemperanze e maldicenze giornalistiche di Menico Sajeva, la sua
irrefrenabile e continua febbre di assalire e aggredire le persone ha fatto
molto male al padre Giovanni, che ha perso la migliore clientela, gli amici, gli
affari. Il primo semestre 1904 Menico è stato espulso dalla casa paterna. Il
sicario della penna è andato a rincantucciarsi nel misero ufficio de La
Campana del Popolo, nei mezzi tetti concessigli dal casino o circolo
Studio e Lavoro, in un giaciglio come un cane, solo, abbandonato. Forse gli
pareva di guadagnare merito con queste privazioni e divenire martire.
Sajeva continuava a lanciare fulmini contro il sindaco Giglia e lo diceva anche
ignorante. Se continuava come aveva cominciato, Menico si sarebbe consacrato col
suo stesso fuoco, come lo scorpione che, quando non poteva inoculare altrui il
proprio veleno, si mangiava la coda e moriva. Nella sua La Campana del Popolo
fulminava Giglia, ma nessuno se ne curava. Giglia e i suoi opponevano il più
profondo silenzio e se si continuava così, Sajeva era destinato a rimanere
nullo.
Diceva molte cose vere contro Giglia, ma quel dir male per sistema, quell’eccedere
nelle ingiurie e nelle frasi virulente muoveva a sdegno il pubblico dei lettori.
Povero grillo! Era destinato alla pazzia seguendo le orme del suo nonno Menico.
Il Sajeva già si firmava dottore. Si creava un titolo senza averlo. Si credeva
importante e con ciò mostrava vanità, orgoglio e nullismo. Ha formato una
fanfara reclutando nella sua Fratellanza i trombettieri reduci
dall’esercito, che suonavano piuttosto benino. Egli lo faceva, per avere uno
strumento di chiasso, di svegliapopolo, uno stimolo entusiastico musicale di
disordine, una riviviscenza dei famosi fasci del Colaianni. Fatto sta che venne
cacciato via anche dalla Fratellanza degli zolfatai.
Sajeva viveva da eccentrico, da pazzo, cacciato dalla famiglia. Il dir male di
tutti era la sua missione e la sua afflizione e castigo, poiché a poco a poco si
circondava di odi sempre più fitti e più forti.
Il 5 dicembre 1904 i parenti snidarono Menico Sajeva dal mezzalino del casino
Studio e Lavoro e lo fecero rientrare in famiglia, ma lui continuava ad
essere quello che era: sempre maldicente.
Con la sua Campana Menico Sajeva per più di un mese, ha frustato a sangue
il Giglia sia come uomo che come magistrato, ma il 12 gennaio 1905 si è tolta la
maschera. In carrozza, appositamente locata, per Girgenti è partito il sindaco,
il delegato Montalbano, Pasquale Andreoli e qualche altro, mezzani di codesti
negozi. Lì si era convenuto doversi trovare Menico Sajeva. Si fece una doppia P:
pace e pasticcio.
Ed ecco che un vilissimo maldicente, un volgare e incorreggibile denigratore,
che si vantava di carattere adamantino, di indipendenza assoluta, avido solo di
giustizia, scendeva senza saper perché all’abbraccio fraterno col suo denigrato
sindaco Giglia e suggellava l’atto complesso con l’agape cristiana.
Il commendatore Giglia, il caporione dei civili, il volpone, colui che teneva il
bastone del comando sugli armenti cornuti, attorniato da larga e poderosa
parentela e clientela, dopo aver taciuto, almeno in apparenza, dignitosamente,
ha dimostrato che il suo tacere non era stato atto di dignità umana, ma paura
mista a vigliaccheria.
Dopo un pugilato sanguinoso, senza scopo e senza conclusione, divennero
agnellini, si fiutarono, si leccarono e belarono insieme l’inno della pace.
A sera, tornando da Girgenti in Favara, tanto per celebrare come suol dirsi, una
grande messa solenne, tutti scesi dalla carrozza, in corteo magno, incluso
mastro Vannillo Sajeva, padre di Menico; hanno trionfalmente accompagnato a
piedi il sindaco sino alla porta della sua casa, offrendo un grazioso spettacolo
alla popolazione favarese.
Sebbene un atto sia stato eseguito in Girgenti, questa farsa è stata
rappresentata nel teatrino di Favara. Che cosa si è rappresentato? Un poema
eroicomico. Don Chisciotte montato sul suo gran ronzino detto La Campana del
Popolo, armato da un grande spadone, da molti scudisci, fruste e flagelli, è
apparso sublime e severo, ed ha menato colpi a dritto e a rovescio. “Ecco,
signori, guardate bene, la mia durlindana non rispetta nessuno, ferisce nel buio
e nel meriggio. Io sono il rivendicatore dei diritti del popolo, io sono il
severo esaminatore di tutti i pubblici uffici e di tutti coloro che governano ed
amministrano, dai più alti scalini fino alle ultime soglie, sono la vera oca del
Campidoglio. Dove vedo il male, grido a squarciagola e do l’avviso; dove vedo un
velo, che copre una piaga, lo spezzo e lo metto in chiaro; dove vedo una
combriccola di truffatori o di pubblici abusatori, sferzo a sangue e faccio
ballare senza volerlo ogni sorta di reo. Giudici di pace titolari e vice, regi
procuratori, signori che trafficano la giustizia, per me tutti si equivalgono,
li attacco, li svergogno e me li metto sotto i piedi. Io sono il vero erede
della Mancia moderna. Guardatemi, specchiatevi su di me, amministratori, e
tremate”.
L’uditorio di questa farsa aveva i suoi posti distinti e i suoi posti comuni. I
civili, i giovani, che erano la speranza e la forza, energia vera del paese,
erano burattini e quindi, nel godimento dell’eroico spettacolo, non si trovavano
che nel loro elemento, come il pesce nell’acqua e l’uccello nell’aria. Il resto
del popolo vero, del popolo lavoratore, che pagava, che non era corrotto fino
alle ossa, mirando le sciabolate di don Chisciotte, vedendo un sindaco, che
sprizzava sangue da tutte le carni flagellate, inarcava le ciglia, aspettava
l’effetto, il trionfo della giustizia ed invece non constatava che lo
scioglimento strano inaspettato dell’eroicomico dramma. Per incanto si sono
sanate le ferite, si è stagnato il sangue. Don Chisciotte ha deposto la
durlindana, ha abbracciato il sindaco e tutto è finito. La Campana del Popolo
di Favara dopo aver suonato col martello del terrore e della minaccia, ha
suonato con la carezza. Di punto in bianco, un desinando al Caffè Palermo, una
scenetta preparata da una combriccola, una stretta di mano ed è tutto finito.
Ecco la grande morale della favola!”.
Il popolo si sentiva sconvolto, non sapeva più giudicare, la logica era spenta.
Diceva il barone Mendola: "Nel mio paese ci sono burattini e marionette e, alla
testa, pochi Cagliostri e arruffapopoli che si arrabattono; un popolo numeroso
che soffre e geme.".
Il fine della buffonata fra Giglia e Sajeva in effetti non era la pace per la
pace, ma la pace per le elezioni. Quell’anno, infatti, erano previste le
elezioni amministrative di Favara e questo avvenimento faceva risvegliare certi
armeggi e certe persone, che non sapevano e non potevano vivere in pace, fra cui
i Valenti che agognavano ad ogni costo al recupero della vecchia fortuna e
stavano come i cani da caccia a fiutare le mosse della selvaggina.
Sajeva faceva bene il suo mestiere di mestatore e di pescatore nel torbido. Un
povero disperato, che cercava pane ed una tavola dove aggrapparsi in tutti i
casi di naufragio, era compatibile. Sajeva aveva tutto da guadagnarci e nulla da
perdere in questo indecente giochetto, ma Giglia ricco, forte nella sua
posizione, perché è sceso così in basso?; neanche il fratello Filippo, tornato
da Palermo, dov'era andato a rifarsi la dentiera, riusciva a persuadersi.
Questa pace è stata appresa e giudicata male da tutto il paese.
Il 18 gennaio 1905 in piazza Cavour tutti, con sorpresa, hanno goduto di due
scenette graziose: due lunghe passeggiate su e giù, dapprima fra Menico e
Calogero Valenti "u lungu", il fratello di Antonio, con cui parlava
furiosamente, e subito dopo col magno sindaco Giglia, con cui si scambiava
vicendevolmente perline d’amore, sorrisi e capriole. Si potevano indovinare i
sentimenti e le correnti contrarie di pensiero in tutti questi burattini che
rappresentavano le loro farse nel teatrino piazza Cavour?
Il 22 gennaio 1905 è uscito il n. 82 de La Campana del Popolo. Era un
pasticcio insipido, un catechismo repubblicano buttato giù dove non c’erano
repubblicani e dove il senso politico era semimorto.
Il Sajeva ha rivestito di stoppa il batacchio de La Campana del Popolo.
Nel mese di febbraio nei vari casini e circoli di Favara è stata inviata
anonimamente, in busta aperta, una caricatura mista a scrittura, una satira del
famigerato Menico, raffigurato come un pupazzetto appeso ad una corda, che
rinunziava alla Repubblica e si attaccava ad una carta da 100 lire proveniente
dal sindacato dei produttori di zolfo, per l’assicurazione degli operai contro
gli infortuni del lavoro.
Nel maggio 1906 il famigerato Menico Sajeva è stato costretto a far tacere la
sua Campana del Popolo. Gli stampatori non si prestavano, più perché
Sajeva non pagava e perché temevano le continue molestie delle querele. Però
Sajeva era un esplodente, che non poteva, né sapeva star quieto; non poteva non
esercitare la innata malvagità e, assieme ai girgentani commendatore Vitale
Cognata e avv. La Loggia, ha montato un nuovo giornale da ricatto intitolato:
Il Rinnovamento. Bel rinnovamento, c’erano i soliti articoli virulenti e
malvagi contro Valenti, contro il cassiere, contro il sindaco, il Consiglio
Comunale e Provinciale, contro il prefetto, etc.
Il famigerato Menico Sajeva faceva pure il libertino e lo scostumato. Nel giugno
1906 è andato via con la corista delle operettiste Rosa Bagiana, con cui
aveva avuto prima dimestichezza quando era studente in Girgenti. Mastro Vannillo,
suo padre, e i fratelli, appena saputa la partenza con un carrozzino, andarono a
raggiungerlo sul ponte S. Benedetto lungo la via Favara-Caldare. Dovettero
staccarlo dalla carrozza per ricondurlo in famiglia.
Dopo questo avvenimento Menico Sajeva è fuggito nuovamente da casa, in lotta coi
parenti e la famiglia, andando a spartire col delegato Filippo Montalbano gli
osceni e venderecci amplessi di una o due puttane coriste della compagnia
Montesano.
Pare che, nello scappare di casa, per seguire le sue coriste, Menico abbia preso
denaro dal padre o dagli acconti che l’Amministrazione dell’Assicurazione degli
Infortuni degli zolfatai gli teneva in deposito. Il padre lo seguì lungo la via
Favara-Aragona Caldare, più per ripigliarsi il denaro che per altri motivi.
Menico Sajeva poi è andato a vivere definitivamente in Francia, dove ha lasciato
le proprie spoglie.