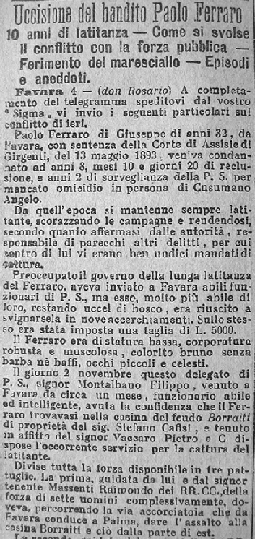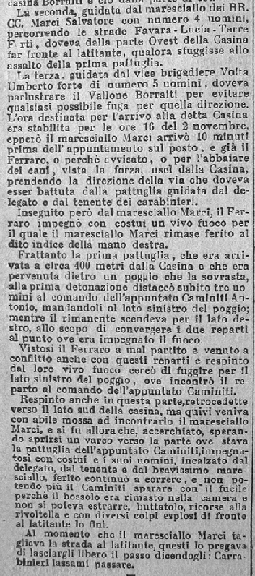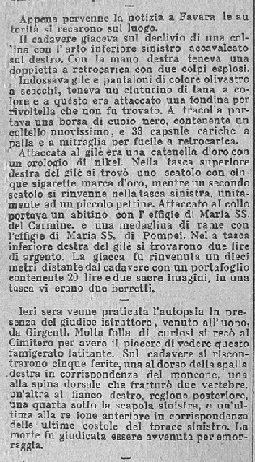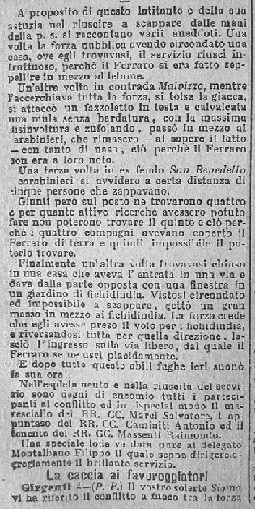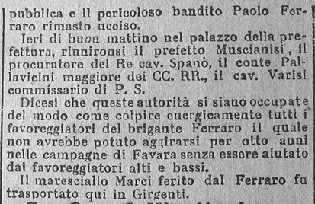Alletti Diego (inteso Nureddra)
Molestatore della quiete e della vita dei favaresi fu un bandito chiamato Nureddra. Di costui (racconta Salvatore Bosco: Favara le sue miserie, le sue disarmonie - Maggio 1989, Tipolitografia Moderna, Modica), non possiamo ufficialmente dire alcunché, se non quello che il filone tradizionale ci ha tramandato, forse veritiero o forse fondato del tutto o in parte sulla immaginazione dei favaresi. Pensiamo, però, che sopra quello che si è detto intorno a questo personaggio, ci deve essere l’una e l’altra cosa. Sentiamo, dunque, quello che ci viene fornito dalla tradizione e che per questa venne costruito in un lasso di tempo di circa un secolo e più. Di questo bandito non si conoscono antenati né paterni, né materni; sappiamo solo che quando la madre di Giuseppe e Onofrio Marchese litigava con delle donne vicine di casa, nell’impeto del dire le avvertiva dicendo: “Finitela di disturbarmi; sappiate che sono nipote di Nureddra”. Il che voleva significare che se quelle continuavano a disturbarla, reagiva con tutta la pesantezza propria di suo zio Nureddra. Non pare che costui si sia legato, o abbia capeggiato una banda stabile poiché risulta che compiva le sue prodezze quasi sempre da solo. E quando non aveva compagni, più che della forza fisica si serviva della sua efficace astuzia. Il suo scenario d’azione fu prevalentemente il territorio di Favara, e non si allontanò da esso se non quando aveva bisogno di vendere la merce rapinata. Spesso le refurtive erano costituite da animali singoli o a piccoli branchi come pecore, capre, buoi. Una volta imbattutosi per via con una grossa pattuglia di carabinieri, mentre guidava un piccolo branco di bovini per venderli a dei macellai in un paese vicino, a fine di evitare qualche domanda insidiosa cominciò a fingere di essere quasi disperato nel guidare da solo gli animalacci irrequieti. Indi, rivolto a quelli, - “Vedano, o signori” - disse - “com’è amaro il pane! Il mio padrone poteva almeno darmi un ragazzo per aiutarmi a guidare questi animalacci. Mentre cerco di metterne uno o due sulla via, un altro o altri due scappano fuori dall’armento e vanno a danneggiare il seminato dei campi. Ho un padrone senza cuore!” - “Pazienza, pazienza, buon uomo; cosa volete farci?” - gli risposero quelli, attribuendo sincerità alle parole del bandito. Un’altra volta, avvistato o conosciuto da alcuni compagni d’arme, nella campagna di Maragliano, scappò via di corsa; ma arrivato nella pianura detta Croce Viola, libera e senza anfratti, si vide perduto. Fortunatamente per lui, lungo la via c’erano alcune donne con sulla testa enormi fasci di stoppia. Ad un cenno da lui fatto a quelle sul pericolo che lo sovrastava, posarono a terra i fasci fingendo di riposarsi. E poiché lui era di dimensioni veramente piccole, una di queste se lo nascose sotto la veste, fra le cosce, ma in posizione seduta sopra una pietra. Immediatamente arrivarono le guardie a tutto sperone e domandarono alle donne se avessero visto qualcuno in atto di correre perché inseguito. “Si” - risposero; e la donna che lo teneva fra le cosce aggiunse: “Lo abbiamo visto correre precipitosamente da questa parte qua” - e indicava col braccio il sinuoso vallone che da quel punto scendeva giù verso la contrada di San Benedetto. Quelli vi si mossero al galoppo e Nureddra, raccattata la carabina che precedentemente aveva buttato tra le frasche. Il suo maggior campo d’azione ladresca era il Poggio di Serra Monello, dove, stando a quanto dice la tradizione, dovette consumare numerose rapine. La frequenza con cui venivano compiute fece, infatti, nascere un detto, assai significativo e occasionalmente ricordato: Cu passa di Muneddu e unn’è arrubbatu o chi Nureddra un c’è o è malatu.
Da Serra Monello, contrada tra Favara e Castrofilippo, passava l’antica via regia, denominata di funtana d’à (Fontana d’Angelo), la quale, prima che venisse costruito lo stradale nazionale 122, costituiva l’unico accesso, breve, che da Girgenti, e quindi anche da Favara, portava al grosso borgo agricolo di Canicattì, ricco di fiere, di commercio di animali e d’altri oggetti da mercato. Dato il posto di transito assai frequentato da commercianti e agricoltori, il poggio di Serra Monello dovette offrire al bandito Nureddra esca abbondante per le sue rapine. Stando ai due versi sopra riportati, che ne rilevano la losca attività, egli dovette aver consumato ripetutamente numerose e fruttuose rapine proprio in quel punto in cui la via si restringe ed è incastrata in un poggio roccioso sovrastato, al lato nord, da grosse pietre che offrivano abbondante schermo all’insaziabile ladro, nonché a quanti altri prima e dopo di lui amavano frequentare quel luogo per tenere attiva la loro natura ladresca.
Si racconta che quando era solo riusciva lo stesso a rapinare, in buon numero, i passanti, incutendo loro terrore con un trucco. Sistemava due o tre carabine fra le pietre, sostenute da finte braccia di pupazzi incappucciati, con le canne rivolte ai passanti, i quali, vedendole, pensavano che gli assalitori fossero in molti. In tal modo ingannava le vittime facendo passare loro la voglia di reagire mentre le spogliava del denaro e d’altri oggetti di valore. Era frequente il caso sino ad un cinquantennio fa che talune mamme, di fronte alle insistenti monellerie dei figli, sbraitassero contro di essi attribuendo loro le stesse qualità negative del fuorilegge Nureddra. “Si tintu comu Nuredda, figliu miu; u nn’haiu chi ffari!”.
A quanto scritto la Salvatore Bosco aggiungo una frase che da ragazzino sentivo dire a mio padre quando mio fratello faceva i capricci: “Nni sta facennu quantu Nureddra”. Oltre a quanto a noi pervenuto attraverso i ricordi degli anziani, a sua volta tramandato dagli anziani del loro tempo tramite aneddoti, storielle tra il reale e il surreale, nessuno mai è riuscito a dire, o meglio, a scrivere quanto di vero ci fosse in questo personaggio, ma soprattutto chi era o se fosse frutto della fantasia popolare. Tutto questo è rimasto avvolto nel mistero fino a quando, nel 2015, fra gli atti della madrice di Favara mi sono imbattuto nell’atto di morte di Nureddra, ma non era un atto come gli altri per via di quello che era stato annotato: Appeso alla forca per mandato del tribunale della R. Corte criminale assieme a Pasquale Romano di Baldassare e Giuseppe Sajeva di Gaspare, entrambi di Girgenti.
Ma chi era questo losco personaggio soprannominato Nureddra? Nome di battesimo Alletti Antonio Diego Giuseppe, nella vita chiamato Diego, era nato l’11 febbraio 1774 da Vincenzo Alletti e Anna Lauricella soprannominata Patacca. Catturato venne giustiziato l’8 ottobre 1808 per impiccagione ed il corpo tumulato nelle cripte della preesistente chiesa e convento di S. Francesco fuori l’abitato, abbandonata dai frati pochi anni dopo per via del forte lezzo dei cadaveri che in quella collina venivano portati durante le epidemie e spesso mal sepolti. Diego fu il primogenito di sette figli, in ordine di nascita, Maria, Pasquale, Giuseppe, Calogero, Antonio e Angelo. Quella degli Alletti era una famiglia di contadini e bovari, già presente a Favara nella seconda metà del 1600, con una discendenza ancora oggi presente a Favara. Diego il 27 agosto 1797 sposò Diega Matina, di nove anni più giovane, la quale due anni dopo la morte del marito, nel 1810, risposò Antonio Nona; nel 1819 Salvatore Caramazza e nel 1845 Calogero Piscopo. Da questi quattro matrimoni Diega Matina ebbe solo un figlio, nel 1802, da Diego Alletti, di nome Vincenzo, come il nonno. Vincenzo, come da tradizione, faceva il bovaro e il contadino, ma pare, anche, che abbia seguito l’inclinazione paterna in fatto di delinquenza. Nella notte del 21 dicembre 1838 è rimasto ucciso in un conflitto armato mentre, assieme ad una combriccola di malfattori, perpetrava un furto di 4.870 onze a danno di donna Maria Cafisi, moglie di Biagio Licata (nonno del principe Biagio), e Carmela Licata moglie del barone Riccardo Ricca (1). Per la verità l’atto di morte fra quelli della parrocchia, tanto meno in quelli anagrafici, è stato riscontrato, però, il fatto che l’ultimo figlio di Vincenzo sia nato nel giugno 1838, fa pensare che quell’anno Vincenzo sia morto. Nel 1824 Vincenzo Nureddra sposò Giuseppa Virone, da cui ebbe sei figli tra i quali due morti prematuramente. Gli altri quattro furono Diega che nel 1840 sposò Calogero Santamaria e nel 1846 Martino Messana dal quale ebbe nove figli; Salvatore che sposò Antonia Spanò da cui ebbe due figli; Onofrio che nel 1869 sposò Rosa Milioti da cui ebbe sei figli. Vincenzo, figlio di Salvatore e Antonia Spanò, nel 1888 sposò Giuseppa Fanara, da cui ebbe tre figlie. Di Onofrio Alletti e Rosa Milioti solo tre figlie presero marito: Giuseppa che sposò Gioacchino Lo Porto, Diega che Sposò Antonio Scalia, Antonina che sposò Gaetano Costanza. Di Vincenzo Alletti e Giuseppa Fanara le figlie: Antonia sposò Calogero infurna, Anna sposò Salvatore Biondo, Giuseppa sposò Calogero Patti.
(1) La combriccola di malfattori era composta da: Alaimo Domenico e Giuseppe, Alba Giovanni, Di Rosa Antonio, Fanara Pisciano Stefano, Picone Carmelo, Sanfilippo Antonio e Calogero, Randi Salvatore, Santosano Calogero, Zaffuto Gattamorta Antonio (tutti arrestati), La Rocca Paolino e Russello Baldassare (latitanti), Nureddra Vincenzo (ucciso).
Sajeva Domenico (inteso Vudiddrazzu)

Tra i briganti favaresi che si resero celebri per scorribande, azioni criminose, crudeltà e funeste conseguenze legate a delitti e ruberie perpetrate a danno di favaresi ed abitanti di paesi vicini sono da annoverare i due Domenico Sajeva, il primo tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800 e il secondo, inteso Vudiddrazzu, nella seconda metà del 1800 (foto a sx).
Il primo Domenico Sajeva nacque il 23 dicembre 1779, terzogenito di quattordici figli di Sguali Francesca (di Gaspare e Russello Agata) e del mastro muratore Delfio (di Domenico e Sciascia Caterina di Girgenti). La sua misera fine è stata annotata dallo storico agrigentino Giuseppe Picone, attingendo dal Di Blasi, nelle sue "Memorie storiche agrigentine", dove si legge: "Girgenti, intanto e i suoi dintorni erano infestati dalla famigerata banda di Favara, capitanata dai fratelli Sajeva, la quale fu distrutta pel senno e l'opera del nostro girgentino cav. Gerlando Bianchini." Lo stesso autore aggiunge che Bianchini consegnò la banda al patibolo nel 1808 e che la relazione fu scritta dal figlio del Bianchini: Sebastiano. Come riferisce Salvatore Bosco nel suo libro: Favara le sue miserie e le sue disarmonie, il nipote di Gerlando Bianchini, prof. Sebastiano, aveva consegnato un voluminoso carteggio di famiglia allo scrittore Luigi Pirandello, il quale, studiandolo, ne derivò il noto romanzo "Vecchi e giovani".
Intorno al 1875 apparve a Favara un’altra banda, capeggiata dal secondo Domenico Sajeva inteso Vudiddrazzu.
Di questa banda, all’atto della sua cattura, avvenuta il 26 giugno 1876, i componenti erano una mezza dozzina, fra cui: un certo Zaffuto, un certo Varisano, un altro di nome Baldacchino e Calogero Tedesco inteso Peppi u Strazzatu.
Secondo la testimonianza orale di discendenti di Vudiddrazzu, annotate da Salvatore Bosco nel suo libro: Favara, le sue miserie e le sue disarmonie, il Sajeva in argomento lavorava come intagliatore di pietre nella costruzione del palazzo di Salvatore Fanara in piazza Cavour. All’inizio dei lavori, quando si stavano per gettare le fondamenta, lì compì un omicidio che gli fu causa della totale perdizione. Nel racconto non venne aggiunto altro, tranne che quel suo parente era di natura collerica e che tale componente psicologica facilmente lo portava a farsi inimicizie.
Intorno agli anni "30 del XX sec., allo scopo di fornire certi servizi ai pianterreni del palazzo, si dovette scavare accanto al muro perimetrale, nell’angolo dove si incrociano via Belmonte e piazza Cavour e ad una considerevole profondità venne trovato uno scheletro umano. Giustamente si pensò che l’occultamento del cadavere in questo punto dovette avvenire durante i lavori di costruzione del palazzo, mentre si gettavano le fondamenta e a ben ragione si pensò a Vudiddrazzu.
Non sentendosi poi del tutto sicuro, il Sajeva si diede a menare una vita semiclandestina, a metà strada tra la criminalità e la irreprensibilità. Avendo finito di lavorare, aveva bisogno di vivere e quindi facilmente si rendeva molesto facendo insospettire forza pubblica e privati. Questa posizione del Sajeva collimava con quanto dichiarato dal comandante della zona militare di Girgenti, nella commissione dell’inchiesta parlamentare del 1875: Altra banda è comparsa da cinque o sei mesi fa, di un certo Sajeva, fabbro da Favara; questo qui era un bravo operaio figlio di un capomastro che lavorava molto e che faceva bene il fatto suo in famiglia; ma piuttosto facinoroso e sanguinario come si vede, dedito ai reati di sangue. Io credo che non abbiano potuto provare gran cosa sul suo conto da mandarlo al tribunale. Credo che fu condannato al domicilio coatto come già ammonito prima; insomma questo qui con tre compagni era in traduzione per condurlo alle isole, scappa di mano ai carabinieri, torna in paese coi compagni e in quattro si aggregano a due o tre altri borbonici, ma la banda non fu mai numerosa, e non sarebbe stata possibile neanche un giorno se i signori di Favara l’avessero voluto.
Si capisce facilmente che esisteva una sorta di compromesso coi favaresi, perché questa gente non toccava mai nessuno di Favara; i loro reati li consumavano nei Comuni di Grotte, Racalmuto e Canicatti, sino a Licata e Girgenti e se toccavano qualcuno di Favara era per fare vendetta per conto di qualche altro. Questa gente si era acquistata fama con l'omicidio di tre pecorai, senza una ragion d’essere, solo per affermarsi, incutere terrore e poter vivere sicuri in campagna. Hanno cominciato con tre omicidi, poi hanno svaligiato una corriera, poi hanno fatto ricatti con lettere di scrocco in quantità, mai denunziate. Risulta probabile che un certo tipo di rapporti con signori facoltosi ed influenti del tempo gli permetteva di trovare nei vari feudi un sicuro asilo ove nascondersi.
Il campiere ed il robettiere del feudo Donato, di proprietà del barone Mendola, furono arrestati con l’accusa di aver dato ricovero ai due importanti latitanti di Favara, Sajeva Domenico e Todaro Calogero e per complicità nel sequestro di Palizza Calogero. Negli atti della Prefettura indirettamente si evince che dopo l’omicidio del palazzo Fanara per il Sajeva non scattò del tutto la vita della latitanza e meno ancora quella della banda, circostanze che si realizzarono dopo.
Il 26 giugno 1876 la banda alloggiava nel casino del barone Ceraulo, in contrada Tamburello, nei pressi di Bonamorone. Certuni che si sono occupati della vicenda Sajeva, il merito della cattura della banda lo hanno attribuito al prefetto Malusardi che lo stesso anno dal governo nazionale aveva ricevuto pieni poteri allo scopo di eliminare bande e mafiosi in Sicilia, ma le cose pare siano andate diversamente. Delfio Sajeva, nipote di Vudiddrazzu, quando seppe che verso il 1923 venne graziato l’unico superstite della banda, cioè Calogero Tedesco, lo volle intervistare allo scopo di sapere quancosa di suo zio e fra le altre cose gli raccontò che le forze dell’ordine vennero a conoscenza della presenza della banda nel casino del barone Ceraulo. Era il mattino del 26 giugno 1876; verso le ore otto il rubettiere, cioè l’impiegato del barone, si recò a Girgenti per fare la spesa. Al ritorno la moglie lo informò che i banditi, uno dopo l’altro, l’avevano disonorata. L’uomo offeso, fingendo di aver dimenticato di comprare il formaggio, superando le insistenze di quelli che si dicevano disposti a mangiare senza questo condimento, salì di nuovo in città ed avvisò questura e carabinieri della presenza della banda nella casina del barone. Dopo circa mezz’ora arrivarono una trentina di militi che, circondata la casa, intimarono alla banda di arrendersi, ma questa rispose con il fuoco. Nella sparatoria ci fu un morto ed un paio di feriti non gravi, fra cui lo stesso capo Sajeva.
Nel 1878 iniziò a Palermo il processo a Domenico Sajeva e ai suoi gregari e manutengoli. Gli avvocati di questi ultimi con un'abile mossa riuscirono a far separare il processo dei loro clienti da quello dei briganti, nel tentativo di recuperarne l'immagine agli occhi della Corte e quindi averne l'assoluzione o almeno pene ridotte. Di ciò si accorse il prefetto di Palermo, che informò al ministro Depretis.
Sajeva fu processato e condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Palermo. I manutengoli Celauro e Trainiti ebbero invece pene meno severe. Il Giornale di Sicilia nell’autunno del 1878 ha riportato il resoconto del processo.
Il processo Sajeva fu accompagnato da processi altrettanto importanti a bande di briganti sia della Sicilia occidentale (processi di Corte d'Appello di Palermo) che della Sicilia orientale (processi di Corte d'Appello di Catania), che si conclusero tutti con pesanti condanne. Essi rappresentarono la sconfitta momentanea del brigantaggio. "Il brigantaggio classico è finito definitivamente" scrisse successivamente il commissario Alongi, ma non la mafia in guanti gialli che ne era uscita più o meno indenne.
I componenti della banda Sajeva morirono tutti in carcere. L'unico a sopravvivere fu Calogero Tedesco, soprannominato Peppi u Strazzatu che rivide la luce della libertà dopo circa 47 anni.
La tradizione ci ha presentato costui come l’uomo più crudele e spietato di quanti altri banditi favaresi operarono a Favara contro le regole del vivere civile. Le sue prodezze nel compiere delitti vennero accompagnate, spesso, da un’altra attività che apparentemente non ha nulla a che fare con la morale e con la giustizia, vale a dire quella di fare la parte del pronubo. Questa sua speciale attività gli fruttò quattro famosi versi di ignoto autore, i quali nei primi del 1900 venivano continuamente canticchiati dal popolo, ma più dai ragazzi. L’autore di essi domanda ad una certa Pippinedda chi le aveva imposto il marito, e lei non nascondeva d’essere stato Peppi u strazzatu. I quattro versi erano:
“O pippinedda, cocciu di granatu, Cu ti lu detti stu beddu maritu?”
“Mi lu detti Peppi lu Strazzatu Chiddu ch’è ccarzaratu a Santu Vitu.
Alcune persone, che lo avvicinarono dopo mezzo secolo di galera, gli sentirono confessare: Ordii tante di tragedie quand’ero giovane che meritavo davvero tutto questo tempo di carcere!.
Una tradizione viva fino a qualche decennio addietro gli addebitava altre prodezze, fra le quali quella di aver rapito una fanciulla in una fattoria del barone Giudice e, dopo averla stuprata per alcuni giorni, la lasciò libera.
Uscito di galera a ben ottant’anni suonati, alcuni lontani parenti fecero ricoverare Calogero Tedesco al Boccone del Povero. Un giorno, era il 10 giugno 1925, mentre pascolava alcune caprette delle suore nelle vicinanze del convento dei Frati Minori, si mise a dormire sotto un carrubo, ed in questo frangente venne pugnalato e ucciso.
Per quanto riguarda la discendenza di Calogero Tedesco e Domenico Sajeva nessuna menzione viene fatta nella documentazione bibliografica finora prodotta, perciò è stata effettuata una ricerca negli atti parrocchiali di Favara e da questa è emerso quanto segue:
Calogero Tedesco non compare negli atti di nascita e di morte. Un solo Calogero Tedesco si rileva nel registro dei matrimoni, per avere sposato Carmela La Rocca il 15 ottobre 1871, da cui sono nati Paola nel 1872 e Paolo nel 1874. La banda compare intorno al 1875, per cui potrebbe essere la persona cercata, ma non vi è certezza.
Per quanto riguarda Domenico Sajeva, l'unica data di nascita riferibile al nostro personaggio è il 14 dicembre 1851 (nel 1875 aveva 24 anni) ed i genitori erano Salvatore (muratore) e Anna Bennardo. Il nipote che ha raccolto le informazioni si chiamava Delfio ed anche Domenico (ultimo di sei figli) aveva un fratello, uno zio e un bisnonno di nome Delfio.
Per quanto riguarda un eventuale rapporto di sangue fra i due briganti Sajeva, dalla ricerca esce la verità curiosa e inquietante che di seguito si ricostruisce.
Sajeva Domenico
Vudiddazzu (2° brigante) ☼14 dicembre 1851 scalpellino↓
Sajeva Salvatore
☼11 4 1809 muratoreBennardo Anna ☼17 5 1812
↓
Sajeva Calogero
☼23 12 1779 muratore (fratello del 1° brigante Domenico)Zambito Carmela
☼25 7 1787↓
Sajeva Delfio
☼1747 muratoreSguali Francesca
☼21 4 1759↓
Sajeva Domenico
Sciascia Caterina
(di Girgenti)
Dalla ricostruzione genealogica e in relazione a quanto sopra detto, ne discende che il 1° brigante Domenico Sajeva era fratello del nonno del 2° brigante omonimo, cioè Vudiddrazzu.
Potrebbe a questo punto, concludersi la relazione con la frase:
buon sangue non mente.
Ferraro Paolo
All’inizio del 1900 il numero dei prusucuti, ossia latitanti perseguitati dalla giustizia, sparsi nelle campagne, che vivevano da signori, che comandavano e tutti dovevano ubbidire, tutti dovevano pagare, era cresciuto a dismisura, quale non era stato mai da 30 o forse 40 anni prima.
Non si era più sicuri della vita e della robba. Intimavano ricatti ai capi mastri ed agli esercenti di zolfare. Attanagliavano ogni sorta di persona, dal proprietario al borghese, al piccolo contadino. Guai a chi si rifiutava! Spedivano lettere di scrocco e di minaccia, firmandosi sfacciatamente con orgoglio e comando. Spillavano denari a capi mastri, anche a coloro che passavano nella mafia per pezzi da rispettarsi.
Questa idra insaziabile del malandrinaggio, appena metteva fuori branche polipose, cresceva tosto a dismisura, turbava, avvelenava la società, la pace pubblica, le persone, le cose.
Alcuni anni fa si raccontava che un certo Calogero Ferraro era stato costretto ad ammazzare una persona e che il fratello Paolo gli abbia fatto compagnia, però senza fare uso di armi.
Dalla Corte d’Assise di Girgenti, il 28 giugno 1887, Calogero venne condannato a 18 anni di lavori forzati.
Tradizione vuole che Calogero, non si sa dopo quanto tempo, sia riuscito a fuggire con altri detenuti da un cunicolo praticato nella latrina comunicante col mare. Sempre secondo la tradizione, pare che, con l’aiuto di un amico calabrese abbia trovato lavoro presso un latifondista, a cui fu presentato sotto falso nome.
Dopo tanti anni volle dare notizie di se alla madre, scrivendo ai padrini, i quali essendo analfabeti, fecero leggere la lettera dal sacerdote Virone “Carcareddu”, il quale avvisò i carabinieri di Favara. Detti Carabinieri, a loro volta, diedero notizia alla polizia vicina a quel paese, la quale provvide alla cattura dell’evaso.
Dopo un numero imprecisato di anni Calogero Ferraro morì e di lui non si disse più nulla in paese.
La rottura di Paolo con la Giustizia avvenne tra il 1890 e 1892, dopo la condanna a 8 anni, 10 mesi e 20 giorni di carcere, oltre a 2 anni di vigilanza speciale per mancato omicidio in persona di Angelo Cusumano.
Un cronista ebbe modo di tratteggiare la figura di Paolo Ferraro, descrivendolo come persona bassa, robusta e muscolosa. Paolo passò 10 anni alla macchia, durante i quali ebbe undici mandati di cattura ed una taglia di 5000 lire.
Ma chi erano questi Ferraro? Calogero e Paolo erano figli di Giuseppe e Giuseppa Signorino. Calogero è nato il 28 giugno 1859, mentre Paolo il 25 dicembre 1870.
Paolo Ferraro, a differenza di tanti altri fuorilegge vissuti nella campagna in epoche diverse, non fu pretenzioso tanto da attirarsi odio e suscitare trame contro la sua libertà e la sua vita, anzi, stando a ciò che la tradizione dice, fu protetto e aiutato da amici, presso i quali trovava spesso ospitalità e protezione (come ad es. Gabriele Dulcetta, che a seguito di una vicenda legata a Ferraro fu trovato morto – si dice, per suicidio).
Intelligenza, astuzia e snellezza permisero più volte a Paolo Ferraro di schivare la cattura. Una volta scrisse superbamente su una pietra “Pi pigliari a Paulu avi a essiri cchiù chi diavulu”. Un’altra scritta comparve accanto: “Quannu arriva l’ura, Paulu si piglia senza paura”.
Intorno al mese di febbraio 1902 Gabriele Dulcetta, conversando col suo amico tenente dei carabinieri, gli ha detto: “Come mai voi, che ignorate il dialetto e non conoscete le persone, potete mai sperare di arrestare Paolo Ferraro?”.
“Ci abbiamo la fotografia” rispose il tenente.
Gabriele era amico e manutengolo di Ferraro. Una volta invitò il tenente nella sua casina della Misita e fece in modo che, mentre si pranzava, arrivasse, ben vestito, un cavaliere sopra una bella giumenta: Paolo Ferraro, già informato di tutto. Infatti arrivò, scese, salì al casino, si abbracciarono e si baciarono con Dulcetta. Il Dulcetta voleva farlo rimanere a pranzo. Anche il tenente rinforzava le preghiere del Dulcetta, ma egli si rifiutò. Il Ferraro prese un boccone ed un bicchierino di vino, e subito rimontò in sella e sparì.
Dopo qualche tempo il Dulcetta disse al tenente: “Ebbene, con tutta la fotografia che tenete in tasca, non avete saputo ravvisare il Ferraro?!”
“Quale Ferraro?” disse il tenente.
“Paolo Ferraro” rispose Dulcetta.
Il tenente, come inebetito: “Ma dove?”
Dulcetta rispose: “Quel gentiluomo, che bevette con noi un bicchierino di vino alla Misita era appunto Paolo Ferraro”.
Il tenente montò su tutte le furie e disse: “O mi fate avere in breve tempo Ferraro nelle mani o io arresto voi, i vostri impiegati e parenti”.
Il 24 settembre 1902 una spia fidata ha riferito alla giustizia che Ferraro stava ammalato (si diceva di palpito di cuore) in casa di un certo “Granvillano”. Verso le 11 antimeridiane soldati e guardie circondarono una larga cinta di case nel quartiere S. Vito, nel cortile Bentivegna (“i setti curtiglia”). Anche questa volta Pauliddu scappò dalle unghie della forza dell’ordine. Nella giacca, di cui s’impadronì la giustizia, furono trovate circa 500 lire.
Nella casa della sorella di questo brigante c’era gran ressa di popolo. Era il culto del popolo, fradicio fino al cervello. Questi capi banditi nella fantasia del popolino tutto imbevuto di mafia, rappresentavano gli eroi, i santi.
La sera del 3 novembre 1902 è arrivata la notizia eclatante, inaspettata, clamorosa sulla morte di Paolo Ferraro.
Tra le 4,30 e le 5,30 le fucilate piovvero come in un campo di battaglia a Burrainito. Il Giornale di Sicilia, n. 307 del 3-4 novembre, tra le prime notizie, ha riportato la vicenda e nel n. 309, 5-6 novembre (v. estratto del Giornale di Sicilia riportato a fianco) è stata fatta la particolareggiata descrizione del conflitto e dell’uccisione del prusucuto.
Un altro resoconto dell’uccisione è stato pubblicato nel n. 8 de La Campana del Popolo del 23 novembre 1902.
|
|
|
Lombardo Francesco (Cicciu Ummardu)

Lombardo Francesco (n.14 marzo 1896 - m. 30 luglio 1921) figlio di Antonio e Carmela D'Angelo.
Meglio conosciuto come Cicciu Ummardu, Francesco Lombardo discendeva da famiglie piuttosto agiate e presenti a Favara già nei primi del 1600.
Un destino inesorabile, però, travolse questo giovane trascinandolo nella rovina. Faceva il falegname e lavorava bene, quando il vice commissario di P. S. Mario Caso, dovendo compiere delle indagini sopra un incidente, credette opportuno interrogare lui e i suoi fratelli. Mentre, però, Michele, Antonio e Giovanni furono sentiti una sola volta, sopra Francesco il commissario insistette; ma il giovane, richiamato nel suo ufficio forse per la quarta volta, non solo si rifiutò di comparire ancora dinanzi al funzionario, ma si diede alla macchia. Il fatto accadde nella primavera del 1914 e segnò l’inizio del primo periodo di latitanza.
Tra il febbraio ed il marzo del 1917, nonostante l’interessamento dei suoi fratelli Michele ed Antonio, e l’aiuto di un amico, riacquistò la libertà.
Subito dopo la ritirata di Caporetto, nell'ottobre 1917, venne chiamato alle armi e mandato al fronte con le reclute del 1899. Là si contagiò gli occhi di tracoma ed ottenne di essere riformato.
Nell’aprile del 1918 si fidanzò con Assunta Airò Farulla e il 18 maggio dello stesso anno fecero solenne promessa di matrimonio in chiesa.
Ma il destino sembrava essergli avverso e all’inizio del 1919 altri avvenimenti lo travolsero e perdette la libertà una seconda volta. Ebbe inizio il secondo periodo di latitanza che si concluse con la morte per strangolamento. La tragedia ebbe luogo la notte del sabato 30 luglio 1921, in una campagna non lontana dal paese, esattamente 24 ore dopo che consumò l’ultimo omicidio, nella contrada Monzù, di un giovane, al quale aveva reciso le orecchie. Cicciu Ummardu si decise ad eliminare questo giovane, perché si serviva del suo nome per estorcere denaro a favaresi più o meno facoltosi.
Appena strangolato il cadavere di Cicciu Ummardu fu nascosto in una profonda fossa sotto un albero di pistacchio.
La domenica del 31 luglio passò tranquilla; ma il lunedì 1 agosto le tragedie divamparono con maggior virulenza dei giorni precedenti. Quel lunedì, infatti, fu contrassegnato da ben quattro omicidi, due dei quali legati alla vicenda Lombardo, fra cui Michele, fratello di Cicciu, il cui corpo venne ritrovato, dopo 47 giorni, in un pozzo asciutto, profondo pochi metri, nella tenuta della Pirciata, di proprietà di don Vincenzo Giudice.
Testo tratto da: Salvatore Bosco, Il Proletariato a Favara - lotte, scioperi ed altre manifestazioni dal 1890 al 1960, Ediz. Sicilia Punto L, Ragusa.