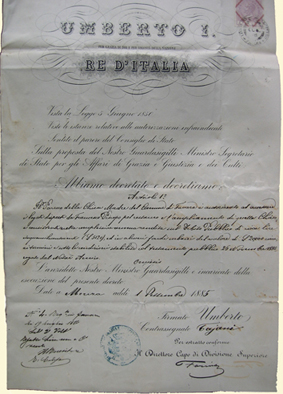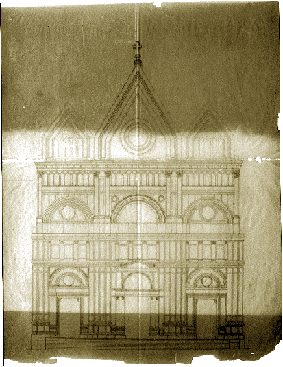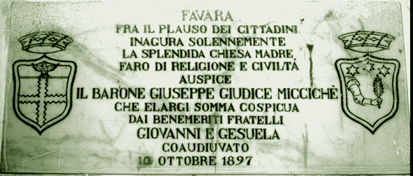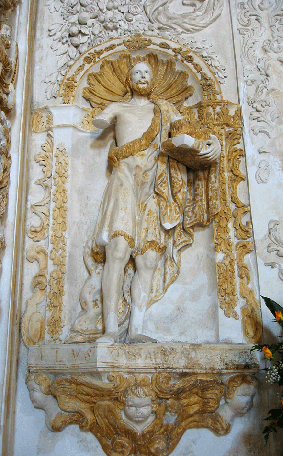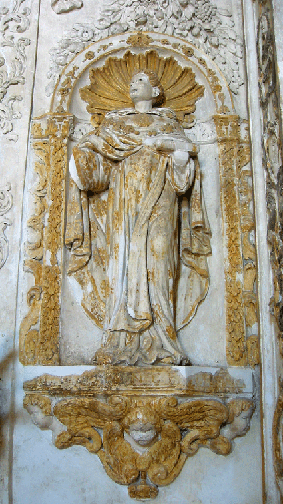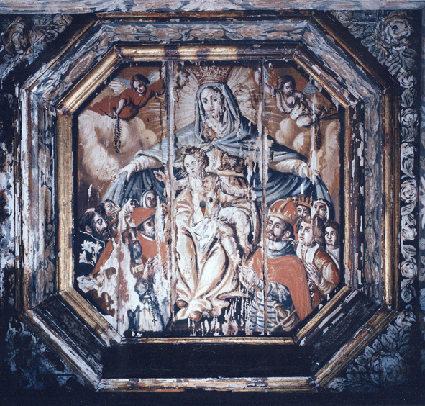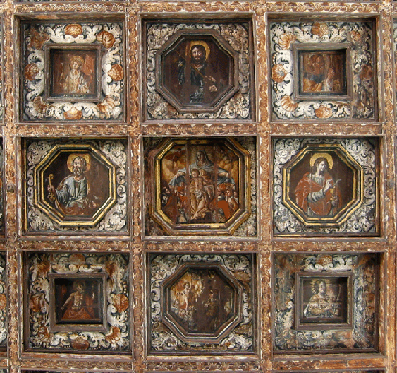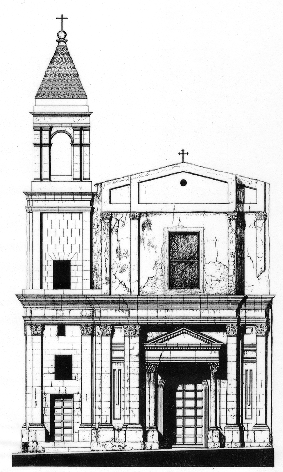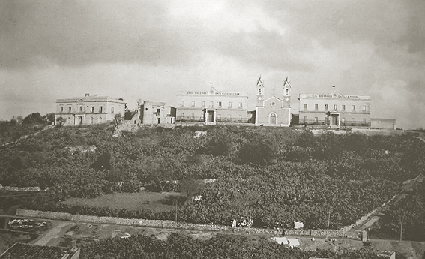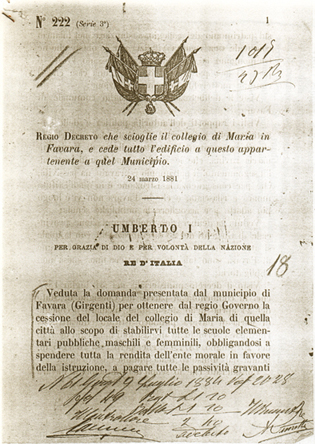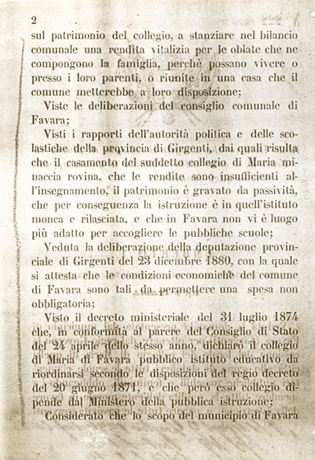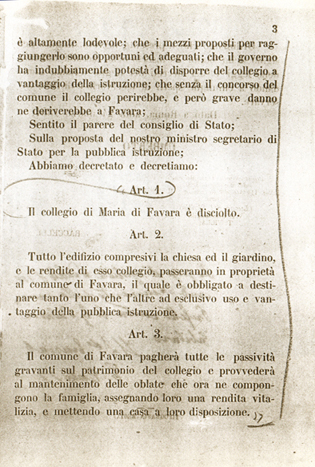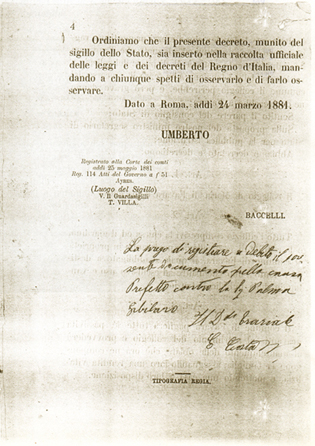Il barone ha dovuto tenere forte ed essere
duro; ha risposto: “La ringrazio assai; la prego, per favore, non
parlarmi di queste cose; non verrò mai, né ora, né in appresso; mi
risparmi sofferenze, mi perdoni se sono così scompiacente ed agreste”.
L’8 luglio 1899 la superiora lo ha nuovamente invitato nella casina di
Fontana degli Angeli di donna Momma, sorella del barone, per partecipare
ad una scampagnata delle orfanelle; ha risposto che era cosa difficile.
Il 1 agosto 1899 il vescovo Lagumina ha visitato l’orfanotrofio. Le
orfanelle hanno recitato una commovente chiacchierata. Facevano,
s’intende, l’encomio al nuovo pastore diocesano ed un pochino hanno
toccato il barone, piangendo commosse. Monsignore era impassibile, quasi
annoiato e scherzerellava su tutto e non vedeva l'ora di andarsene. Suor
Gennarina disse al barone: “Quanta differenza, come variano i tempi!
Due anni fa mons. Blandini, ora mons. Lagumina”. Avanti alle altre
suore non mi poteva dire di più; ma il barone ha compreso, ha pesato
tutto il valore occulto di quelle parole, sgorgate dal suo petto.
Il 17 settembre finalmente ha visitato le orfanelle, le quali gli hanno
fatto grata e festevole accoglienza.
Il 24 novembre, col bel sole e con l’aria tiepida, verso le 15,00 è
andato nuovamente dalle orfanelle per visitarle de per fare la prima
prova fotografica su di loro. Di fotografia aveva cominciato ad
occuparmene già dal 1863, con metodi allora assai difficili.
Il 30 novembre 1899 il barone ha deciso di fabbricare sul dormitorio
delle orfanelle un altro dormitorio superiore. Alla fine del mese di
gennaio 1900 ha incaricato l’impresa ad Antonio Castronovo di preparare
la pietra a S. Francesco per il nuovo dormitorio.
La domenica del 18 marzo 1900 le orfanelle sono ritornate in casa del
barone Mendola per vedere la discesa dei santi. La verità sembrava
trionfare. La superiora era rinsavita. Si erano dissipati i dubbi e le
calunnie della maldicenza. Giorni prima il barone avevo fatto sentire
alla superiora, indirettamente, che lui non invitava; ma che la mia casa
e il mio cuore erano sempre disposti ad accogliere le orfanelle.
Il 5 aprile 1900 si sono cominciate le fabbriche del nuovo dormitorio,
con Carmine Airò e per spaddaloro (mastro aiutante), suo cognato Peppe
Lo Porto coi rispettivi manovali. Il cattivo tempo si avvicinava.
Il 26 aprile 1900 sono andato nell’orfanotrofio per vedere lo stato
delle fabbriche ed il lavoro nel nuovo dormitorio. Le suore, e
soprattutto le orfanelle, mi hanno fatto festa: una festa innocente. Ne
ho ricavato sollievo per il mio povero spirito. Queste ore di diletto
intimo mi ripagavano delle spese che avevo sostenuto. Era benedetto
Iddio, che tra i guai che amareggiavano la mia vecchiezza, mi concedeva
queste gioie somiglianti a gaudi di paradiso.
Il 20 maggio 1900 sono venuti mastro Giacomo La Russa con un parente di
mastro Antonio Amico, pregandomi di fare entrare nell’orfanotrofio delle
bocconiste la piccola delle due figlie di detto mastro Antonio, orfana
di padre e di madre, sola, abbandonata, anzi, reietta da tutti.
Il caso muoveva a pietà, ma io non avevo forza di pagare le spese per
l’accrescimento delle orfanelle sulle mie spalle che già erano 41, oltre
le suore e il culto della chiesa.
Il 22 maggio, per la forte pioggia, un pezzo dell’orfanotrofio, che si è
trovato scoperto, si è inumidito nel soffitto del sottostante
dormitorio. Il tetto è stato tutto coperto e integolato.
Il 28 maggio sotto la pioggia si è coperto il corridoio di passaggio,
che dalla scala del quarto delle suore, conduceva al nuovo dormitorio.
Proprio la pioggia mi ha inquietato durante questa costruzione, nel
coprire i tetti. Così avvenne, nel piccolo e grande corridoio e nel
dormitorio.
Il 31 maggio 1900 la volta del piccolo corridoio era quasi finita e, nel
frattempo, si è cominciata quella del grande corridoio.
Il 2 giugno, mentre l’asino e infingardo manovale Antonio Sajeva di
mastro Delfio, scaricava sul ponte o palco del corridoio piccolo
dell’orfanotrofio la gavita di calce, per intonacare i muri, non sapendo
ben portarla e ben scaricarla, me la rovesciò addosso, giusto mentre io
passavo sotto il ponte. Mi colpì la falda del cappello e mi riversò
l’impasto addosso; sicché ci ho perduto il vestito nuovo d’inverno
leggero fattomi a marzo dal mio sarto Albergamo. La calce l’ha fatto
ingiallire e cangiar colore. Meno male che non ci ho rimesso il cranio.
Il 9 giugno risultava finito l’intonaco esterno della facciata del nuovo
dormitorio e quasi un terzo dell’interno. Si sono levati i ponti
esterni. Erano già collocate finestre, balcone e usci. Rimaneva la
pavimentazione e l’altra mano d’intonaco anche nel corridoio e
l’imbiancamento.
Il 12 giugno è stato cominciato l’ammattonamento.
Il 13 agosto si è iniziato l’allattamento o imbiancamento del tetto e
delle pareti del corridoio e del dormitorio nuovo delle orfanelle, con
calce della mia fornace, non avendo potuto averne altra buona da
Sciacca.
Il 1 settembre si è finito di dipingere finestre ed usci nel nuovo
dormitorio e corridoi dell’orfanotrofio.
Il 12 ottobre si sono alzati i ponti per collocare le palle sulle
piccole cuspidi di campanile e pinnacoli in centro e in alto. La pietra
cosiddetta di Ciccione ha fatto cattiva prova. In pochi anni si è
logorata, ha crepato ed è caduta giù, producendo guasti ai tetti, ai
muri e minacciando pericolo alle persone. È stata buona ventura che
nessuno sia stato colpito dai frantumi.
I pinnacoli vecchi, già fiaccati e distrutti, erano stati scolpiti da
Stefano Russello del fu Gaetano e messi al posto il 18 maggio 1889.
Questa data era incisa sulla pietra della base, levata il 12 ottobre.
La mattina del 13 ottobre, alle ore 7, si alzarono nuvoloni da tutte le
parti, maggiormente dal mare di mezzogiorno, che minacciavano tempesta.
Alle 9 si ripresero i lavori e i manovali ripigliarono l’alzatura del
ponte sui campanili della chiesa delle bocconiste. Alle 3 si riannuvolò
nuovamente il cielo, ma poi schiarì. Il lunedì del 15 ottobre la
giornata passò liscia, senza le temute piogge e tempeste. L’aria era
fredda. Era il vero principio d’inverno. Si è collocato il pinnacolo del
campanile dell’orologio e si è dato mano a scendere le travi del ponte
per riaccomodare e alzare l’altro nel vicino campanile il giorno dopo.
Il pinnacolo l’ho lasciato neutro, cioè col colore naturale del piombo,
perché stava bene e in armonia con la croce, pure di piombo. Il 16
ottobre c’erano poche nuvole, ma l’aria era fredda e verso le 10 c’era
un vento forte, che ha fatto scendere i muratori che accomodavano il
ponte nel campanile delle campane e del calendario, perché a
quell’altezza non si poteva resistere all’impeto del soffio. Il 19
ottobre finalmente si sono messi i pinnacoli e le palle e si è sceso il
ponte.
Il 18 Ottobre 1900 ho visitato p. Mammana e abbiamo parlato del modo
come organizzare alla meglio il futuro dell’orfanotrofio di Favara.
Manifestai la mia intenzione di erigerlo in ente morale. Con i
bocconisti non sapevo raccapezzarmi; volevano e disvolevano ogni
momento. Un giorno si proponeva, anzi proponevano loro stessi un
progetto e il giorno dopo ne vagheggiavano un altro.
P. Boscarino nel 1898 mi aveva fatto uscire dai gangheri, poiché, al
momento stesso del mio consentimento ad una sua proposta, si smentiva,
recedeva, metteva avanti altre difficoltà, altri progetti. P. Mammana
invece voleva che io cedessi la casa di Favara al Comune, per evitare le
tasse di successione e assegnassi una rendita affinché il Comune stesso
curasse le orfane sotto il governo delle bocconiste, con tutte le
clausole legali atte a mantenere la perfetta osservanza dello scopo. Se
la cosa poteva essere attuabile, a me non dispiaceva questo sistema.
Nel mese di gennaio 1901 è venuto a Favara il superiore generale e non
ha voluto che io perseguissi i procedimenti per ottenere l’entità
morale, ma che cedessi al Comune di Favara i locali.
Il 20 gennaio sono andato dalle bocconiste per la celebrazione, a mie
spese, delle 40 ore. Ho preso il liquore La Ville per la podagra e poi
in carrozza sono andato nella chiesa delle bocconiste.
C’era un affollamento straordinario. C’erano tutti i francescani. Prima
della predica, davanti la porta della chiesa, p. Alfonso ha benedetto il
paese. Il sacramento stava di rimpetto a tutto il paese e questa
benedizione, in un sito così eminente e santo, diventavava imponente e
sublime.
Una lava di popolo gremiva il piano. Rientrato p. Alfonso ha poi
benedetto le orfanelle, le suore ed anche il pio fondatore. Io, per
naturale rossore, mi sono nascosto dietro un pilastro. Chi avrebbe
potuto prevedere tutto questo? Quanto dovevo essere grato a Dio di
essersi servito della mia povera persona per compiere questa santa opera
e per vederla fiorire per come fioriva. Io non lo avrei sognato giammai.
Erano miracoli, erano doni della Provvidenza.
Il 21 febbraio 1901 ho scritto una lettera al reverendo Mammana,
superiore dei boccononisti, dicendo che non avevo parlato al sindaco per
la cessione dei locali dell’orfanotrofio. Avevo una doppia ripugnanza,
soprattutto perché il sindaco, nelle cose di beneficenza, non mi era mai
stato favorevole, oltre a dubitare molto sulla legalità dell’atto e
della sua curabilità. Io invecchiavo sempre più e dovevo pensare presto
a sistemare l’avvenire dell’orfanotrofio. Ho pregato il reverendo
Mammana, prima di dare corso alle trattative col sindaco di Favara, di
consultare la faccenda con qualche bravo avvocato.
Il p. Mammana ha risposto alla mia lettera che, dopo le informazioni
assunte, la via di legare l’Orfanotrofio all’Amministrazione di Favara
non era percorribile.
Nel mese di aprile 1901 ho cominciato a soffrire i primi dispiaceri per
atti poco corretti della superiora Gennarina.
Mandava continuamente da me i parenti delle orfanelle, che bussavano
alle porte dell’orfanotrofio per entrarci. Il no lo faceva dire sempre a
me. Poi, quando ad essa pareva e piaceva, faceva entrare le orfanelle.
Ho inteso avere asilato la figlia della cosiddetta “Callararella”.
Padrona la superiora di fare ciò che voleva; ma non c’era nulla di male
nel darmene notizia, sia per poter regolare i miei discorsi e le mie
risposte alle domande di diverse persone, sia per conservare le forme di
gratitudine, almeno apparentemente, verso me che ho edificato a spese
mie l’istituto. Ma Iddio voleva darmi sempre questi piccoli
contrattempi. Ho manifestato ai miei impiegati il mio risentimento;
così, conversando loro con la superiora, glielo avrebbero fatto sapere.
Quello che si sarebbe detto era che il torto stava dalla parte mia, che
non seppi serbare concordia con la superiora Orsola e che non ho mutato
stile con la superiora Gennarina; ma il tempo mi darà ragione.
Verso la fine di aprile Baldassare Airò ha palesato il mio risentimento
alla superiora Gennarina per la mancanza di convenienza verso di me nel
riceversi le orfanelle. Ha negato tutto. Bel modo di uscirsene. Ha detto
che con me ha parlato sempre e più volte delle orfanelle candidate per
l’entrata. Ciò era vero; però nell’atto di entrare o poco prima non mi
diceva nulla, anzi, mi mandava le orfanelle dopo la loro entrata e dopo
che i loro parenti si erano un poco dispiaciuti delle mie ostinate
negazioni. Io non ricordavo nulla di tutto ciò che diceva la superiora,
forse ero divenuto imbecille per la vecchiaia.
Il 4 maggio 1901 sono venute a trovarmi le due suore Arcangelina ed
Eusebia. Abbiamo parlato delle sconvenienze usate dalla superiora
Gennarina verso di me nell’atto di accogliere le orfanelle allo
stabilimento. Abbiamo pure parlato dei fatti di Peppina Maniglia e della
mia retta condotta. La superiora ha apprezzato male i fatti. Io parlavo
con verità. Non era vero che io ho minacciato la Peppina di non
sussidiarla per farsi suora e di sussidiarla solamente per andare a
marito. Io l’ho sconsigliata a farsi suora, sia perché preferivo le
buone madri di famiglia nel mio paese, sia perché volevo essere certo di
una vocazione vera.
Il 13 giugno 1901, verso le 14,30 è venuta alla casina della Piana la
superiora Gennarina, alcune suore e quasi tutte le orfanelle. Suor
Felicita ha fatto cantare col pianoforte un coro ad meam gloriam. Prima
tre e poi altre quattro orfanelle hanno recitato e mi hanno regalato
mazzetti di fiori odorosi. Infine le orfanelle mi hanno presentato un
bel cuscino da divano di seta bianca, con un tralcio di rose e altri
fiori ricamati bene, con bei colori. Ho dovuto ringraziare tutti. Mi
erano care le orfanelle; ma gli elogi sperticati del mio oramai vecchio
corpo non mi andavano a genio e mi disturbavano.
Il 15 giugno 1901 hanno finito le fabbriche del corridoio e due camere
dell’orfanotrofio, coprendone i tetti, riadattando le canalate di zinco
e intonacando i muri esterni di calce. Rimaneva da fare un pò
d’intonacatura.
Il 17 giugno fui chiamato dalla superiora Gennarina e trovai lo scultore
Calogero Cardella34 da Girgenti. Lo incaricai di abbozzare una statuetta
dell’Immacolata per poi convenire al prezzo di una statua riprodotta in
grande da mettere nell’altare maggiore della chiesa delle bocconiste35.
La sera del 15 luglio 1901, zoppicando, sono andato a passeggio fino
all’aia. È venuta la superiora con le orfanelle. Era disturbata e piena
di dispiaceri per la ingratitudine, la superbia e la cattiva maniera di
come la trattavano le orfanelle, le quali, già cresciute, all’età di
marito, vedendo già maritate le loro compagne Assuntina Butticè e
Peppina Maniglia, erano piene di desiderio di mettersi al pari loro. Ho
fatto loro un piccolo sermone di rimprovero, con invito ad essere dolci
e grate, a mostrarsi come figlie buone e obbedienti verso la superiora,
che era la loro madre adottiva, che le curava e le amava da vera madre.
Si sono mortificate o indispettite e, partendo, non mi hanno nemmeno
salutato.
La superiora mi diceva, altresì, che la mafia era penetrata e radiata
dentro il cuore delle orfanelle. Se una faceva una mancanza non era
possibile che l’altra lo svelasse. C’era il silenzio più profondo e
rigoroso. Soffrivano qualsiasi castigo, ma in silenzio.
Il 7 settembre 1901 sono stati ripresi i lavori del corridoio e annesse
stanze dell’orfanotrofio.
Nel mese di settembre 1901, nel n. 219 del giornale Il sole del
mezzogiorno, c’era un articolo troppo laudativo per l’orfanotrofio e per
me.
Quanto suono di tromba attorno alle opere di beneficenza; nientemeno mi
mettevano alla pari col vescovo. La beneficenza doveva stare raccolta,
modesta, inosservata. I colpi di grancassa le facevano male. L’articolo
si riferiva alla festicciola celebrata nell’orfanotrofio il 31 agosto,
in occasione del compleanno del vescovo.
Nella prima metà di settembre alcuni giornali hanno pubblicato estese
corrispondenze spronandomi a prevedere la dotazione e sistemazione
dell’orfanotrofio.
In un saggio pubblicato nel n. 34 de Il Cittadino di Girgenti del 15
settembre 1901, si diceva che, versando il Boccone del povero in tristi
condizioni, come non si era trovato mai, si era costituito un comitato
per raccogliere qualche somma per le misere orfanelle. Si sollecitava
tutto il paese, per sfamare le povere orfanelle, a cooperare tutti
assieme “al benefico e generoso fondatore l’illustre barone Mendola ...”
Ecco gli zuccherini adulatori e bugiardi imbottiti di veleno. Ci voleva
proprio la penna del corrispondente Lutid (così si qualificava) per
salvare l’istituto e per ricondurre all’adempimento del proprio dovere
l’illustre benefico fondatore barone Mendola.
Io non mi sono quasi mai dati pensieri delle lodi e dei biasimi; agivo
per Dio e per doveri civili. Ma, arrivati a tal punto, non potevo
provare altro che tutto il disgusto, il dispiacere, il malessere, che la
calunnia e la menzogna poteva produrre.
Ne Il Giornale di Sicilia, n. 257, 13-14 settembre 1901, in una
corrispondenza di Favara si parlava e si deplorava la misera condizione
in cui versava il nostro orfanotrofio. Si parlava anche di un comitato
provvisorio per una passeggiata di beneficenza. Che l’orfanotrofio
andava a degradarsi era vero, non era novità. In tutto questo ci vedevo
l’intenzione di nuocermi e denigrarmi.
Tutta questa carità improvvisa mi pareva pelosa; era fatta per
denigrarmi, per mostrare che io avevo quasi abbandonato le infelici
recluse.
L’orfanotrofio non doveva cadere. Già da tempo avevo in mente di dotarlo
con testamento. Fatte le giuste riflessioni e tenuto conto dei miei
interessi, non conveniva erigerlo in ente morale. Dovevo preparare il
regolamento e provvedere alla dote di lire 6.000 all’anno; il tutto da
eseguirsi dopo la mia morte. A me, vivente, non conveniva pagare circa
20.000 lire per tassa sul valore del fabbricato della rendita. Dio
avrebbe accordato maggiore prosperità al pio istituto. Io li lasciavo
dire e fare, non mi curavo di nulla, ero avvezzo ai dispiaceri.
I componenti del comitato provvisorio erano ottime persone e miei amici.
Essi agivano in buona fede e credevano farmi un favore. Non si
accorgevano che Caramanno, cognato del Valenti, non era in buona fede.
Egli più volte in pubblico aveva manifestato l’inopportunità della mia
opera e lo spostamento delle orfanelle raccolte. Dubitavo pure di Pietro
Vasta che, se somigliava al padre, doveva essere un vaso di Pandora. La
guerra sorda e triste contro di me continuava sempre. Avversavano le
opere buone, le istituzioni utili al paese, per nuocere alla mia
persona.
Oramai in Favara mancava l’amor di patria, la religione e il culto della
scienza. Cresceva una gioventù presuntuosa e nulla.
I miei nemici, con alla testa il dr. Valenti e suoi, stavano dietro ai
vetri a guardare, imponendosi amici, usando un linguaggio non solamente
blando ma elogiativo, per sorprendere, così, le persone di buona fede.
In mezzo, agli encomi e agli aggettivi di lode apatica, essi
frammettevano sempre quei benedetti “ma”, “l’orfanotrofio è un ottimo
istituto, il migliore che abbiamo in Favara, ma le orfanelle soffrono
troppo, muoiono di fame. Sarebbe bene soccorrerle e aiutarle. Mettiamo
su un comitato di beneficenza”. Con questa trovata hanno avuto l’agio di
strombazzare ai quattro venti e nei molti giornali, a mio danno, la
sanzionante (come si diceva) notizia calunniosa e imbellettata di miele
che io, il pio fondatore, volevo imitare Saturno, che mangiava i propri
figli, cioè che io abbia abbandonato insanamente l’opera mia, la figlia
mia, condannando alla fame le orfanelle.
Subito dopo la pubblicazione di questi articoli faziosi mi sono recato
dalla superiora Gennarina. Ho letto a lei i diversi giornali diffamatori
e ho detto: “È vero che l’orfanotrofio versa attualmente in condizioni
come non si è visto mai dacché esiste? È vero che le orfanelle periscono
di fame? Ella sola conosce i veri bisogni dell’istituto. Ha ella
manifestato questi lagni a qualche componente del comitato per la
passeggiata di beneficenza? Perché non l’ha detto prima a me? Io non
farei morire di fame le orfanelle!”.
La superiora è cascata dalle nuvole. Aveva essa con sorpresa e
dispiacere letto la corrispondenza e ne aveva rilevato gli eccessi. Mi
ha assicurato non esser vero che l’istituto versasse nelle tristi
condizioni espresse dai giornali e non essere vera la fame delle
orfanelle. Bastava vederle per accorgersi del contrario; che erano sane,
belle e grasse. Ha detto che le bocconiste stavano sempre alle prese con
urgenti bisogni, che accoglievano quasi sempre orfanelle in numero
maggiore di quello previsto. Ma gli eccessi manifestati nei giornali
erano esagerati e calunniosi. L’opera del comitato era santa e cadeva
opportuna, perché l’orfanotrofio necessitava di tante cose.
Con lettera del 15 settembre, il comitato mi notificava che, da
provvisorio, si era tramutato in definitivo e mi invitava ad intervenire
e far parte di esso comitato e, per dar prova di solidarietà, ad una
solenne adunanza, che doveva avere luogo nella casa di Miccichè il 29
settembre alle ore 4 p. m. La lettera concludeva col solito frasario
massonico: “Nutriamo fiducia che la V. S. vorrà facilitare il compito
nostro, onorandoci del suo valido appoggio”.
Io ero deciso a non dare nulla del mio, per confonderlo nella raccolta
delle oblazioni che si ricavavano dalla passeggiata di beneficenza. La
parte materiale la facevo da me, versando io direttamente, come avevo
già fatto, le mie elargizioni nelle mani della superiora.
Il 19 settembre ho scritto una lettera alla superiora, per avere una
risposta scritta, da portare al comitato, per sbugiardare le calunniose
eccessive notizie apparse sui giornali, col finto e pietoso pretesto di
aiutare le orfanelle, ma col fine vero e reale di mettere in cattiva
mostra la mia condotta. Sopportavo queste contrarietà con rassegnazione
e fidavo in Dio, fonte di verità e di giustizia, che col tempo saprà
mostrare le cose e i fatti, quali effettivamente erano.
Lo stesso giorno la superiora Gennarina e suor Felicita sono venute alla
Piana, per dirmi che non si poteva dare risposta alla mia lettera, senza
prima informare il superiore generale, poiché probabilmente sarebbe
stata consegnata alla stampa. Abbiamo discusso a lungo la cosa. Ho
dimostrato la necessità della mia difesa e che avrei usato ogni mezzo,
per dimostrare la verità che doveva uscire fuori. Ho soggiunto alla
superiora che poteva far leggere l’articolo de Il Cittadino di Girgenti
e la mia lettera al Gabriele Dulcetta presidente del comitato, che
stimavo giovane buono e, se lo riteneva giusto, correggere e fare
dichiarazione nello stesso giornale per salvare il mio.
Il 21 settembre l’articolo fu scritto da un ragazzo chierico, forse il
figlio di Valenti.
Intanto ho sospeso ogni operazione con la superiora.
Il 29 settembre è arrivato il n. 36 de Il Cittadino di Girgenti del 29
settembre che, con mia soddisfazione, chiariva il senso dell’articolo
precedente. Un altro articolo più esplicito in mio favore veniva
pubblicato nello stesso giornale, nel n. 38 del 13 ottobre 1901. La
questione venne chiarita definitivamente e l’equivoco dissipato nel n.
39 del 29 settembre.
Nei primi di novembre si dovevano imbiancare ancora i muri, si doveva
mettere un’altra finestra nel corridoio, la ferrata nel gran balcone del
corridoio, i cristalli che non erano pochi, un nuovo cesso per il quarto
superiore. Si è fatto un condotto sotterraneo per versare le acque lorde
delle pile invece che in giardino, dentro un’antica cava di pietra
sotterranea, colmata di sterri, che poteva ricevere acqua, quanta se ne
voleva. Lo scolo dell’acqua nel giardino, pienissimo, ristagnava e
rendeva insalubre l’aria, molle e fangoso il suolo. La spesa è stata
forte e la superiora chiedeva cose nuove.
Il 10 novembre il carro di beneficenza ha fatto la sua prima giornata
percorrendo molta parte del paese. Era uno dei carretti comuni e forse
quello di Dulcetta. Era parato tutto come un padiglione, come una
casetta con tetto e pareti, tutta vestita, o forse composta, di
ramoscelli di alberi sempre verdi, di mirti, carrubi ed altro. Era
accompagnato da molti gentiluomini, maestri e popolo, don Gabriele
Dulcetta e altri civili, il prof. Darò, il nuovo provinciale dei frati
minori Vincenzo Bongiorno con altri religiosi, il sac. Pirrera, mastro
Michele Lentini di Antonio “Cenzu russu”, un tenente delle truppe:
insomma la rappresentanza di tutti i ceti.
Con zelo il comitato promuoveva, chiedeva e quasi estorceva il dono,
l’obolo per le povere orfanelle. Era la prima volta che, in una colletta
di beneficenza, tutti i ceti erano rappresentati. Mi ha recato sorpresa
e piacere l’intervento dei frati minori. Essi, mendicanti come le
bocconiste, solevano contendersi la pubblica carità ed in questo
esercizio si erano sempre guardati in cagnesco.
Verso le 4 p. m. i componenti e agenti del comitato di beneficenza sono
saliti in casa mia per salutare e ringraziare il fondatore e benefattore
dell’orfanotrofio. Mi hanno detto tante belle parole. Dulcetta mi diceva
che la colletta era venuta meno alle loro aspettative e non era
corrispondente alle forze del nostro paese. Si erano raccolte circa 700
lire e diverso genere di roba. La banda musicale accompagnava il carro,
rendendo più pomposo e festevole il cammino e aiutandone lo scopo. Dio
rendeva mercede al Dulcetta ed agli altri cooperatori di tanta buona
opera.
Un migliaio di lire in quel momento era una vera manna dal cielo per le
orfanelle, per una una comunità di più di 60 persone.
Molti del popolo lodavano la pia opera; molti altri borbottavano e si
lagnavano. Alcuni hanno chiuso gli usci, si sono tappati e nascosti in
casa al passare del carro. Molte porte furono fortemente percosse e
fatte aprire a forza. Alcuni, a ragione, non hanno condiviso questo modo
d’agire ed io ero d’accordo con loro. La carità deve essere spontanea o
almeno non violentata. La carità estorta si denatura, non è più carità,
ma atto amaro e odioso per chi viene costretto a farla.
Il 17 novembre la superiora mi ha detto che, in solo denaro, erano state
raccolte 1.119 lire circa.
Il 24 novembre, alle 3 p. m. sono andato all’orfanotrofio in carrozza,
per l’invito datomi dalla superiora, al fine di assistere ad un
trattenimento che le orfanelle offrivano al pubblico di Favara e,
segnatamente, a coloro che si erano affaccendati per la buona riuscita
della passeggiata di beneficenza. Il trattenimento fu grazioso ed ha
destato meraviglia nel vedere la pazienza straordinaria delle bambine.
Un tenente pianista, molto avanti nella musica, ha lodato il fare delle
fanciulle, che cantavano intonate, senza saper musica e senza studio di
carte. La gente era poca, pochi preti, gli ufficiali e pochi civili. Dei
Dulcetta c’era solo Gabriele e poi una ciurmaglia di ragazzi.
Il 19 dicembre si è realizzata la muratura della latrina del piano
superiore dell’orfanotrofio. Oltre al cesso ho visto che i muratori
hanno accomodato il fumaiolo girevole sulla canna fumaria della cucina,
che rappresentava un gatto intagliato in grezza latta.
Il 10 febbraio 1902 le orfanelle, mentre andavano a passeggio all’Itria,
mi hanno avvistato, mi sono corse incontro e mi hanno augurato il buon
Carnevale, ringraziandomi del pranzo che avevo fatto apparecchiare loro
per Carnevale.
Quando meno me lo aspettavo, il 19 marzo 1902, le orfanelle sono venute
in casa mia, con la superiora Gennarina con altre suore, compreso le due
novelle: Colomba e Felicita. Suor Felicita ha suonato discretamente il
pianoforte. Tutti gli anni, dacché fu aperto l’orfanotrofio, ho avuto il
costume d’invitare le orfanelle nei miei balconi per godersi la festa di
S. Giuseppe ed ho loro apparecchiato qualche refezione in dolci, frutta
secca, vino o rosolio.
Nel 1901 la superiora Gennarina non accolse l’invito e fece fallire per
la prima volta la lunga consuetudine.
Nel 1902 non mi è convenuto rifare l’invito. Spontaneamente è venuta la
superiora con le orfanelle; ma non potei offrire nulla a loro perché la
loro venuta era inaspettata, ma anche perché dopo il fatto del 1901, non
mi pareva opportuno mostrarmi troppo caldo e cortese.
Le orfanelle sono ritornate il 29 marzo con la superiora ed altre suore
ad augurarmi la buona Pasqua.
Il giorno 7 settembre 1902 le orfanelle sono venute con le suore alla
Piana, per invitarmi ad assistere, all’indomani, alla messa cantata, per
commemorare il decimo anniversario dell’apertura al pubblico servigio
del mio orfanotrofio. Molte mi dicevano: “Sono già 9 anni che io ci vivo
dentro e mi pare ieri”.
Nel 1898 non si festeggiò per nulla l’apertura. La superiora Gennarina
era a Sciacca ed io seriamente ammalato.
Nel 1899 mandai un piccolo pranzo alle orfanelle. Avrei dovuto darne un
altro nel 1902 come decennale ricordo; ma la mia malattia mi ha
distratto dal pensarci.
Ogni anno la memoria, il ricordo dell’apertura dell’orfanotrofio si
affievoliva. Io ringraziavo Iddio che mi aveva fatto vedere e compire il
primo decennio di caritatevole esercizio delle orfanelle.
Il 2 maggio 1903 Il presidente dell’Assise di Girgenti, il regio
procuratore, il cancelliere, giurati, etc, venuti in Favara per un
sopralluogo sul luogo dove avvenne l’assassinio di Calogero Sorce, per
la causa di Diego Vitello, alle 5 p. m. sono venuti a visitare
l’orfanotrofio e la biblioteca. Mi hanno colmato di lodi e di buone
parole. Dai forestieri riscutevo conforto, dai paesani oltraggi.
Raccontai i principali aneddoti che sembravano incredibili: l’affare
dell’osservatorio meteorologico, dell’asilo infantile, dell’ospedale e
dicevo al presidente, in faccia all’avv. Vullo, cognato del sindaco ed
al Carbone suo adepto: “Contradditemi se potete. Io parlo perché ci
siete voi, altrimenti tacerei, temendo di non essere creduto, tanto sono
inverosimili e barbari gli aneddoti”.
Alle 4 del mattino del venerdì 8 maggio 1903 è spirata suor Felicita.
Era la prima volta che una suora bocconista moriva nell’orfanotrofio di
Favara. Nella comunità è stato un lutto, un pianto sincero, vivissimo.
Suor Felicita era una perla; insegnava nelle scuole elementari alle
orfanelle secondo i programmi didattici governativi, insegnava ricamo di
ogni maniera, in biancheria, in applicazione pittoresca, in lana, in
seta, in oro. Insegnava musica e canto ed era valente suonatrice.
Insegnava la rappresentazione e recitazione teatrale, era dotata di
molta saggezza e perspicacia e bene sapeva consigliare ed aiutare la
superiora. Il popolo sentiva anch’esso il lutto e il dispiacere come lo
sentivo io.
Suor Felicita ha lasciato un gran vuoto nell’orfanotrofio. Si sono
preparate le pompe funebri per esaltare tanta virtù prematuramente
spenta. Pare fosse stata assalita da meningite.
Mancava la neve. La neve mancò altresì per i poveri fratturati delle
miniere. La Campana del popolo se ne dolse. Il sindaco fece orecchio da
mercante e lasciò gli ammalati di un paese di 20 e più mila abitanti
senza questo necessario mezzo di cura. Se la neve era pronta forse suor
Felicita si sarebbe salvata. Sono venute due carrozze con le sorelle e
con le cantatrici di Girgenti per celebrare la messa in musica di
requiem.
Alle 3,30 sono scese in piazza poche persone a due gruppi, nel primo 6
orfanelle vestite di angiolette, portavano una grande corona mortuaria.
A breve intervallo seguirono le altre orfanelle in abito dimesso, di
giornata, come manifestazione di lutto e di dolore e piangenti ed indi
la cassa mortuaria. Tutto era mesto, modestissimo, come si addiceva a
poverissimi, senza banda, senza carro mortuario. Alle 4 si mossero dalla
piazza i gonfaloni del circolo cattolico della Fratellanza, della
Maestranza, della Lega di Difesa e Camera del Lavoro per accompagnare il
feretro, che ebbe concesso dal municipio il carro mortuario di 1 classe
e banda musicale in gran tenuta.
Sei orfanelle angiolelle con ali e veli variopinti e ingramagliati di
nero scortavano il carro. Altre grandi corone mortuarie erano
vicinissime al carro. Un vero colpo d’occhio, un miracolo di carità e di
buon esempio.
Ci fu un gran concorso di popolo dalla madrice al cimitero. Erano
passati poco prima i francescani terziari e i frati minori con la croce.
Pure il gonfalone della Cassa Rurale e le figlie di Maria. Il sindaco e
il paese resero veramente grandi onoranze a questa vergine morta a 32
anni, fior di vita religiosa e civile. Il sac. Antonio Giudice ne
commemorò la vita e le virtù nella chiesa delle bocconiste. Il municipio
ha accordato il posto nel cimitero monumentale (di Piana Traversa).
Alle 4,30 è passato il corteo imponentissimo, con immenso popolo, che si
avviava nel luogo di riposo che non ha fine. Un’orda immensa di popolo
commosso e piangente in omaggio alle virtù della povera caduta avanti
tempo. Per rendere più solenne il fatto, dalla madrice i nove gonfaloni
scesero per la strada Albergamo - S. Onofrio, traversarono la piazza,
risalirono la madrice e per la strada detta nuova o V. Emanuele,
processionalmente, marciarono per il camposanto vecchio. Precedeva un
gruppo di orfanelle con grandi corone mortuarie. Seguivano le altre
orfanelle, poi le figlie di Maria con donna Gesuela Giudice in gonne
celesti, poi i francescani.
Quanto tributo di affetto reso ad una povera monachella! Onorava chi lo
rendeva e colei che lo riceveva.
La prima suora del boccone del povero che moriva in Favara era nata in
Palermo. Orfanella a 6 anni d’entrambi i genitori, entrò nelle
bocconiste, si professò e si spense santamente lavorando in Favara a 32
anni. Marrone regalò 125 lire per la carrozza di gran gala. Il sindaco
150 lire per la banda musicale, oltre alle spese per entrata nel
camposanto. Don Angelo Avenia era pronto a pagare le tasse del
camposanto, se il sindaco non avesse accordato franchigia. Mastro
Giacomo La Russa ed altri mi hanno detto che c’è stato vero lutto, vera
commozione, vero pianto nel popolo.
L’orologiaro Onofrio Tuttolomondo lesse il discorso sulla salma
dell’umile suora appena deposta sul suolo del cimitero, al cospetto di
un’orda immensa di popolo piangente. Non credevo che questa pietosa
cerimonia dovesse essere così solenne, così commovente.
Nel corteo vidi anche il dr. Antonio Valenti e figlio.
Il 19 luglio 1903 le orfanelle sono venute a trovarmi in villa Piana.
Non essendo io al casino mi hanno seguito fino all’aia. La loro
compagnia piena di vita, di brio, di spensieratezza, di cinguettio di
voci e di risate ha scosso il mio letargo malinconico. Ho inteso il
palpito esuberante della vita. Vedere quella ingenuità, quella specie
d’innocenza nelle piccoline, mi ha infuso un senso di piacevolezza, di
soddisfazione interiore e morale, che non so dipingere a parole. Queste
seconde figlie nella carità hanno confortato ed un poco esilarato la mia
depressa vecchiaia.
Io per un pò di tempo non sono andato più a vedere le orfanelle. Non
sapevo più quello che facevano.
Eravamo al 7 settembre 1903, vigilia dell’undicesimo anniversario
dell’apertura al pubblico servizio del mio orfanotrofio ed io
ringraziavo Iddio, che mi aveva fatto godere del mio orfanotrofio,
introducendomi nel secondo decennio.
La sera del 9 settembre ho visitato le orfanelle. Non si sono presentate
tutte. Fu una visita formale, fredda. Non parlavamo. Non sapevo che
dire. Le nuove orfanelle, circa un quarto, non le conoscevo neppure. Le
cose sono mutate, da quando mi sono dovuto allontanare da esse.
Il 17 novembre mi hanno visitato le orfanelle (non tutte, circa la metà)
in villa Piana, accompagnate dalla superiora.
La sera del 31 ottobre 1903 si è posto fine ai lavori di riattazione e
riparazione dei muri a secco o bastioni nella terra di S. Francesco.
Il 30 dicembre 1903, alle ore 3,30, sono venute le orfanelle a
visitarmi. Non erano tutte, ma circa la metà e tre suore. La superiora,
timorosa di cadere ammalata, non è venuta. Mi hanno dato buoni auguri.
Ma che buoni auguri, nello stato di malattia e di vecchiaia dov’ero! Io
aspettavo solamente la morte. Tutto mi era di peso. Guardavo tutto con
indifferenza. Vedevo fermato il mio tempo, non avevo più scopi, né
ragione di vivere più oltre.
Il 7 maggio 1904 sono venuti Giacomo La Russa e Bellavia detto “Fedele”
con una fanciullona seminuda e mezza macilenta, detta Gaetana Sanfilippo
del fu Gaetano, orfanella abbandonata, scalza, nuda e cruda, che viveva
alla ventura.
In vista di questa creatura molti benevoli si erano cooperati a
raccogliere il corredo, anzi più, circa 500 lire per entrare nel mio
orfanotrofio. Volevano il mio assenso. Ho detto: “Non uno, ma ve ne do
mille. Da parte mia sempre approvo e vi lodo della pia cooperazione a
favore di una creatura così disgraziata. Però non dipende da me. Il
pubblico non lo crede, ma io dico la verità”.
Giacomo La Russa mi ha detto: “Siamo già andati dalla superiora
Gennarina, la quale ha accettato la nostra domanda ed ha promesso che
l’orfanella Sanfilippo prenderà parte, appena sarà uscita un’altra
orfana, in vista di maritarsi fra breve”.
Ma cosa potevo fare? Ho detto che pochi anni prima, in un caso identico,
dovetti ripetere la stessa canzone a Ciccio Spadaro.
Il 2 giugno 1904, giorno del Corpus Domini, ho visitato le orfanelle. Ho
trovato novità. L’antico parlatoio è stato trasportato nella casa di
rimpetto a sinistra di chi entra, destinata a portineria e la stanza
grande da lavoro è stata montata a bella stanza da ricevere insieme
all’antico dormitoio. L’infermeria è stata rimessa dov’era stata
destinata da principio, con quattro letti in ferro, con pulizia ed una
certa eleganza. Ho portato alla superiora il libro con la mia biografia
da cavaliere del lavoro. Tutte le orfanelle stavano bene. Faceva piacere
a vederle.
Il 13 giugno 1904 le orfanelle, dopo che anni addietro avevo mostrato
dispiacere per le lodi del mio compleanno e onomastico, non si sono
fatte vedere. Tutto era silenzio e indifferenza attorno a me.
Il 26 luglio 1904 è venuta in casa mia Carmela Cordaro che già era stata
mia serva, con la figlia sua Checchina Airò Farulla, sortita il giorno
prima dall’Orfanotrofio. La ragazza voleva farsi ad ogni costo suora
bocconista, non voleva uscire dall’orfanotrofio. La madre voleva
maritarla. Io avevo già prescelto lo sposo, un bravo giovane detto
“Santagatuzzo”, calzolaio.
Ho detto a Checchina, che si mostrava ostinata nella sua risoluzione, di
monacarsi: “Il primo tuo dovere, secondo i comandi di Dio è ubbidire e
onorare il padre e la madre. La tua madre ti vuole in casa e tu per ora
devi seguirla. Non si può affermare come vera la tua vocazione
religiosa. Sei troppo giovane, esci da un ambiente speciale,
monachizzato e monachizzante. Mettiti un poco nel mondo, nella famiglia,
prova gli stati differenti. Se è vera vocazione, se persisti, dopo
questi esperimenti non dubitare, tua madre ti farà suora ed io te lo
prometto”.
Essa ha risposto di conoscere il suo dovere verso la madre, ma che il
dovere verso Dio era ancora più rispettabile e imperioso. Ad una ragazza
in questo stato come mettere accanto la suocera?
Il 29 luglio la Checchina ha voluto rientrare in convento. Pareva ormai
decisa la sua monacazione.
L’8 settembre 1904 ricadeva un giorno per me memorabile; si compivano 12
anni da quando era stato aperto il mio orfanotrofio e due anni da quando
è mancato ai viventi mio fratello.
Un misto di piacevoli e spiacevoli ricordi. Io, più passava il tempo e
più divenivo meno sensibile. Il tempo mi afferrava per i capelli e mi
trascinava con una velocità vertiginosa verso la fine della vita. Mi
sentivo quasi separato dal mondo; perdevo la sensibilità, scemavano le
speranze, le reminiscenze; vedevo quasi confusi il passato e il
presente. Non frequentavo più come prima l’orfanotrofio. Il mio cuore,
per questo materiale allontanamento, non ricavava più quei diletti, quei
conforti di prima. Ero assai vecchio, tutto mi infastidiva, ero sordo e,
quando parlavo e non intendevo, mi pareva che tutti, anche le orfanelle
si burlassero di me. La superiora Gennarina con le sue trascuranze e
sconvenienze di forme sociali, ha contribuito pure a questo penoso
distacco tra me e le orfanelle. Molte di esse, oramai erano grandette e
bellocce ed a me conveniva, attesa la infame maldicenza dei favaresi,
tirarmi indietro.
Le orfanelle con la superiora sono venute a trovarmi alla Piana verso le
5,30 del 22 dicembre 1904 ad augurarmi il buon Natale e Capodanno. Mi
hanno insistentemente invitato, come gli altri anni, alla festa che esse
facevano la sera in casa e la notte in chiesa per la notte di Natale.
Ho ripetuto a loro che era ben difficile, per non dire impossibile, che
io potessi accettare il loro invito.
Il 20 gennaio 1905 quattro ragazze sono state imputate di aver guardato,
dalle finestre dei balconi del quarto superiore dove abitavano, la
faccia di certi monachelli nel vicino convento dei frati minori. Le
mamme di Sajeva. Lombardo, Maniglia ieri sera dopo le minacce e le
invettive della superiora Gennarina, che aveva fatto il giro completo
delle case e poi era venuta da me, andarono all’orfanotrofio per
riprendere le proprie figlie.
Ci fu una scena straziante. Piangevano assieme alle loro compagne. Un
pianto generale, una commozione generale, resa più sensibile dal sesso e
dell’età quasi infantile. Finalmente, anche dopo il pianto delle stesse
suore, la superiora perdonò le ree. Esse, prostrate ai piedi di lei,
abbattute per un giorno di digiuno e di dolore facevano pietà. La
superiora alzò le mani e sospese le misure severe. Più sentivo queste
cose e più censuravo la superiora; perché questo rimbombo per una
piccola cosa? Il vero chiasso, il vero scandalo l’ha fatto lei.
L’1 marzo 1905 la superiora Gennarina è venuta a darmi la buona novella
che il padre generale ha mandato una bella statua di gesso alta m. 1,70
dell’Immacolata fatta a Milano, che è costata 250 lire benché in gesso,
ed un servizio di candelabri da chiesa di legno rivestito di una patina
di rame, fabbricato a Malta.
Il 23 marzo 1905 p. Bongiorno mi ha scritto una raccomandazione per
un’orfanella sua parente. Con vergogna e dispiacere ho dovuto dirgli che
non dipendeva da me asilarla nell’orfanotrofio. La superiora era
gelosissima della prerogativa di scegliere le orfanelle. Il mio nome, la
mia raccomandazione sarebbe stata d’ostacolo.
L’1 aprile 1905, verso le 4, dopo pranzo, studenti e professori sono
venuti a visitare prima la biblioteca e poi l’orfanotrofio e le
orfanelle che più non riconoscevo. Le piccine si erano fatte grandicelle
e si erano trasformate, cosicché non mi riusciva facile ravvisarle. Le
nuove asilate non le conoscevo affatto. Carmelina e Tina Lombardo, del
fu Giovanni, si erano fatte due belle ragazze ed erano così vive e
frementi di giovinezza e di voluttà, che faceva paura vederle rinchiuse
in un orfanotrofio come usignoli in gabbia.
Ho visto la nuova statua di gesso dipinta, venuta da Milano e mi è
piaciuta. Ci trovavo solo il collo un poco lungo. Ho visto i nuovi
candelieri modellati, con ornamenti di bello effetto. Ho visto pure una
bella pala d’altare sopra un fondo di seta e foglia bianca ad unico
pezzo, ricamata a fiori a colore, col calice in mezzo e la simbolica
spiga di frumento e grappolo di uva in oro. L’ostia sovrapposta al
calice in argento e due angeli in adorazione.
Il 2 luglio la superiora mi ha detto che erano state consacrate a Dio,
nella pia Congregazione dei bocconisti: Chiarina Butticè (suor
Battistina), Peppina Maniglia del fu falegname mastro Peppino (suor
Lina), Giovannina Lo Brutto (suor Angelina), Maddalena Torricelli (suor
Marianna).
Il 13 agosto 1905 ho avuto un momento di dispiacere.
Da anni avevo fatto piantare ai lati della chiesetta dell’orfanotrofio
due cipressi che erano già abbastanza cresciuti. Dovevano rendere più
pittoresca e più gradita la vista dell’orfanotrofio dal paese.
Le suore, barbaramente e scioccamente, li hanno denudati. Hanno lasciato
due fusti brutti con fiocchetti più brutti ancora in testa. Ignoravano
che le conifere, e segnatamente i cipressi, tagliati e potati, non
potevano più rimettere fogliame e rimanevano eternamente tosati.
Io facevo e le suore disfacevano. Ci voleva una spesa per estirpare i
tronconi già resi inutili e le radici e ripiantare nuovi cipressi e quel
che era più ci voleva, poi, molto tempo a crescere.
Questi fatti mi dispiacevano, mi scoraggiavano dal fare ornamenti
all’orfanotrofio. Ne ho fatto un forte risentimento alla superiora
Gennarina, la quale si è scusata dicendo che il danno era stato fatto da
un villano all’insaputa delle suore, che volle entrare in quella specie
di giardinetto con le rose per zapparlo e credette di fare opera buona
nel rimondare gli alberi; ma io non credevo alla superiora.
Il 23 dicembre 1905, verso le 3 p. m., mi sono ritirato dalla villa
Piana a casa in Favara perché minacciato dalla gotta al ginocchio.
Appena in casa, sono venute le orfanelle, la superiora ed altre suore
per darmi le felicitazioni per il Natale e Capodanno. Erano tutte
allegre, vispe, gioconde, come incoscienti del loro stato. La giovinezza
e la salute usciva loro da tutti i pori. Una vita rigogliosa e di buon
umore, un contrapposto troppo amaro con la mia cadente età, alla
vecchiezza troppo avanzata. Le ho ringraziate ed ho ricambiato le
felicitazioni. Ho detto: “Godete voi che siete stelle nascenti. Io sono
un astro tramontato”.
Il 26 dicembre 1905 mi riferirono che la lesione del muro di oriente
rispondente nel sesto acuto della finestra dell’ordine bastardo e
discendente sino alla sottostante porticina, che dalla chiesa immetteva
nel corridoio per dove le orfanelle frequentavano la chiesa, andava
lentamente allargandosi. Il pericolo imminente non esisteva, ma poteva
venire nel futuro. Il male veniva dalle fondazioni, in questo punto
poggiate sopra molle e cattivo terreno. C’era poi da far cadere una
piccola cornice cadente nell’arco centrale, che divideva la chiesa
dall’abside o cappellone.
L’orfanotrofio mi dava da fare e da spendere, era un tarlo continuo.
Le suore erano pretenziose. C’era ancora da rinnovare e restaurare gran
parte della facciata dell’orfanotrofio ed asilo, segnatamente nelle
iscrizioni in pietra e negli emblemi o simboli del sole di carità e di
giustizia. Erano in pietra o gesso fissati con ferri. La ruggine aveva
fiaccato i materiali e li aveva sgretolati. Da decenni ho avuto il
pensiero di questo lavoro ma un pò per una cosa, un pò per un’altra,
sono stato impedito dal farli.
Un altro gravissimo pericolo minacciava il tetto della chiesa. Le grandi
travi che io, con forte dispendio, secondo il consiglio di mastro
Antonio Lentini, avevo fatto tagliare dai boschi sull’Etna e con immense
difficoltà ho fatto trasportare in Favara, non so per quale cagione sono
tutte infradicite. Il colore di cui erano dipinte all’esterno nascondeva
il vizio e il danno interno.
Il 10 gennaio 1906, verso le 3 con mia figlia, che era in Favara,
abbiamo visitato la superiora e le orfanelle. Ho tenuto ragionamento con
la superiora delle voci, che correvano intorno al comitato pro Calabria,
che con lire 1.500 voleva asilare tre orfanelle calabresi vittime del
terremoto. Secondo il mio parere non conveniva accettarle. Per il solo
corredo bisognavano circa 400 lire, con le altre 1.000 lire non si
poteva compensare la retta di un biennio.
C’era nel paese una corrente favorevole alle piccole calabresi. Il
Comune non aveva mai favorito l’orfanotrofio e i signori ricchi di
Favara avevano fatto ben poco e viveva soprattutto delle sole
sovvenzioni mie e di mia sorella e del poco che raccoglieva nel popolo.
Il sindaco Giglia, che era la negazione del bene, è venuto il 23 gennaio
1906, per parlarmi delle orfanelle calabresi, che il comitato pro
Calabria voleva asilare nel nostro orfanotrofio, offrendo un vantaggio
per le povere calabresi e per le bocconiste (quale?).
Me ne sono tosto spicciato, dicendo: “Non ho nulla da fare con le
bocconiste. Non vado più nell’orfanotrofio. Ci entro appena due volte
l’anno. Ella conferisca con la superiora. Ciò che essa farà sarà ben
fatto da parte mia. Se ne è andato mogio mogio”.
Credeva forse che io avrei dovuto accogliere entusiasticamente la sua
proposta e ringraziarlo. La mia inaspettata freddezza e indifferenza
forse lo ha colpito.
Nei primi di febbraio 1906, nello scrivere il mio testamento ho dovuto
vedere le grandi difficoltà, che mi si paravano davanti, per dotare di
una rendita l’orfanotrofio. Anni addietro avevo dato l’incarico all’avv.
Ciccio Bennardo per portare avanti le procedure; ma, dopo due anni, non
aveva fatto ancora nulla. Io mi scoraggiai. Le tasse e le spese erano
enormi; io volevo risparmiarmele e volevo risparmiarle successivamente
anche a mia figlia. Ho chiesto a Ciccio Scaduto di fare uno studio
preventivo sulla questione, con la promessa di 200 lire in premio, oltre
le spese documentarie. Egli aveva accettato, ma senza il pagamento delle
200 lire. Fare gratis il lavoro non potevo permetterlo.
La sera del 31 maggio 1906 sono andato nell’orfanotrofio per visitare p.
Mammana, da poco venuto in Favara, ma non l’ho trovato. Le orfanelle mi
hanno fatto molta festa; ma io dovevo tenermi riservato. Mi hanno
invitato a visitarle spesso e intervenire giorno 13 nell’orfanotrofio
per la festicciola del mio onomastico. Mi sono negato. Ho detto,
scherzando, che il mio santo non voleva. Prontamente, a coro, hanno
risposto: “Che vanità! Noi vogliamo semplicemente mostrarle la nostra
gratitudine, il nostro affetto”. Io ho replicato: “Il santo non vuole.
Ci vede vanità da parte mia, non da parte vostra. L’affetto e la
gratitudine devono stare nel cuore ed io, per crederci, non ho bisogno
di festicciole”.
Il 12 giugno 1906, alle 2,30, quando meno me lo aspettavo, le orfanelle
sono venute alla Piana con la superiora e le suore. Mi hanno offerto un
quadro ricamato. Hanno suonato un inno di felicitazioni sul mio
pianoforte della Piana. Hanno recitato poche poesie. Io soffrivo nel
sentire queste lodi vanitose, ma dovevo subirle.
L’orfanotrofio andava benissimo. Le orfanelle da 42 erano salite a 52.
Dopo attento esame, dopo aver consultato valenti avvocati, ho disposto
tutto col mio testamento.
Mi sono messo d’accordo con mia figlia per la costituzione in Ente
Morale della Pia Opera Barone Mendola dopo la nostra morte. Ho assegnato
6 mila lire annue e un fondo di accrescimento perenne intangibile di 10
mila lire e lire 500 di frutti da impiegarsi e reimpiegarsi tutti gli
anni, con un accrescimento ogni 16 o 17 anni di un patrimonio ordinario
di lire 500 annue. Ogni volta che le lire 500, fondo intangibile,
piglieranno altre 500 lire annue, esse 500 lire si distaccheranno, per
così dire, dalla madre ed andranno ad impinguare la rendita attiva della
pia opera.
Il 21 ottobre 1906 le orfanelle, passando per una loro passeggiata
davanti il portone della Piana ed avendomi visto mentre scendevo dalla
stradella della carretteria, scortato dalla superiora Gennarina, della
di lei sorella e da altre suore, sono venute a vedermi.
Io non capivo perché non provavo più per queste povere orfanelle quelle
dolci emozioni di prima. Ci siamo allontanati e distaccati. Non
conoscevo più nessuna delle piccine delle nuove ricoverate. La superiora
non mi diceva nulla su chi usciva ed entrava nell’orfanotrofio.
A poco a poco sono diventato un perfetto estraneo. Come sono mutati i
tempi! Anche la vecchiezza mi ha fatto più pigro e meno sensibile. La
superiora però era sempre insistente a chiedermi la soddisfazione dei
bisogni dell’orfanotrofio. Voleva riacconciati i tetti, voleva riparato
un muro nel grande dormitorio di sopra dicendo di essere spaccato in
modo da entrarci il sole e via via altre cose.
L’orfanotrofio, ossia le orfanelle, non erano più fisse nel mio cuore
come lo erano nel primo decennio. Colpa delle suore. In generale, i
preti, a cominciare dai vescovi, e le monache, da un certo tempo,
figuravano male nella mia testa: i fatti di suor Orsola, la condotta del
p. generale Mammana e poi del p. Boscarino, gli scandali di padre
Fleres, le imprecazioni, i duelli o cattivi sospetti contro la mia
persona, nutriti e significati da suor Gennarina e della fu suor
Felicita a proposito della sortita di Peppina Maniglia sorella di
Tanuzza; la condotta fredda e il trattamento sconveniente della stessa
Gennarina nel ricevere e licenziare le orfanelle mi hanno reso scettico,
diffidente e quasi ombroso verso l’esercito nero maschile e femminile
della chiesa.
Il 26 ottobre 1906 Calogero Caramazza figlio di Giuseppe Garibaldi il
vecchio, ha alzato il ponte sui campanili dell’orfanotrofio per assodare
e rendere saldi i pinnacoli di legno foderati di piombo, che si sono
staccati alla base.
Questi pinnacoli furono messi al loro posto da Carmelo Airò, ma non ha
saputo rinsaldarli bene, non ha saputo valutare la forza dei venti e
delle bufere, tanto che la muratura dove il pinnacolo si manteneva sul
culmine del campanile era guasta, quasi distrutta e perciò il pinnacolo
barcollava e ondeggiava. Un’asta di ferro attraversava i pinnacoli, in
tutta la sua lunghezza, per renderli più saldi; scendeva per la cima del
campanile giù verso l’interno, attraversava la voltina del campanile
dov’erano collocate le campane e s’impernava al centro di una croce di
ferro, che s’innestava nel telaio quadrato, che circondava appunto la
testa dei campanili.
C’erano difficoltà gravissime a perforare le volte dei campanili, ad
estrarre l’asta verticale e dislocarla dalla crociera. Questi campanili
mi davano molto filo da torcere.
È venuto Vincenzo Amico e mi ha detto che, avendo esaminato con più
attenzione e accuratezza le cose, ha trovato che le aste di ferro, ossia
armature, erano abbastanza conservate bene e solide, erano solamente
frantumate le pietre di Ciccione, che formavano il culmine dei campanili
e le basi dei pinnacoli. La pietra di Ciccione era fragilissima; bisogna
supplirla col calcare compatto. Si doveva avere cura d’impeciare il
ferro e rivestirlo di una placca di piombo e indi murarle in gesso e
pietra compatta. Anche le basi delle palle ai quattro angoli erano di
pietra di Ciccione. È stato collocato e messo a punto il primo pinnacolo
sul campanile a destra di chi guardava la facciata della chiesa, bene
impeciato e rivestito poi di lamina di piombo e ben murato in gesso e
pietra calcarea.
Il 31 ottobre, dopo pranzo è stato finito il primo campanile. Il 7
novembre si è messa l’ultima palla, con pericolo dei manovali, nel primo
campanile. Si è acconciato il secondo e si è collocato pure il
pinnacolo. Si poterono terminare i campanili e disfare i ponti la sera
del 9 novembre. Il 19 novembre mastro Calogero Caramazza di Giuseppe
Garibaldi il vecchio, con due manovali innalzò il ponte da terra sino
all’orologio della torre campanile dell’orfanotrofio, per aggiustare il
quadrante, abbassatosi da un pezzo, e quindi disadatto a funzionare.
All’indomani ci sono saliti Vincenzo Amico e Onofrio Tuttolomondo ed
hanno eseguito diverse riparazioni.
Il 30 novembre 1906 si è finito di piazzare il quadrante dell’orologio
nel campanile della chiesa dell’orfanotrofio. A sera ho saputo che, per
una distrazione di Onofrio Tuttolomondo, che dimenticò una piastra da
fare a casa, non si è potuto finire di piazzare il quadrante.
La sera del 23 dicembre 1906 è venuta a visitarmi la superiora Gennarina
Durante con suor Catalda. Con le orfanelle non passava più l’antica
confidenza e cordialità; non c’era più lo scambio di affetti innocenti e
soavi. Nella mia melanconia, nella mia desolazione interna del cuore,
sino a qualche anno prima trovavo conforto nel rivedere le orfanelle,
nel conversare con loro, nell’adattarmi alla loro infantile ingenuità e
semplicità e mi pioveva un balsamo dolce a sanare le piaghe e le
afflizioni morali. Quel filo che ci teneva avvinti, si è spezzato; si è
dissipata quell’attrazione di flusso magnetico che avvicinava il ferro
alla calamita.
Il 22 marzo 1907 ho fatto ripiantare due cipressi ai due lati della
chiesa dell’orfanotrofio e il 26 novembre nuovamente.
Il 14 aprile 1907 ho mandato i muratori Calogero Caramazza Bertinello e
Calogero Alletti Sajeva sul tetto del dormitorio superiore delle
orfanelle, per indagare sulle cause che hanno reso bagnato e ammuffito
l’intero muro di mezzogiorno. Ho mandato pure altri mastri. Ciascuno
doveva fare la sua relazione o diagnosi della malattia del fabbricato,
separatamente l’uno dall’altro.
Il 19 maggio 1907 non ho potuto penetrare nei mezzi tetti, cioè tra il
tetto e la volta per esaminare da vicino i guasti e il perché l’acqua
piovana invece di andare fuori, penetrava e moriva dentro i muri, perché
Carmelo Airò non ha lasciato nella fabbricazione, una porticina, un buco
qualunque per entrare sotto i tetti. Ho deciso di farne aprire una
apposta.
Nel pomeriggio del 24 dicembre 1907 sono venute a casa mia le orfanelle
del boccone del povero con la superiora e molte suore per farmi le buone
feste. Delle grandicelle, che io conoscevo per averle viste crescere e
quasi allevate, ne ho viste assai poche; quasi tutte erano piccine e
novelle.
Io da circa tre anni non ho frequentavo più l’orfanotrofio. Ho dovuto
distaccarmene per una specie di trascuranza in cui la superiora mi ha
tenuto, oltre che per non dare neppure un lontano pretesto alla
maldicenza, che era smisuratamente cresciuta.
Non avendo più l’antica familiarità e dimestichezza con le orfanelle,
non sentivo più quelle dolci emozioni che provavo prima, quando le
vedevo spessissimo scherzare intorno a me, come tante mie seconde
figliolette. I tempi sono mutati. L’età, la debolezza delle mente mi
hanno distratto dall’orfanotrofio. Sono rimasti integri i rapporti
d’interesse e di tutela nei confronti delle orfanelle, ma quasi estinti
quelli dei reciproci affetti. Il cuore mi si è inaridito. Non ho
raccolto più il balsamo soave della carità. Le orfanelle non mi hanno
più fatto l’effetto di figlie, ma di estranee.
Come gli altri anni, le suore hanno celebrato la notte di Natale con le
orfanelle, vegliando, giocando, ridendo e poi passando in chiesa a fare
la solita nascita con le solite statue di carne, con otto orfanelle che
questa volta scelsero fra le grandicelle come più resistenti, vestite da
angiolette, che offrivano vari doni al nuovo nato di Betlemme. Il cielo
era sereno sebbene c’era un poco freddo. La luna, poco prima della
mezzanotte, splendeva argenteamente chiara. Ci fu gran concorso di
popolo.
Quando pensavo al passato mi veniva da piangere. Morto il figlio, morta
la collezione ampelografica, rubatimi tutti i materiali scientifici da
quel briccone di Peppino Caruso; inutilizzato e quasi perduto il
Popularis sapientiae Loculus; reso per me quasi arido ed estraneo
l’orfanotrofio. Solo, desolato, oltraggiato ingratamente con la stampa
da persone, cui ho piuttosto fatto del bene, tra dolori morali e
melanconie.
Nel Natale 1907 non ho avvertivo nulla, nessun ricordo, nessuna
reminiscenza delle cose di Natale di quando io ero bambino. Ero preso da
una perfetta apatia. Vegetavo e non pensavo.
A sera mi assaliva una profonda melanconia. Mi vedevo solissimo, vecchio
e cadente tra quattro muri. Tutto era silenzio irreale per difetto del
mio udito quasi perduto. Tutti gioivano, tutti godevano. I bambini non
mancavano nelle famiglie e ne formavano la delizia. Le bettole erano
piene. Vino e capponi, carte da gioco e dolci mettevano un tripudio
eccezionale. Io solo gemevo nell’isolamento, con una gramaglia nera che
mi levava la luce, mi impediva ogni gioia e mi prostrava l’anima e il
corpo.
Scrivevo senza sapere ciò che scrivevo.
La notte di Natale 1907, con l’anima distrutta e in silenzio, ho
mangiato una forchettata di broccolo lesso ed una piccola linguata in
umido e poi sono andato a letto contristato.
Ho letto al solito e poi ho preso sonno, ma da infermo, voltandomi e
rivoltandomi tra le lenzuola, sempre con la mente piena di sogni strani
e penosi. Mi sono più volte risvegliato. Nonostante la mia sordità ho
inteso voci e rumori di passi affrettati e cinguettii di bambini per la
piazza e per le strade. Un continuo chiamarsi e richiamarsi, una
festevolezza insolita, una vita vibrante di gioia. Nella notte silente
tutti gioivano: io solo piangevo e mi addoloravo.
Nel silenzio pensavo a mio padre, mia madre, mio fratello Andrea, mio
figlio, i miei più cari amici che non c’erano più, che ormai popolavano
il regno dei morti e pareva mi dicessero col loro mutismo: “Fra poco ci
raggiungerai”.