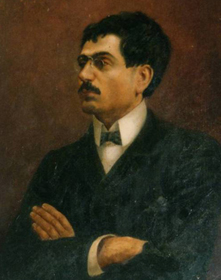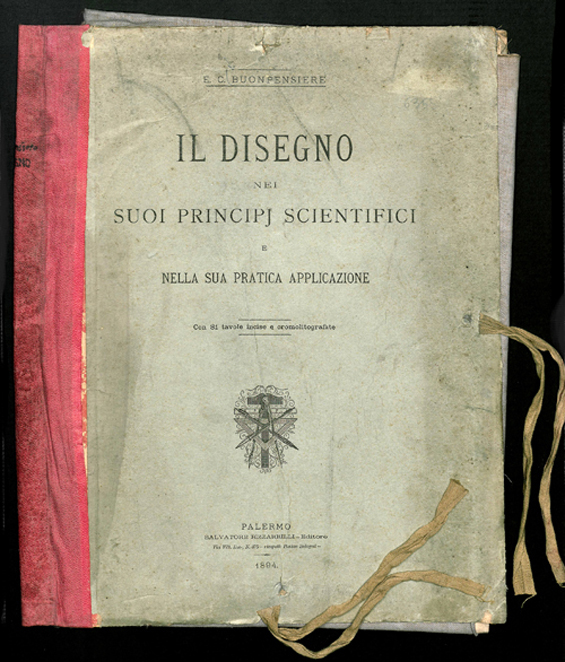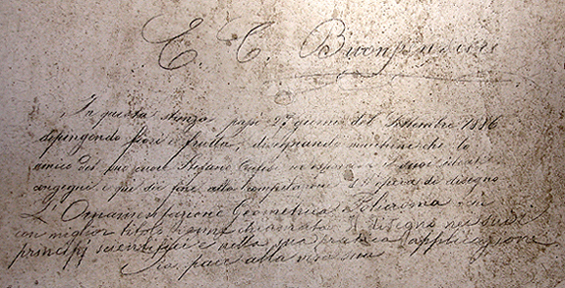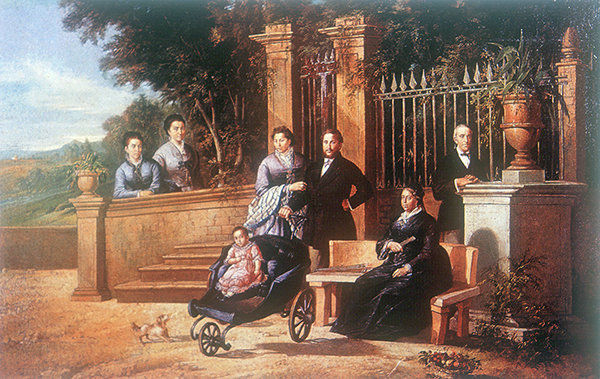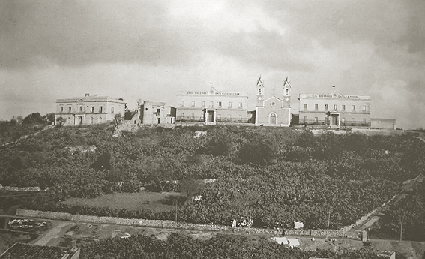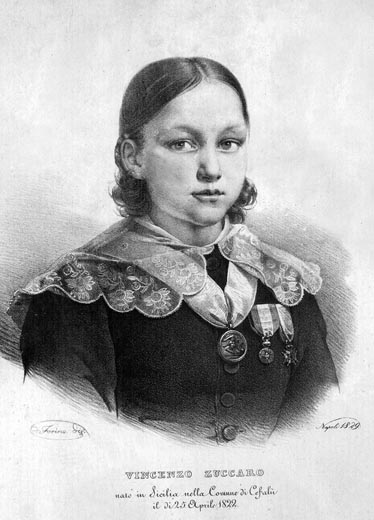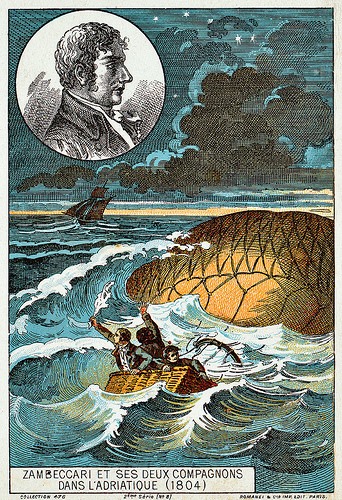|
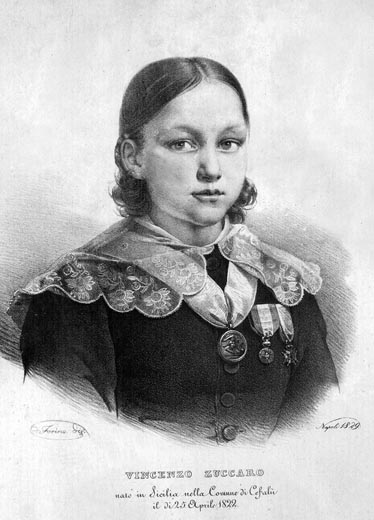  |
29 -
Vincenzo Zuccaro: un piccolo genio
(da Piero Meli e Sandro Varzi)
Di questo prodigioso
ragazzino di nome
Vincenzo Zuccaro,
palermitano, figlio di
Benedetto Zuccaro maestro della banda musicale Favarese per più di 15 anni
scrisse un breve appunto il barone Antonio Mendola nei suoi
diari. Vincenzo Zuccaro
nacque a Cefalù il 25 aprile del 1822 da Benedetto e da Lucia de Luca,
originari di Caccamo, ma ambedue provenienti da Palermo. Appena nato, fu
immediatamente portato in cattedrale dalla signora Paola Maggiore,
levatrice, e subito battezzato, perché in grave pericolo di vita. Il
padre, professore di flauto e direttore d’orchestra, per guadagnarsi da
vivere, vagava da Comune a Comune, portandosi con se il fanciullo (che
grazie a Dio sopravvisse) e gli strumenti musicali e iniziando a dargli
le basi musicali, giacché doveva egli sicuramente intraprendere per il
futuro la medesima professione del padre che, non poteva permettersi di
avviarlo agli studi delle belle lettere. Vincenzo, laddove il padre si
fermava per qualche giorno a suonare o a dare lezioni di musica, era
sempre pensoso e taciturno e se ne stava spesso rannicchiato in un
angolo della stanza dove il padre esercitava la sua professione. Ora
accadde che suo padre, chiamato da un gruppo di giovani a dirigere una
banda musicale, dovette stare sei mesi lontano da casa. Al suo ritorno
trovò il piccolo Vincenzo di molto dimagrito e ne chiese il motivo alla
moglie la quale rispose che il fanciullo da qualche mese stava sempre
sveglio, non riusciva a chiuder occhio la notte e calcolava
continuamente tra se e se borbottando numeri: cento, dodici cento, venti
trecento....ed inoltre aveva già imparato a contare sino al centinaio
giocando con le noccioline. Il padre sorrise e chiese scherzando al
fanciullo che cosa avesse da contare e che cosa ne potesse sapere lui di
conti. Vincenzo rispose prontamente che faceva il conto di quanti tarì
aveva guadagnato il padre l’anno prima, di quanti ne aveva mandati a
casa in quei mesi, quanti ne spendeva la madre tutti i giorni e a quanto
sommavano per mese e per anno. Contava poi quante stelle ci fossero in
cielo, quanti portoni, balconi e quante finestre ci fossero a Cefalù. Il
padre lo credeva impazzito ma non si perse d’animo e facendosi coraggio,
così per prova, gli chiese: “47 più 38 quanto fanno?” e prontamente il
fanciullo rispose “85”; “e chi ti ha insegnato a sommare?” replicò il
padre; “Nessuno” rispose Vincenzo;e il padre “dimmi 5 per 9?”; “45”
rispose Vincenzo. “Ma chi ti ha insegnato la tavola pitagorica?” chiese
il padre, ma il fanciullo non sapeva che cosa fosse detta tavola e la
madre affermava che non fosse venuto nessuno a casa. Intanto il padre
continuò a porgere a Vincenzo altre domande più difficili, avendo da lui
sempre risposte pronte, sicure e velocissime. Sbigottito, dopo aver
fatto tutti i riscontri con carta e penna, concluse che le risposte
erano tutte esatte. Nel frattempo si confidò con alcuni amici i quali
vollero rendersi conto delle meraviglie di Vincenzo e rimasti anche loro
sbalorditi, consigliarono don Benedetto di far conoscere il fanciullo ad
alcuni nobili e dotti cefalutani o ancor meglio di portarlo nella città
di Termini Imerese, che a dir loro era città più dotta. Passarono alcuni
mesi e tra la gente locale e del circondario incominciavano a circolare
notizie sui prodigi del piccolo Vincenzo, “ Nato e cresciuto nella
miseria, nell’ignoranza, deve la sua scienza alla natura che volle
formarne un prodigio, fanciullo di statura conforme all’età,
fisionomia graziosa, occhi e fronte indicanti riflessione profonda, voce
di suono maturo, il quale senza sapere ne leggere e ne scrivere, con la
sola forza del suo intelletto, eseguisce a memoria i calcoli numerici di
qualunque specie con maggiore facilità e speditezza di quanto si possa
attendere dal più esercitato calcolatore e con tale esattezza che
sorprende, ciò che Zuccaro fa da se stesso, non lo fanno gli uomini di
nessuna età e di nessuna dottrina, come se madre natura avesse rotto le
sue leggi”. Nel 1829, il padre ripensando a ciò che ebbe detto
dagli amici, un giorno presa una carrozza da Cefalù, portò il piccolo
Vincenzo a Termini Imerese. Appena arrivati in quella cittadina, la
gente, come se sapesse del suo arrivo, si riversò nelle strade
accompagnandolo con giubilo al Palazzo di Città. Qui accolti dalle
autorità cittadine, Vincenzo fu invitato a dare una pubblica prova del
suo talento, lo invitarono a farsi fare un ritratto e lo decorarono con
la medaglia del loro Liceo. In quell’occasione si trovava a Termini, per
affari personali, il marchese Giuseppe De Spuches, anima generosa e
grande mecenate, che rimase colpito da quel fanciullo, tanto che in
seguito, nel corso di quello stesso anno, lo condusse a Palermo
prendendolo sotto la sua protezione e aiutandolo negli studi. Egli che
assunse l’impegno di presentarlo al capo del governo, non volendo
rischiare un tale passo prima di essere sicuro del merito del fanciullo,
lo condusse, dal distintissimo matematico prof. Nicolò Cacciatore al
quale, Vincenzo all’età di circa sette anni diede un pubblico saggio di
calcolo mentale. Questo avvenimento fece parlare di sé i giornali
scientifici e letterari più accreditati d’Italia e d’Europa, “Vincenzo
Zuccaro fanciullo prodigio di Cefalù, volle dare in questa capitale un
nuovo saggio del suo prodigioso talento di calcolare a memoria. Egli
tenne perciò nei giorni trascorsi pubblica accademia in una delle grandi
sale del Palazzo Calabritto. Scelta e numerosa udienza di personaggi
distinti, di scienziati e di cultori d’ogni specie di letteratura v’era
concorsa per ammirare uno spettacolo ben poche volte o non mai da altri
veduto finora. Il programma delle materie, intorno alle quali poteva
essere interrogato il fanciullo, girava di mano in mano agli spettatori
e non vi fu un solo che leggendolo non avesse rivolto gli sguardi sul
piccolo Zuccaro, come per assicurarsi se la cosa fosse possibile. Ma il
dubbio durò ben poco. Alla prima domanda che al ragazzetto si fece:
Estraetemi la radice cubica del numero 43.816, ed alla sua pronta
risposta: 35 con il resto di 941, al dubbio seguì la sorpresa ed alla
sorpresa la meraviglia allorché si andò man mano notando con quale
rapidità e sicurezza egli risolvesse tutti i difficili problemi a lui
posti. Dopo tali fatti che potremmo noi aggiungere in lode di questo
favorito dalla natura? Diremo solo che ai professori nella scienza del
calcolo esercitatissimi il tempo mancava per risolvere con la penna quei
problemi ch’egli scioglieva senza altro soccorso che della sua memoria”.
L’eco dell’accademia pubblica palermitana fu vastissima. Ne
parlarono i più autorevoli giornali scientifici e letterari d’oltre
faro. Perfino il “The London literary gazette” pubblicò una
corrispondenza da Napoli dal titolo “Calculating Boy”. Oltre alla città
di Termini Imerese il cui Decurionato riunitosi di proposito il 6
dicembre del 1829 aveva deliberato di proteggere, per quanto poteva, il
fanciullo prodigio, anche la municipalità di Palermo volle contribuire
al mantenimento e alla cura dello Zuccaro e concesse al De Spuches, che
sin dall’inizio ebbe cura del fanciullo, una pensione affinché potesse
farlo bene istruire. Vincenzo da quel momento ebbe chiarissimi
protettori che tanto influirono per assicurargli una convenevole
educazione e agevolare e proteggere le sue naturali virtù. Tra questi il
Duca di Gualtieri, presidente del Consiglio dei Ministri. E proprio
all’interessamento personale di questi si deve che nel corso del 1831
dal Governo di re Ferdinando, che ormai con impazienza desiderava
conoscere direttamente e personalmente gli avanzamenti fatti negli
studi, e i particolari progressi nella scienza del calcolo, fu impiegata
la somma di 1500 ducati annui per la sua ulteriore istruzione. “ Che
un ingegno così promettente non debba essere seguito e coltivato, è cosa
irragionevole, bisogna dare lode al Governo delle Due Sicilie che
addossandosi la cura del fanciullo Zucchero, gli dà una nobile
educazione, di cui la povertà domestica lo avrebbe per necessità
lasciato privo ”. Vincenzo Zuccaro, fanciullo prodigio superò
brillantemente i problemi a lui sottoposti dai più grandi luminari di
quel tempo, come il siciliano prof. Diego Muzio ed esimi matematici come
i professori Bata, Fuoco e Casano conosciuti a livello europeo, i quali
ebbero a dire di trovarsi di fronte ad un emulo di Archimede e Newton.
La meraviglia suscitata dal nostro Zuccaro, non rimase circoscritta
solamente in Sicilia e la presenza di numerosi e curiosi stranieri a
Palermo portarono la fama del nostro, anche fuori i confini d’Italia.
Dalla Francia tramite il barone Sermont, Intendente Generale dell’armata
francese in Grecia, si volle da quel Governo decorare il fanciullo
prodigio con Medaglia e Croce al merito, alta onorificenza in quel
Paese. Nel 1834 veniva accordata al meraviglioso fanciullo calcolatore
Vincenzo Zuccaro, l’annua pensione di mille scudi, onde non mancargli un
decoroso mantenimento e un industrioso e diligente maestro che potesse
riuscire al veloce e completo sviluppo di quell’ingegno, che tanto
prometteva. Questo fanciullo, matematico per istinto, che non sapeva né
leggere né scrivere, ora per le cure dell’Abate Minardi, destinatogli
come istitutore, comprese e spiegò gli autori italiani e latini,
prosatori e poeti, dandone pubblica prova. Le notizie sul suo conto si
fermano all’anno 1837 quando negli Annali universali di statistica,
pubblicati in Milano, in quell’anno, così si legge “ In ordine di
tempo la Sicilia ci ha dato Vincenzo Zuccaro, il quale fecesi ammirare a
Napoli e a Palermo, ed ora altro siciliano di cognome Pugliesi gira l’italia
riscuotendo applausi per il suo improvvisar di calcoli in età
fanciullesca”. Da questo momento cala un buio totale sul destino
del piccolo Vincenzo Zuccaro, non avendo altre notizie sulla sua vita,
sul suo operato, nessun anche ben minimo indizio sugli anni a venire, si
presume che il fanciullo prodigio di Cefalù, sia morto prima di aver
compiuto la giovane età di 15 anni. Ma non è così. Una lettera autografa
dello Zuccaro acquistata da chi scrive in un antiquario di Lucca ci
rimette sulle sue tracce. La lettera, datata 20 maggio 1852, da Torino,
è indirizzata al ministro delle finanze del governo piemontese che
allora era Camillo Benso conte di Cavour. Scrive tra l’altro Vincenzo
Zucchero (così si firma, italianizzando il cognome): «Non avendo potuto
avere l’onore di parlare con Lei, Sig. Ministro, mi fo ardito
d’invitarla a volermi onorare di Sua presenza all’Accademia di calcoli
numerici a memoria, che io darò la Sera di Sabato 29 corr. te alle ore
8½ nella Sala del Gabinetto Chimico sita nel Collegio di S. Francesco da
Paola. Animato dall’avere il Presidente del Consiglio, Cav. D’Azeglio,
accettato filantropicamente simile mio invito, spero che anch’Ella, Sig.
Ministro, vorrà onorarmi di sua presenza». Che si tratti del prodigioso
fanciullo non c’è alcun dubbio come dimostra un avviso apparso sulla
“Gazzetta del Popolo” l’8 marzo del 1852: «Il professore di calcolo
mentale estemporaneo, cav. Vincenzo Zucchero, siciliano, che ha dato sin
dal 1829 delle accademie di calcoli numerici in tutte le principali
città d’Italia, ed altrove, dà ora qui delle lezioni di Aritmetica ed
Algebra elementare a prezzi discreti. Egli abita in contrada d’Argennes
n. 6, piano 1º, e si trova in casa dalle 9 alle 11 antim. tutti i
giorni». Come e perché fosse finito nella capitale piemontese a
guadagnarsi da vivere esibendosi in pubbliche accademie e impartendo
lezioni private è un’altra storia, un’altra avventura di questo
singolare personaggio cefaludese. A svelarlo un documento dell’archivio
di Stato di Torino, l’estratto dal ruolo matricolare degli ufficiali del
corpo volontari italiani intestato a Vincenzo Zuccaro fu Benedetto e fu
Lucia De Luca nato il 22 aprile 1822 a Cefalù. Un documento che ci
riconsegna un “altro” Zuccaro acceso patriota e garibaldino, un
combattente per l’indipendenza della Sicilia e per l’Unità nazionale.
Dopo le speranze disattese nello studio delle scienze esatte, forse
scaricato dal governo borbonico, si era arruolato nel maggio del ‘48
come volontario nei dragoni di Lombardia; il 21 ottobre però è in
Sicilia dove il Parlamento Generale lo nomina primo tenente del genio.
Ma dopo la caduta di Catania, nell’aprile del ‘49, prende la via
dell’esilio, a Londra. Qui, senza mezzi economici e senza conoscere una
sola parola di inglese, s’ingegnerà a sbarcare il lunario, sfidando al
gioco del domino, dov’era abilissimo, gli avventori nei piccoli bar
gestiti da italiani, vincendo infallibilmente la sua magra consumazione
quotidiana. Nel ‘52 è, come abbiamo detto, a Torino. Il 19 giugno del
‘59 in qualità di commissario piemontese insieme al capitano Giovanni
Pagliacci e al tenente Antonio Del Buono verrà mandato da Cesare Mazzoni
presso il governo provvisorio di Perugia, per predisporre la difesa
della città dall’assalto delle truppe pontificie. Alla fine degli
scontri del 21 giugno verrà dato per disperso. L’anno successivo invece
accorre nuovamente in Sicilia tra le file garibaldine col grado di
capitano di fanteria dell’armata dell’Italia meridionale. Modesto e
riservato, chiuderà la sua carriera nell’esercito nel distretto militare
di Bari, ignoto agli storici e ai cultori di cose di Sicilia. Nel volume
“Gli emigrati politici siciliani dal 1840 al 1860”, Alessio di
Santostefano della Cerda ricorda d’averlo visto più volte uscire in fin
di mese dall’ufficio del Direttore dei Conti stringendo “amorosamente”
nella mano la busta che conteneva il suo magro stipendio di militare:
«appariva convinto che verso lui, umile gregario, la patria ripagava il
suo debito di riconoscenza».
L’occasione
del restauro del dipinto “Ritratto di Fanciullo”, di ignoto pittore
siciliano del XIX secolo, posseduto dal barone Enrico Pirajno di
Mandralisca, di proprietà oggi della omonima Fondazione Culturale,
realizzato grazie al finanziamento del Circolo Italo-Tedesco Gaggenau e
compiuto dalla restauratrice cefaludese Dott.ssa Antonella Tumminello,
mi ha spinto ad iniziare una serie di ricerche riguardo il giovane
personaggio ritratto in questa tela, sino ad oggi rimasto sconosciuto.
Conoscendo bene tutto il patrimonio pittorico e librario appartenuto al
Mandralisca, la mia memoria mi venne in aiuto facendomi ricordare di una
litografia su carta che raffigurava un fanciullo che meritò di essere
effigiato, in ricordo ai posteri, per dei meriti particolari che non
ricordavo bene.Spulciando i vari inventari ecco trovare una litografia
corrispondente al mio ricordo
“Litografia raffigurante il
fanciullo prodigio Vincenzo Zuccaro, nato nella Comune di Cefalù, addì
22 aprile 1822”. Trovata
la litografia nei depositi, volli fare subito un confronto e il
sorprendente risultato fu quello che i due personaggi risultarono
pressoché identici nella fisionomia, differenti nella cronologia
dell’abbigliamento, che tuttavia aveva in comune la presenza di un
colletto riccamente ricamato. Il primo passo sembrava compiuto, il
personaggio ritratto non è altro che il fanciullo cefaludese Vincenzo
Zuccaro. Ma chi era costui? Che meriti ebbe per meritarsi una
litografia, un ritratto ad olio su tela? Come mai il barone Enrico ci
tenne ad avere dei ritratti, in ricordo di un personaggio a lui
contemporaneo e che di sicuro ebbe occasione di conoscere personalmente?
Conosciuto ora il suo nome e cognome iniziai delle ricerche sistematiche
anche nell’archivio della Famiglia Mandralisca e nel fondo librario
storico, nella speranza di trovare qualche cosa a me utile. Poco ci
volle e mi imbattei in una pubblicazione dal titolo
“Sopra il famoso fanciullo
Vincenzo Zuccaro, epistola di Ferdinando Malvica”,
Palermo 1829. Ecco scoperto l’arcano, finalmente fui in grado di capire
chi fosse il fanciullo, il perché di quei ritratti e l’interesse che
ebbe il Mandralisca nei suoi confronti. A voi il resto, affinché
possiate avere il piacere di scoprire chi fu Vincenzo Zuccaro,
fantastico fanciullo prodigio di Cefalù, del Regno delle due Sicilie,
d’Italia, d’Europa.
Sandro Varzi
|